El parlamento furlan e la contadinansa
viewtopic.php?f=163&t=201
Dopo tre secoli “Rinasce il Parlament Furlan”
http://www.lindipendenza.com/dopo-tre-s ... ent-furlan
di ADRIANO BIASON
Rinascerà il 3 aprile del 2014 lo storico parlamento friulano. Il 3 aprile, lo stesso giorno in cui nel1077 naque lo Stato patriarcale di Aquileia, la Patria del Friuli. Il parlamento del Friuli fu uno dei più antichi e longevi parlamenti europei, alla pari del parlamento inglese per fare un paragone. Iniziò la sua attività nel 1231 e fu chiuso, ad opera di Napoleone Bonaparte, nel 1805.
Ora dopo tre secoli viene ricostituito sotto forma di associazione culturale. I suoi obiettivi saranno quello di cercare vie legali, democratiche e pacifiche per poter ottenere l’indipendenza del Friuli dallo Stato italiano e quello di cercare soluzioni per aiutare il popolo friulano ad affrontare la perdurante crisi italiana. Caratteristiche di questa associazione sono quella di non avere alcun orientamento politico ma bensì di ospitare tutte le possibili parti in discussioni costruttive e produttive. Inoltre ha la caratteristica di essere un progetto partecipato.
Infatti tutti i friulani possono contribuire alla scrittura dello statuto iscrivendosi al relativo gruppo Facebook e tutti potranno partecipare alla costituente dell’associazione divenendo fondatori del parlamento stesso. Inoltre l’associazione assumerà un profilo internazionale, infatti prevede anche il coinvolgimento di quei comuni della Slovenia occidentale che storicamente appartenevano al Friuli cercando quindi ad esempio di riunificare la città di Gorizia con la gemella Nova Goriza. Insomma, una volta costituita l’associazione, tutti i cittadini friulani che aderiranno potranno candidarsi su base territoriale e farsi eleggere a rappresentare i propri elettori nel Parlament Furlan. E così finalmente dopo tre secoli il Friuli riavrà il suo parlamento.
El parlamento furlan e la contadinansa
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
El parlamento furlan e la contadinansa
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38318
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
Re: El parlamento furlan
El Parlamento del Friul o Furlania
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_del_Friuli
Era un istituto di tipo romano-germanico (???), le sue origini risalgono agli incontri fra i nobili ed il patriarca che si cominciarono a tenere già dal XII secolo. La data di inizio ufficiale dell'attività del parlamento si fa risalire al 1231, data della prima delibera; il parlamento continuò a riunirsi (anche se privato di quasi tutti i suoi poteri) anche dopo l'invasione veneta (???), avvenuta nel 1420. Il parlamento si riunì per l'ultima volta nel 1805, fu infatti ufficialmente sciolto da Napoleone Bonaparte. Questo ne fa uno dei parlamenti più antichi e longevi di tutta Europa.
Il parlamento era solito riunirsi a Udine e Cividale del Friuli oppure a Campoformido (luogo in cui veniva fatta la rassegna dell'esercito dello stato patriarcale), si tennero diverse riunioni anche ad Aquileia, San Daniele del Friuli, Gemona, Sacile ed altri svariati luoghi del Friuli. Dopo l'occupazione veneta le riunioni si tennero solo nel castello di Udine.
I compiti del parlamento erano vari: la difesa della Patriarcato (ogni rappresentante era tenuto a corrispondere un preciso numero di uomini ed armi in caso di necessità), la tassazione, la politica estera, l'emanazione di leggi (raccolte dal patriarca Marquardo di Randeck nelle Constitutiones Patriae Foriiulii), l'amministrazione della giustizia e la pubblica amministrazione erano i più importanti.
L'organo esecutivo del parlamento era il Consiglio.
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Friuli
1381-1420 - È il periodo della decadenza del ducato patriarcale , principalmente causata da uno spirito di fazione, odio e vendetta tra i comuni friulani, in particolare tra quelli di Udine e Cividale, lite in cui vengono coinvolti altri stati italiani ed esteri. Con Cividale si schierano gran parte dei comuni friulani, i carraresi, Padova ed il Re d'Ungheria; Udine appoggia invece Venezia. Nel 1411 il Friuli divenne campo di battaglia fra l'esercito imperiale (schierato con Cividale) e quello veneziano (schierato con Udine). Nel dicembre di quello stesso anno l'esercito dell'imperatore si impadronisce di Udine; il 12 luglio 1412 nel Duomo di Cividale viene investito dei suoi poteri temporali il patriarca Ludovico di Teck (questa fu l'ultima cerimonia del Sacro Romano Impero in Friuli). Il 13 luglio 1419 i Veneziani occupano però Cividale e si preparano alla conquista di Udine;
1420 - Il 7 giugno 1420, dopo una strenua difesa, l'esercito veneziano entra nella città di Udine; subito dopo cadono Gemona, San Daniele, Venzone, Tolmezzo; è la fine del potere secolare del patriarca;
1445 - Dopo lunghe trattative il patriarca Ludovico Trevisan accetta il concordato imposto da Venezia . Da qui in avanti il Friuli seguirà le vicende della Serenissima Repubblica Veneta.
http://it.wikipedia.org/wiki/Parlamento_del_Friuli
Era un istituto di tipo romano-germanico (???), le sue origini risalgono agli incontri fra i nobili ed il patriarca che si cominciarono a tenere già dal XII secolo. La data di inizio ufficiale dell'attività del parlamento si fa risalire al 1231, data della prima delibera; il parlamento continuò a riunirsi (anche se privato di quasi tutti i suoi poteri) anche dopo l'invasione veneta (???), avvenuta nel 1420. Il parlamento si riunì per l'ultima volta nel 1805, fu infatti ufficialmente sciolto da Napoleone Bonaparte. Questo ne fa uno dei parlamenti più antichi e longevi di tutta Europa.
Il parlamento era solito riunirsi a Udine e Cividale del Friuli oppure a Campoformido (luogo in cui veniva fatta la rassegna dell'esercito dello stato patriarcale), si tennero diverse riunioni anche ad Aquileia, San Daniele del Friuli, Gemona, Sacile ed altri svariati luoghi del Friuli. Dopo l'occupazione veneta le riunioni si tennero solo nel castello di Udine.
I compiti del parlamento erano vari: la difesa della Patriarcato (ogni rappresentante era tenuto a corrispondere un preciso numero di uomini ed armi in caso di necessità), la tassazione, la politica estera, l'emanazione di leggi (raccolte dal patriarca Marquardo di Randeck nelle Constitutiones Patriae Foriiulii), l'amministrazione della giustizia e la pubblica amministrazione erano i più importanti.
L'organo esecutivo del parlamento era il Consiglio.
https://it.wikipedia.org/wiki/Storia_del_Friuli
1381-1420 - È il periodo della decadenza del ducato patriarcale , principalmente causata da uno spirito di fazione, odio e vendetta tra i comuni friulani, in particolare tra quelli di Udine e Cividale, lite in cui vengono coinvolti altri stati italiani ed esteri. Con Cividale si schierano gran parte dei comuni friulani, i carraresi, Padova ed il Re d'Ungheria; Udine appoggia invece Venezia. Nel 1411 il Friuli divenne campo di battaglia fra l'esercito imperiale (schierato con Cividale) e quello veneziano (schierato con Udine). Nel dicembre di quello stesso anno l'esercito dell'imperatore si impadronisce di Udine; il 12 luglio 1412 nel Duomo di Cividale viene investito dei suoi poteri temporali il patriarca Ludovico di Teck (questa fu l'ultima cerimonia del Sacro Romano Impero in Friuli). Il 13 luglio 1419 i Veneziani occupano però Cividale e si preparano alla conquista di Udine;
1420 - Il 7 giugno 1420, dopo una strenua difesa, l'esercito veneziano entra nella città di Udine; subito dopo cadono Gemona, San Daniele, Venzone, Tolmezzo; è la fine del potere secolare del patriarca;
1445 - Dopo lunghe trattative il patriarca Ludovico Trevisan accetta il concordato imposto da Venezia . Da qui in avanti il Friuli seguirà le vicende della Serenissima Repubblica Veneta.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38318
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
Re: El parlamento furlan

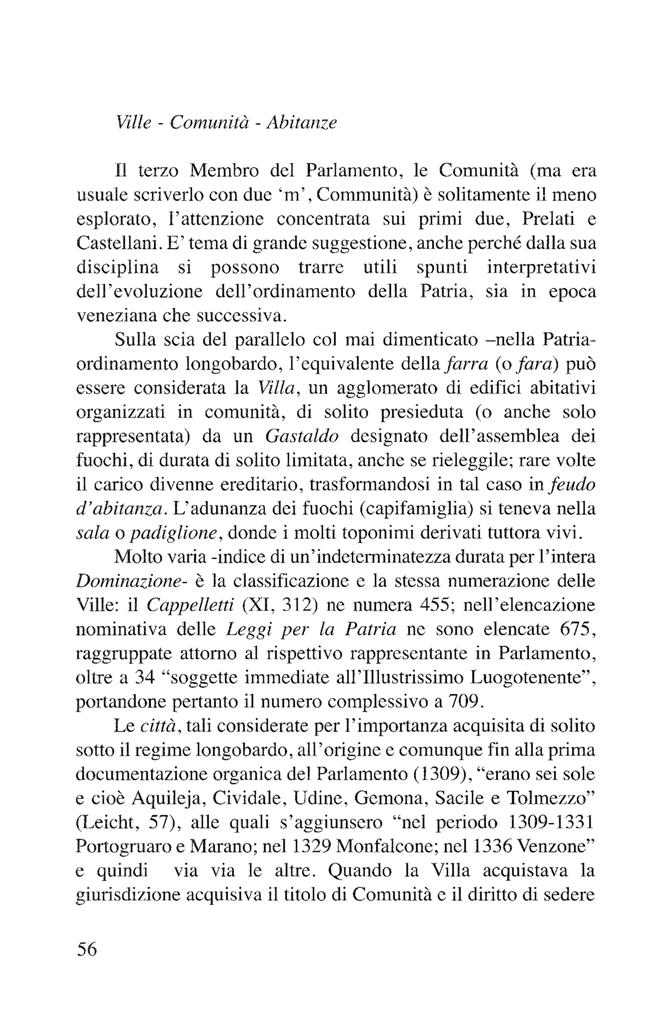
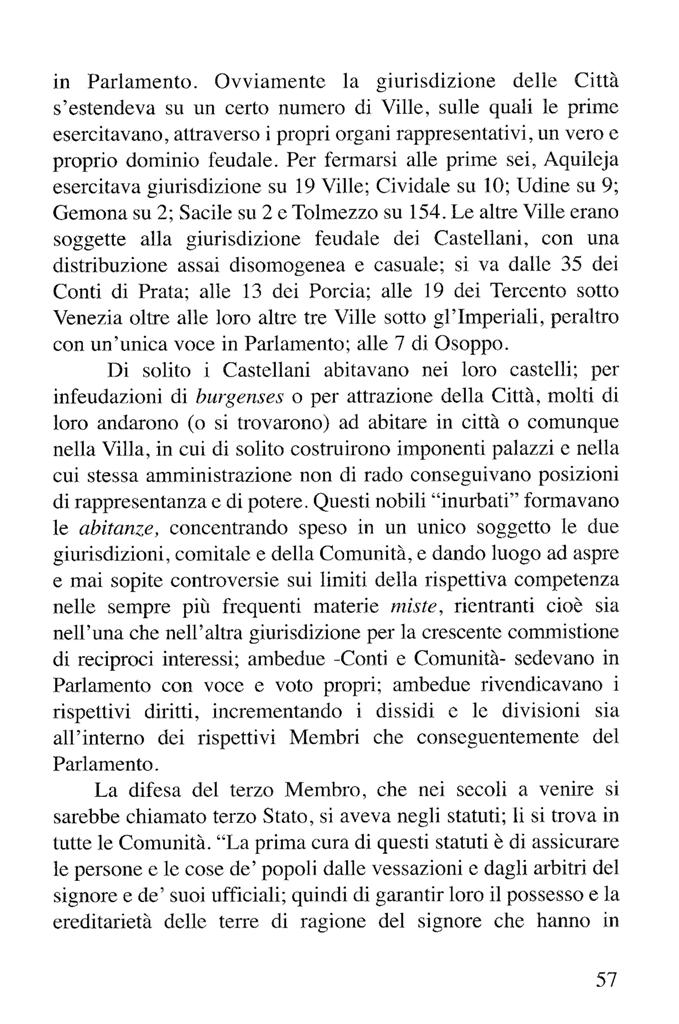
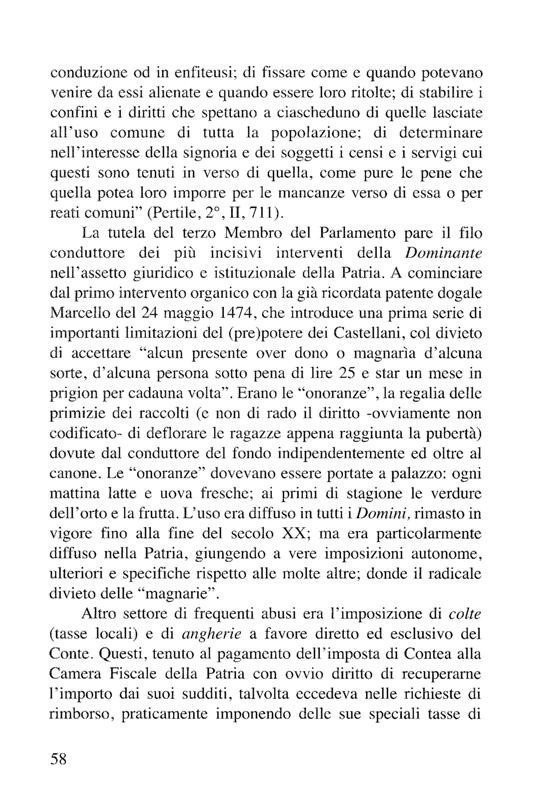
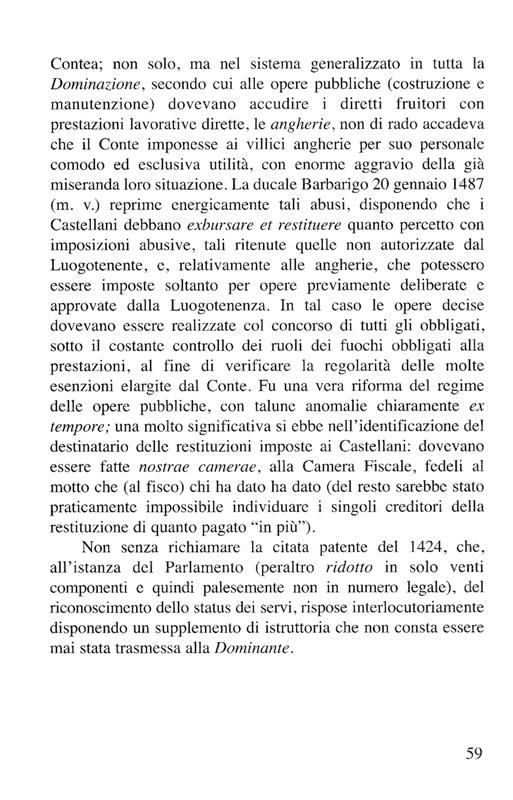
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38318
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
Re: El parlamento furlan
Friul/Friuli, Priula, Friola, Feriole, Feriolo, Ferriol, Frejus
https://docs.google.com/file/d/0B_VoBnR ... JoWWc/edit

http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... =163&t=819
San Marco en vanti de esar el Santo Patrono de Venesia el jera el Santo Patrono de la Akileja Patriarcal anca ente li secoli longobardi.
http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... p=411#p411
Marco (etimoloja)
on santo cristian de łi veneti de mar ma anca de coełi de tera
https://docs.google.com/file/d/0B_VoBnR ... ZQVUU/edit

Gravo, Grado, Grau/Grao (etimoloja e storia)
https://docs.google.com/file/d/0B_VoBnR ... ZPak0/edit

https://docs.google.com/file/d/0B_VoBnR ... JoWWc/edit

http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... =163&t=819
San Marco en vanti de esar el Santo Patrono de Venesia el jera el Santo Patrono de la Akileja Patriarcal anca ente li secoli longobardi.
http://www.filarveneto.eu/forum/viewtop ... p=411#p411
Marco (etimoloja)
on santo cristian de łi veneti de mar ma anca de coełi de tera
https://docs.google.com/file/d/0B_VoBnR ... ZQVUU/edit

Gravo, Grado, Grau/Grao (etimoloja e storia)
https://docs.google.com/file/d/0B_VoBnR ... ZPak0/edit

Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38318
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
Re: El parlamento furlan
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38318
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
Re: El parlamento furlan
Storia del Friul
scrito da (on soçałista o comonista?)

https://www.filarveneto.eu/wp-content/u ... -Friul.jpg
L'inverno del patriarcato
Ormai l'inverno del patriarcato era alle porte.
Secondo ogni legge fisica e storica una pressione costante su di un oggetto, alla lunga finisce con l'indebolirne la struttura.
Se poi le forze interne che regolano la forma materiale dell'oggetto cominciano ad incrinarsi, ogni speranza è perduta. Venezia che spinge da un lato ha raggiunto il punto in cui una zona cuscinetto fra il suo territorio e quello dell'impero è assolutamente e categoricamente necessaria. Alle stesse conclusioni giunge l'impero, e allora si mettono in moto con ogni mezzo per raggiungere l'oggetto tanto desiderato. Nel mezzo, il patriarcato d'Aquileia, la Patria del Friuli, non ha più in sé le condizioni per esistere, può solo sperare di durare. Fallito il tentativo, le «Constitutiones Patriae Foriiulii» che l'abilità di Marquado di Randek, 1'11 giugno 1366, riuscirà a promulgare, non sono altro che un monumento funebre che si trascinerà fino al 1420, anno dell'ingresso di Venezia nella Patria.
Lavorando per linee interne (l'asino carico d'oro di Filippo di Macedonia) Venezia raggiunge uno degli anelli della catena che tiene ancora in equilibrio, pur sotto tensione, lo stato patriarcale. L'iscrizione, nel 1385 di una delle colonne portanti del patriarcato, Federico, della famiglia Savorgnan, fra i nobili del maggior consiglio della repubblica, è la rottura dell'anello. Nel 1388 il Patriarca Giovanni di Moravia, nel tentativo di spezzare la velata signoria su Udine dei Savorgnan, portando al governo cittadino membri delle 12 arti rappresentate in città, ruppe il secondo anello: la città. Cividale e Udine si allearono in campi opposti e la diga rabberciata che teneva immote le acque feudali, a sua volta, si ruppe.
Nel tortuoso scorrere delle maree, preso il flusso, Venezia raggiunse il suo obiettivo, un relitto arenato.
Il patriarcato, come forza spirituale, resterà per qualche secolo, poi altre vicende lo trascineranno in Venezia. Elio Bartolini descrive i giorni veneziani dell'ultimo patriarca in uno splendido, ambiguo e profondo romanzo: Pontificale in San Marco. L'involucro di quella che fu una potenza materiale e spirituale, per l'aura che emanava, poteva essere ancora appetibile e così lasciò il palazzo di Udine con gli affreschi per andare in un altro palazzo con affreschi a Venezia, in un momento in cui, l'ironia della storia, vedeva un involucro di repubblica. Era venuto l'inverno dello scontento, anzi, era tornato, perché esso sempre torna.
Le ali del leone
La fede et conversation dela sua Republica consisteva solo in li villani et plebei.
(Amaseo, Diarii)
Nel 1421, nello stesso periodo in cui Venezia stringeva i fili del proprio secolare potere in Friuli, il doge Tommaso Mocenigo elencava, in una lettera — quasi un congedo — ai suoi compatrioti, in cifre, la grandezza della città. 195.000 persone si affaccendavano fra le calli e i canali, circolavano dieci milioni di ducati che fornivano un interesse annuale di quattro milioni. Solcavano i caldi mari in cui si spartiva il Mediterraneo più di 3.000 navi con 20.000 marinai, e nei piccoli laboratori artigianali 16.000 operai producevano di tutto e trasformavano le materie prime.
La guerra di Chioggia, con l'occupazione, certo momentanea ma traumatica, della cittadina lagunare da parte dei Genovesi, aveva sollecitato un ripensamento strategico complessivo.
Il relativo disinteresse per la terraferma era motivato dal fatto che frammentari poteri feudali poco potevano impressionare una grande potenza. Le cose cambiavano quando erano viste sotto l'inquietante crescere dei Visconti in Lombardia che, oltre al fatto di essere uno stato unificato, minacciava già Verona, Vicenza e Padova, tagliando inoltre le grandi vie commerciali per l'Europa.
Una cosa, forse, sfuggiva ai sottili politici di San Marco. Per essere sempre stata «fuori» dalle campagne, il fenomeno feudale aveva toccato Venezia in misura molto piccola; così i suoi rapporti con i cittadini, con gli artigiani, con gli operai, con i contadini, pur non sfuggendo a certa demagogia, erano stati più sfumati. L'aristocrazia mercantile d'altra parte, agendo in un clima estremamente favorevole - erano eliminati gli scontri frontali fra contadini, popolo e feudatari - evitò, senza neppur rendersene conto, il pericolo della Signoria, vista la grande compattezza politica dei gruppi dirigenti.
Non a caso, a lungo, il regime politico di Venezia venne visto da osservatori politici, legislatori e filosofi come una sorta di «migliore dei mondi possibili». Brian Pullan lo analizza molto bene, e cita Contarini al quale non sfugge la situazione: «Cosa veramente sopra il creder d'ogni uno, che il popolo sendo stato tanti anni privo del governo publico, mai habbia rifiutato l'imperio de i gentil huomini...»; così il «modello» veneziano venne osservato da uomini della statura di Bodin e di Botero.
Entrando però nelle grandi e immote campagne dell'Adige e del Po, del Brenta, del Tagliamento fino all'Isonzo, la Repubblica doveva farsi carico di ensioni e lacerazioni di cui non aveva pratica diretta. Non solo, ma con il XVI secolo entriamo in un periodo, che taluni definiscono di «rifeudalizzazione», in cui assistiamo all'inizio di un'inversione di tendenza dell'economia basata sul commercio: il capitale viene immobilizzato sempre di più nell'acquisto di grandi proprietà terriere, e sempre di meno investito in quei commerci che erano stati la chiave della grande ascesa della potenza della repubblica. Nel 1454 Venezia, con la pace di Lodi, ha definitivamente chiuso il ciclo della sua espansione a onde intorno al centro. Tutto il Veneto, il Cadore e la Patria del Friuli fino ai confini della contea di Gorizia e delle Alpi Carniche, parte della Lombardia fino all'Adda, portano una nuova struttura statuale, una nuova sicurezza, le ricchezze del suolo — non ultimi, certo, gli alberi che hanno, per i Veneziani, una forma esatta per tutte le parti di una nave — e nuovi investimenti.
Inizialmente la Patria non rappresenta certo i boschi della Carnia, rappresenta solo un ulteriore allargamento dell'anello difensivo.
Nonostante tutti gli sforzi non è riuscita ad avere il pieno controllo del litorale Adriatico e del golfo di Trieste; la città si è già involata nelle mani degli Asburgo i quali, per quasi tre secoli, non l'avranno in cima ai loro pensieri.
Ma contano i passi delle Alpi, la strada del ferro e la strada del sale di cui è la massima produttrice ed esportatrice. (Cento e più anni dopo troveremo che Udine e Cividale negli appalti del sale, controllati da quella potenza che era l'ordo salis, avranno notevoli tassi di profitto: 61,53% Cividale, 31,25% Udine.)
Il collaboratore per eccellenza, Tristano Savorgnan, come un suo antenato era stato ammesso alla nobiltà veneta, per ricompensa avrà il titolo di «primario della Patria del Friuli».
Nella valutazione degli interessi basterà vedere che Venezia avrà inteso dare un privilegio «onorario» e che così, invece, non l'intenderanno i Savorgnan.
Le condizioni sociali del territorio erano desolanti. Lo strano procedere delle guerre, quell'impazienza apparente di fermarsi per poco, dare il guasto, andare e ricomparire da lì a un mese o a un anno, che ha più l'aspetto di una guerriglia continua che di una campagna, avevano ridotto commercio e lavoro dei campi ad un decadimento fortissimo. Bruciare i campi, tagliare gli alberi da frutto, le viti, portar via il bestiame erano usanze che si ripetevano ad ogni uscita di campo. E quando se ne andavano gli stranieri, erano i nobili locali in eterna bega fra di loro a condurre operazioni del genere, su scala forse più piccola, ma certamente più dannosa per la sua costanza. Vittime usuali erano i contadini e, in definitiva, l'intera vita della Patria ne usciva malferma perché il paese viveva sostanzialmente di agricoltura.
Il compito di Venezia era assai difficile e per molto tempo, vista la turbolenza del paese, gli scontri con l'impero, le scorrerie della cavalleria turca, cercò di cambiare il meno possibile.
L'unico cambiamento di fondo fu quello della direzione politica e amministrativa.
Con ogni probabilità, visto l'esiguo numero di personale a disposizione, sia per gli allargamenti territoriali, sia perché impreparata tecnicamente ad essere «impero», il piccolissimo strato burocratico locale dovette rimanere. Il personale dirigente fu sempre veneto, ogni potere reale fu sottratto al Parlamento, la Chiesa venne relegata nel ruolo che uno Stato, molto laico e poco incline allo strapotere clericale, riteneva idoneo ad un'autorità spirituale (così come avrebbe fatto molti anni dopo il friulano Paolo Sarpi, non a caso protetto dalla Repubblica). Il potere politico venne accentrato nelle mani di un rappresentante del Senato, il luogotenente, una sorta di governatore, il quale, oltre ad avere un limitato arco di tempo di governo, doveva mandare a Venezia quelle «relazioni» che saranno la base di uno studio molto accurato da parte degli storici per la gran quantità d'informazioni sociali ed economiche sul territorio preso in esame.
Il luogotenente stabilì il centro della propria attività politica nel castello sul colle di Udine.
Inoltre, vista la necessità di provvedere alle difese della terra, minacciata da imperiali e da Turchi, si dette mano alla costituzione di gruppi di contadini armati, le «cernide». A capo di questi organismi, naturalmente sollevando le proteste, le diffidenze ed i sospetti dei nobili di parte imperiale (molti dei quali speravano inutilmente in un ritorno al vecchio modo di governare, una volta pur tanto detestato), fu messo un membro della famiglia Savorgnan che non se ne lasciò mai sfuggire il controllo. In realtà l'efficienza militare delle cernide era assai limitata. Non bastava assicurare un minimo di armamento a dei gruppi di contadini: l'addestramento all'uso delle armi e la pratica di combattimento richiedeva troppo tempo. In questo contesto si assiste al lento spostarsi dell'appoggio contadino a Venezia, come controprova della disaffezione che l'uomo della gleba provava per i suoi signori.
Del resto, di tale appoggio Venezia godrà in tutto il suo territorio per secoli. Di questo fatto darà diretta e stupita testimonianza Nicolò Machiavelli nel 1509: «E tutto dì occorre che uno di loro preso si lascia ammazzare per non negare el nome viniziano. E pure iersera ne fu uno innanzi a questo Vescovo, che disse che era Marchesco, e Marchesco voleva morire, e non voleva vivere altrimenti; in tal modo che il Vescovo lo fece appiccare; né promessa di camparlo, né d'altro bene lo possé trarre di questa opinione; dimodoché, considerato tutto, è impossibile che questi re tenghino questi paesi con questi paesani vivi».
I Turcs tal Friul
Per più di due secoli le incursioni della cavalleria irregolare turca, infiltrandosi attraverso le valli della Drava e della Sava, alle spalle dell'Istria veneziana, saggiarono le difese veneziane e imperiali, imparzialmente.
Sulla spinta delle conquiste nella penisola balcanica, l'impero turco si assestò come scomodo vicino per i regni cristiani. All'interno del sistema di stato costituito, la selvaggia cavalleria irregolare dei Turcomanni finiva con l'essere di estremo disturbo. Così venne deciso dai sultani di usarla per scorrerie alle frontiere e oltre. Questo corpo irregolare, gli agingi, viste le difficoltà del Tesoro ottomano a pagare costantemente un esercito regolare, era pagato esclusivamente con il bottino che riusciva a procurarsi in qualunque condizione, in qualunque territorio oltre a quello imperiale.
Questi cavalieri, che rinnoveranno per secoli lo stesso terrore degli Ungari, si erano aggregati all'impero sotto la spinta delle tribù mongole di Genghiz khan, e avevano seguito le fortune dei sultani. Avevano un armamento leggero: archi, lance, spade, poche armi da fuoco. Abituati ad una vita dura e selvaggia, si muovevano con grande rapidità, distruggevano, bruciavano, depredavano e prendevano prigionieri....
Per farvi fronte venne costruita la gigantesca fortezza nella bassa pianura, Palmanova, la cui modernità e la cui misura saranno proporzionali all'inutilità del lavoro e al gigantesco saccheggio, questo «legale», cui si diede la Repubblica per reperire i fondi. La maggior spesa venne sostenuta, e pare naturale, dai «fedeli e boni furlani».
Un conglomerato eterogeneo
«Un conglomerato eterogeneo, tenuto insieme dalla forza coercitiva del governo centrale» (Ventura).
All'indomani dell'acquisizione del Friuli gravi contrasti di fondo avevano scosso Venezia. La tendenza a impegnarsi in terraferma, contrastata dal vecchio doge Mocenigo, aveva avuto la meglio, ma, come è stato notato, il partito vincitore non proponeva idee chiare e, soprattutto, non aveva una strategia di lunga durata. Così il gruppo dirigente si trovò impegnato nella costruzione di uno Stato che non era quello per cui la città era sorta, né quello in cui si era formata una classe dirigente aristocratica, abile nella politica mercantile, ma limitata a pensare solo in funzione cittadina.
Vennero dunque stesi i fili di un potere molto centralizzato. Nessun friulano ebbe mai in mano uno solo di quei fili. Il luogotenente rispondeva solo a Venezia. D'altra parte una politica di rotazione costante, forse utile, forse eccessivamente sospettosa, impediva a quel funzionario di avere una conoscenza approfondita del territorio che governava. Se sono di buon livello, accurate e attente le relazioni che era tenuto a inviare, con ogni probabilità ciò è dovuto agli estensori reali.
Il luogotenente generale aveva la sua sede in Udine e controllava il territorio della Patria e il Cadore. Dei Rettori, che in larga misura da lui dipendevano, reggevano dei dipartimenti che avevano un centro amministrativo a Caneva, Sacile, Pordenone, Portogruaro, Marano, Monfalcone, Cividale, Venzone e, dopo la costruzione della fortezza, Palmanova, che aveva diritto, vista la sua importanza strategica deterrente, a un Provveditore Generale della Fortezza.
Questa terra dalla struttura geologica così diversa è un mare contadino, anonimo, senza storia e senza tempo. Venezia deve trattare con questo immoto specchio d'acqua, ma non ha, ancora, nessun proponimento d'investire in bonifiche, in migliorie, in una diversa conduzione agraria.
Per il momento è interessata a non agitare troppo le acque con la nobiltà, di cui. diffida, ma di cui ritiene di non poter fare a meno pur controllando che il suo peso feudale sui contadini non sia eccessivo.
Solo quattro anni dopo il suo arrivo fa una mossa politica per trovare alleati sicuri. Il 14 aprile 1424 fa pervenire una sua Ducale in cui afferma: «Nostrae intentione fuit et est quod nobiles omnes gaudere debent sine diminutione privilegiis, concessionibus et immutatibus».
Avendo diviso il territorio della Patria in Giurisdizioni, alcune di queste continuarono per espresso desiderio di Venezia ad essere sottoposte a signoria ecclesiastica o feudale; in seguito, per necessità economiche, alcune di queste Giurisdizioni vennero messe a disposizione di chi, mercante o nobile, fosse nelle condizioni di riscattarle. Era un onore che non dava oneri alla Repubblica in quanto queste ville, dette dominicali, di per sé non erano in grado di essere rappresentate nel Parlamento della Patria dai loro signori.
Per un certo periodo di tempo, per quanto privato di reale potere politico, il Parlamento fu in grado di stabilire gli estimi per le spese militari e sanitarie. I sei deputati incaricati dell'ufficio potevano avere notevoli possibilità d'arricchire, e di far arricchire a spese d'altri, con operazioni che erano comunissime in quell'epoca come lo sono nella nostra. In seguito anche questo ufficio passò direttamente ai Veneziani (evidentemente c'era stato sentore dello zampettare di tanti topolini friulani intorno ad un formaggio friulano e si ritenne più decoroso che topolini veneziani gustassero con minori complessi il formaggio foresto).
Nel grande teatro del mondo, l'apparenza del potere ha la forma del potere e non la sua sostanza, ma resta il fatto che la forma, pur coprendo un manichino, è pur sempre visibile, rispettabile, onorabile, così questo parla-mento che si riunisce una volta all'anno nel vecchio castello del patriarca (sappiamo come doveva essere dal trecentesco sigillo del comune di Udine, visto che crollò rovinosamente nel grande terremoto del 1511) alla presenza del luogotenente, questo parlamento che parla, ma che poco conta, può almeno far scrivere, per i posteri, da un cancelliere le decisioni. Può insomma, previo cenno di capo di chi a capo è veramente, «dispensar e ordinar le gravezze e fazioni che occorrono nella Patria...».
Stanno seduti, i potenti con i poveri, i deboli, i subalterni, i contadini, undici rappresentanti della Chiesa, quarantacinque feudatari e tredici città dette Comunità: Udine, Gemona, Venzone, Tolmezzo, Sacile, Portogruaro, (i lettori del Nievo ricorderanno la sonnolenta e nebbiosa vita della gente dabbene di Portogruaro sul crinale della grande Rivoluzione: veramente il tempo gira in ozioso e silenzioso circolo), Monfalcone, di notevole interesse strategico per il suo incunearsi nelle terre dell'impero, San Daniele, Fagagna, Aviano, Caneva, Mossa, Meduna.
Capitoło: Lo slittamento dei codici: dal linguaggio del rito al linguaggio della rivolta
Man mano che l'antropologia culturale, arricchita da studi interdisciplinari, prende in esame determinati eventi storici, s'accorge di affondare sempre di più in un mare di significati complessi. Per molto tempo la rivolta contadina che sconvolse il Friuli nel 1511 è stata vista come un'anomalia. Si è pensato immediatamente a «rimuovere» pretese, definite «pretesti», su di un'interpretazione basata sul concetto di lotta di classe.
L'evento è stato staccato dal suo contesto e visto con molta perplessità. Si è pensato, dapprima, di darne un'interpretazione di lotta politica, di «parte», tenendo conto che lo scontro avveniva fra due fazioni, «zambarlani» e «strumieri», di cui la prima era favorevole a Venezia (e in qualche testo definita «guelfa») e la seconda all'impero (e perciò «ghibellina»).
In secondo luogo si è trasformato questo avvenimento in una rivolta diretta dai Savorgnan contro i loro rivali i della Torre, nobili d'origine lombarda e imperiali, per eliminarli direttamente dalla scena politica friulana. Cosa prevista, tanto che nobili amici dei della Torre non avevano mancato di avvisare i sospettosi padroni veneziani su non certo tanto ipotetici sospetti nei confronti di un Savorgnan Antonio, che poteva voler una signoria, e che perciò si sforzava «de meter insidie fra li villani e li castellani, maxime in questo caso che li castellani non vedevano l'ora de mutar stado per tornar la famoletà (servitù) in la Patria, et cazar li villani zoso de li tereni per non li pagar loro meglioramenti».
Ma, dando pur per esatte queste versioni-almeno suì fatti non c'è molto da discutere, se mai si tratta di trovare negli archivi altro materiale-l'antropologia, aiutata dalla psicologia e dalla psicanalisi e da altri strumenti, va più nel profondo e tende a far emergere vibrazioni collettive, onde lunghe generalizzate, tendenze del profondo che vengono da molto lontano nel tempo, molto inquietanti.
Prendiamo ad esempio il periodo 27, 28 febbraio e 1 marzo del 1511: si comincia con Giovedì grasso. Casuale?
Naturalmente potrebbe essere casuale, ma vi sono coincidenze che non possono non interessare e non obbligare ad una più approfondita riflessione.
Alcuni esempi: nel 1376 a Basilea ha luogo, il Martedì grasso, un massacro di tale portata da essere ricordato negli annali svizzeri come bòse Fastnacht (cattivo Carnevale); a Londra, in una festa popolare scoppia una rivolta
contadina, è il 1517, a Digione, nel 1630, scoppia una violenta rivolta di viticultori a Carnevale; sul Carnevale di Romans, del 1580, Le Roy Ladurie ha costruito un libro eccezionale, appunto intitolato Il Carnevale di Romans (Burke ricorda anche altre rivolte con massacri in giorni di festività chiave, come il Corpus Domini della Catalogna, e la Domenica delle Palme di Madrid del 1766).
Non a caso, molto acutamente, nel suo documentatissimo e monumentale libro “Tradizioni popolari in Friuli”, A. Ciceri avverte l'esistenza di questo implacabile, se pur apparentemente invisibile filo, quando ricorda che «gli eccessi più gravi che la nostra storia ricordi, sono avvenuti sempre nel "giovedì" grasso», ed ha in mente, oltre ad un altro fatto, proprio il giovedì grasso del 1511, e annota, inoltre, come i membri delle due fazioni portassero «mascheramenti di segno diverso, onde riconoscersi nella lotta».
Allora è evidente che qualcosa lega gli eventi a movimenti tellurici dell'inconscio collettivo.
Quali, e perché, e in che misura?
Il mondo alla rovescia
Gli elementi fondamentali del Carnevale sono il cibo, il sesso e la violenza. Bachtin ha dato interessanti motivazioni sulla maschera, specialmente sull'inversione dei ruoli maschio-femmina e l'interpreta come «il diritto carnevalesco di critica e derisione, che talora sfociava in rivolta vera e propria». In sostanza era un'usanza di cui l'attuale Carnevale, in epoca postindustriale, non è altro che un pretesto senza le basi sociali che ne sostengano l'ambiguità e la funzione, spesso ripetuta, di valvola sociale.
Abbiamo già ricordato l'interpretazione che vien data, alla luce di recenti indagini, della Messa dello Spadone nel giorno dell'Epifania in Cividale.
L'inversione dei ruoli e la contrapposizione dialettica ne sono le componenti: maschio-femmina (molte maschere hanno significati sessuali), dominati-dominatori («Un giorno di regno», i dominati regnano per un giorno — in epoche più antiche i dominati che regnavano per quel giorno venivano sacrificati come simbolo del limite invalicabile che si poneva fra il potere e il mondo dei poveri) il grasso-il magro (al di là di spiegazioni di normativa alimentare-etichette messe su situazioni di cui non si comprendeva il reale significato. Harris ad esempio ha svelato l'arcano della proibizione del maiale fra i popoli semiti e della mucca fra gli indù, – v'è la più elementare spiegazione di un periodo agricolo in cui s'impoveriscono le scorte, ed ecco la Quaresima).
La permissività del Carnevale può essere stata interpretata come una valvola di sfogo a tensioni a lungo represse (non è spiegabile altrimenti il vagheggiare il Carnevale che avveniva nel passato, dove tutto accadeva in funzione del prossimo Carnevale, divertirsi certo, ma che altro?).
Non a caso L. Accati indica nel Carnevale in Friuli, uno dei meccanismi in cui la Chiesa cerca di comprimere tutte le feste contadine. A questo punto il «Carnevale assomma dunque e concentra i significati delle feste, diventa il
teatro in cui si riversano i riti agrari e non cristiani via via espunti dal calendario. Il Carnevale festeggia la morte della vecchia stagione, il nascere della nuova, la fertilità e la fecondità e nel contempo ironizza sulle assurde pretese della gerarchia dominante e dei suoi membri all'eternità e all'immortalità».
A risultati del genere, per un'area diversa (ma teniamo a mente come nei secoli passati un substrato «pagano» e neolitico fosse abbastanza comune, prima cioè che le diversità nazionali e le culture delle classi dirigenti si stendessero in maniera abbastanza impermeabile sull'inconscio contadino) sono arrivati la Zemon-Davis, Camporesi, Hill.
Hill, ad esempio, ritiene che queste feste d'apparente follia fossero «una valvola di sicurezza: le tensioni sociali si allentavano grazie a questo periodico “bouleversement” e forse l'ordinamento sociale ne risulta un po' più tollerabile».
È dopo, molto dopo, certo non nella nostra situazione (ecco perché il timore di un'interpretazione «rivoluzionaria» del giovedì grasso 1511 è privo di fondamenti) che sorge una domanda, e cioè se questo «mondo alla rovescia» non avesse, per caso, una possibilità politica di essere realizzato.
Carnevale in Friuli era chiamato “Inseri”, parola di cui non si sa con certezza l'etimologia (Ciceri); il Pirona (Vocabolario della lingua friulana) dice che «indicherebbe l'ultimo giorno di carnevale». Infatti c'è un proverbio della metà del '500 che suona in questo modo: «Lu prin dì d'inseri è San Pas [da pàscisi = mangiare a sazietà], lu sejont San Creper [crepa = crepapancia], lu tiarz San Sclop [sclopà = scoppiare]» (Il primo giorno di carnevale è San Pasciuto, il secondo San Crepapancia, il terzo è Santo Scoppio). In questo contesto, in gran parte perduto, ricostruire una mentalità contadina con tutte le sue complesse interdipendenze (oggi dalle maschere, è possibile riconoscere ancora origini slave, austriache o locali) è molto difficile.
Resta il fatto che viene ad emergere, a mutili frammenti, un mondo — in gran parte dai resoconti dei processi dell'Inquisizione — greve, sommerso nel fango di una paura senza nome della morte. E già stato fatto notare che non è casuale il comparire delle grandi pestilenze del XIV secolo assieme ad un lento decrescere della naturalità della morte, quella che Ariès chiama, in un suo libro, (Storia della morte in occidente), la «morte addomesticata», mentre compare un concetto che è quello della «morte di sé». Huizinga ritiene che sia la campana che annuncia «l'autunno del Medioevo». Ariès ritiene, d'accordo con Tenenti, che ciò possa essere l'attaccamento alla vita, «la vita piena». In uno spazio in cui si affrontano il bel vivere e il vivere di stenti, lo specchio rimanda, nonostante tutto, un'immagine di felicità della vita malgrado la presente infelicità, e da ciò sorge, impetuoso, vorticoso, drammatico il concetto stesso di esistenza.
Nel grande monastero fortezza di Sesto al Reghena tutti, poveri o ricchi che lì si recano a pregare, possono vedere affrescato, il loro dramma segreto, il dramma della morte di sé. E l'affresco, si ritiene degli inizi del XIV secolo, dell'incontro dei tre vivi e dei tre morti.
Non che tutti l'abbiano visto, naturalmente, ma è una cosa che ormai sta nell'aria, assieme ai germi della peste e determina una nuova, tenebrosa, sensibilità e morbosità. Non v'è momento più adatto a tale concetto di un momento in cui così poco valore ha la vita.
Udine, giovedì grasso 27 febbraio, venerdì 28, sabato 1 marzo 1511
«A furore rusticorum libera nos, Domine.»
Un'immagine «alta» direbbe che la Patria del Friuli del XVI secolo ricorda una tragedia di Shakespeare, un'immagine «bassa» potrebbe farci ricordare pagine di Gargantua e Pantagruel, oppure, per essere più vicini al senso del tempo, l'uno dentro l'altro. Vi è un piccolo Riccardo III, Antonio Savorgnan, i cui seguaci potrebbero benissimo chiamarsi Falstaff, Pistola, Sommario, Silenzio, Bardolfo, e vi sono gli abitanti di Lerné che per ordine del re Picrocole assaltano i pastori, e il re che assedia la fortezza Clermaud. La tragedia ha in sé il riso, come il corpo ha il tanto terrorizzante scheletro che pur lo sostiene.
Nel 1508 scoppia la guerra fra l'Impero e Venezia. Sono guerre strane, ma tutti si muovono vorticosamente sulla terra friulana. Gli imperiali vanno e fuggono, ritornano, assediano Udine, e, immancabilmente vivono sul terreno. Sono 14.000 che mangiano, bruciano, violentano, bevono, inseguono e sono inseguiti. Nella pause, il Papa ed altri signori fanno lega a Cambrai e muovono guerra a Venezia la cui sfortuna è uguale a quella della Chiesa, come ha scritto un grande dell'epoca, troppo forte per essere sconfitta, troppo debole per prendere il potere e costituire uno Stato.
La rabbia contadina comincia a debordare. Nella Carniola viaggia per monti e valli un santo contadino che afferma di avere rapporti diretti con lo Spirito Santo, i contadini che lo seguono bruciano i castelli, tagliano la testa ai nobili proprietari e costringono le gentildonne, vestite da contadine, a lavorare la terra. E il mondo alla rovescia. Ma, breve è il Carnevale e molto lunga la Quaresima. Cinquant'anni prima, per poco la plebe, in un momento di furore, non aveva preso il castello di Spilimbergo, per un motivo sproporzionato all'evento, almeno pare, visto che avevano arrestato un mugnaio reo di furto.
Ma nell'anno della guerra imperiale è il castello di Sterpo ad essere assalito e bruciato (1509).
E una situazione di endemica insicurezza, e intanto Antonio Savorgnan medita.
Egli medita sullo stato delle cose. Per quel che sappiamo di lui, e abbiamo una coralità di giudizi negativi, quasi egli fosse del tutto simile al torvo pensoso isolato psicologicamente e fisicamente Catilina del Maccari aveva una notevole, anche se contorta e ambigua personalità (ma sono i tempi che rafforzano le inclinazioni). D'altra parte, nella oggettività della situazione, la potente famiglia doveva per forza di cose essere guardata con sospetto, sia per quella «larvata Signoria» di cui parla Ventura in quella che è certamente la più acuta analisi fatta su di una vicenda vista distrattamente dagli storici non friulani, (anche se non è sfuggita, sia pur descritta in modo un po'
meccanico, agli storici sovietici Skaskin e Samarkin), e mi riferisco a “Nobiltà e popolo nella società veneta del 400 e 500”, sia per l'ostilità istintiva che potevano provare dei signori feudali come quelli friulani, fossero o meno di origine tedesca, verso un'aristocrazia mercantile.
Non a caso Roberto di Spilimbergo scriveva: «pertanto io protesto coram Deo che [...] ne hanno messo il jugo de questa servitù perpetua, che mai non fui consentiente».
Il Savorgnan intuiva che l'appoggio che Venezia da quasi un secolo forniva alla sua famiglia, era un appoggio obtorto collo, presa com'era la repubblica fra la sua evidente simpatia per la classe dirigente che si rivelava infida, e l'impossibilità, classista, di appoggiare deliberatamente istanze contadine.
D'altra parte l'assenza di una forte borghesia comunale in Udine, l'unica città in qualche modo «borghese», rendeva precaria la scelta di alleati. Per quanto nei secoli passati, molte famiglie d'artigiani, mercanti, professionisti, banchieri fossero venute a stabilirsi in Friuli, e a Udine in particolar modo, in parte portati o invitati dai patriarchi italiani, lombardi soprattutto (basterà ricordare alcuni nomi per risentirne la toscanità: Capponi, Cavalcanti, Soldanieri, Lotti, Anselmi, Vanni, Manini, Brunelleschi, Neri, Ridolfi) il loro influsso politico era minimo, culturalmente nullo.
Un vecchio e accuratissimo studioso di cose friulane, lo Joppi, ci rammenta che Udine, almeno fino alla fine del XV secolo, non ebbe un artista, uno storico, un letterato, un poeta.
Ne conseguiva una sorta d'ambigua politica, oscillante fra il colpo al cerchio e l'altro alla botte, con molto paternalismo verso il basso, sospirosa tolleranza verso una nobiltà in generale arrogante, incolta e rissosa, pignolissima con i contadini e distrattissima nel pagare le tasse: nel 600 un di Toppo denuncia una rendita di 94 staia di frumento mentre, spulciando i libri contabili, si può trovare che supera i 240. (Bianco). La condizione di guerra guerreggiata, con incursioni dentro il territorio della Patria, rendeva la situazione estremamente confusa, specialmente per chi, stando a Venezia, di là seguiva l'andamento delle cose.
In ogni modo Venezia, muovendo cautamente i piatti della bilancia, un cenno d'interessamento lo aveva dato ai contadini, abolendo progressivamente, fino alla sua totale scomparsa, la servitù di masnada, pur riaffermando — colpo all'altro piatto della bilancia — i diritti dei castellani sui servi.
Questo atto formale non era stato certamente senza effetto. Pur non divenendo «marcheschi» nella maniera descritta dal Machiavelli, certo i contadini s'erano spostati istintivamente verso la Repubblica.
Per quanto ignoranti, illetterati e incapaci di vedere il mondo oltre i campi e il villaggio, essi non potevano non provare grande inquietudine per lo scalpitare dei loro padroni verso l'impero. Non v'era dubbio che l'impero avrebbe significato il ritorno, tout court, dell'antico modo di governare.
Così la campagna, ribollendo per mille correnti e rivoli, tende a coagularsi intorno ai più evidenti difensori di Venezia, i Savorgnan, uno dei quali poi — il caso si presenta all'appello della storia come una delle condizioni necessarie — era il capitano delle cernide.
Delle cernide abbiamo già parlato, ma per quanto da poco fossero militarmente — almeno contro i Turchi — secondo il conte di Porcia, all'epoca avevano la forza di 1250 archibugieri, 1300 galeotti, 1250 picche.
Cosa del tutto rispettabile se si tien conto dell'antichità dei castelli, rabberciati alla meglio per paura dei Turchi, e di guarnigioni nominali, certo più che sufficienti ad imporre pioveghi (cioè corvée), tasse e altro ad una masnada impaurita, inadatta alle armi, come dovevano essere i contadini.
La preoccupazione dei nobili è puntigliosamente annotata da Francesco di Strassoldo il quale, parlando dei contadini, scrive: «hanno inter caetera dicto et usate alcune nefandissime e diaboliche parole massime de tagliar a pezzi prelati, zentilhomeni, castellani, et cittadini, et denique de far uno vespro cicilian [...]».
L'aria era agitata da condizioni molto precise: la questione delle migliorie sui mansi. I proprietari dovevano rifondere gli affittuari delle spese sostenute, che, a volte, eccedevano il valore del fondo stesso.
Nel 1503 il Parlamento della Patria aveva fatto pendere la bilancia dalla parte dei proprietari, aggiungendo poi, come una sorta di minacciosa spada di Damocle, che il Comune rustico sarebbe stato responsabile di possibili danni determinati da atteggiamenti di protesta o ribellione. Non si vede come un Parlamento così costituito avrebbe potuto legiferare diversamente (il giovane avvocato Karl Marx esordì proprio con un argomento non del tutto dissimile, a proposito della legge sui furti di legna, dove sosteneva la tesi che era assai improbabile che dei giudici, figli di proprietari di boschi, fossero in grado di essere «oggettivi» di fronte ai furti nei boschi), resta il fatto che tutto ciò consolidò definitivamente il peso del «partito veneziano».
Il Devoto dice, nel suo Dizionario della lingua italiana: «partito. Diviso [...] o con l'idea di un frazionamento accentuato spec. sul piano politico o civile [...]e cita Dante «Li cittadin della città partita».
Ora, l'idea di partito che accompagna il nostro andamento sociale, non è certo la più adatta a farci comprendere il concetto di partito in uso nel XVI secolo. Non vi è somiglianza di sorta fra i due termini tranne, forse, nella comune adesione al trasformismo, anche se, una maggior radicalizzazione dello scontro fino all'eliminazione fisica dell'avversario, rendeva più difficile, anche se non impossibile, un passaggio armi e bagagli dall'altra parte (e proprio lo stesso Antonio Savorgnan di cui si parla, pochi mesi dopo quel Giovedì grasso, passerà agli imperiali, finendo poi ucciso per mano di non dimentichi avversari).
Sarà proprio un Furlano di quei tempi a dire, a giustificazione dell'uccisione di un avversario: «omo morto non fa guerra».
I nomi dei due partiti sono di origine confusa, strumîrs e zambarlàns, «strumieri» e «zambarlani». Abbiamo già accennato alle definizioni approssimative di ghibellini e guelfi, che, in qualche modo, possono dare una vaga idea del complesso intreccio di questi «partiti» che partiti non erano, e che governavano, o meglio controllavano, strati notevoli della città e delle campagne. Sappiamo che, per distinguersi bene gli uni dagli altri, i simpatizzanti delle due parti portavano piume sui cappelli, erbe sulle scarpe e fiori.
La tensione aumentava in continuazione. Questi versi ne sono una testimonianza eloquente:
Raibe stizze velen el maal mazuch
Mal di sclese e di sclop lancuur faiaal
La madreule el madron e ogni maal
Ai Signors e in tiri in t'un scrusup.
Rabbia rogna veleno il mal caduco / mal di scheggia e di vermi / crepacuore e malanno senza cura / il tappo al culo l'ipocondria e ogni male / ai Signori, e che gli capiti in una catapecchia.
Dove aleggia un'aura impalpabile e maleodorante, che sa di evocazione, di «preento», di scongiuro, d'invettiva e di maledizione, di odio gridato a squarciagola e con irrefrenabile violenza, un odore di morte i cui miasmi salgono dalle campagne e dalle città, dove nobili spaventati e incarogniti sostano, pernottano, vigilano assieme a servi e seguaci e bravi, guardando gli uni le case asserragliate degli altri, ascoltando i brusii che salgono dalle strade e che superano gli alti muri e provengono da altre strade, da braide all'apparenza deserte e percorse dal gelido e omicida vento di febbraio, dove i colori dei panni dei gonfaloni e dei pennoni sembrano funesti presagi, scricchiolanti per il ghiaccio che li artiglia.
Sono i giorni in cui per la prima volta il sole rivolge indietro i suoi passi e l'ora della sera, suonata con quel lugubre lamento che han le campane delle chiese nei giorni che inclinano lividi verso sere furtive, s'allontana impercettibilmente. Febbraio è il peggiore dei mesi, “Fevrarùt piés di dut, ma già 'e Pifanìe un pît di strie” (all'Epifania un piede di strega, i giorni, cioè, crescono impercettibili come i piedi delle streghe).
Dentro il palmo del destino premeva il sangue, e dietro s'agitava già per le viscere della terra brontolando il terremoto, e dietro ancora, in letargo, i bacilli della peste stavano per schiudersi.
«Li poveri castelani tuti stavano neli loro casteli cum grande temerosità, dubitando de non eser tagliati a pezi deli vilani e abrusati.» Spaventati, alzavano la voce i castellani, e uno degli uomini della famiglia di punta, contraria ai Savorgnan, Alvise della Torre, risponde ai signori di Spilimbergo che lo informavano d'avere uomini pronti — arroganza della paura o della certezza? — «ve avisemo, che quella bestia de Antonio Savorgnan [...] era posto in tanta fuga, che non ardiva monstrar lo volto».
Intanto in questo clima da fine del mondo, le osterie erano piene, la gente si voleva divertire ad ogni costo, quasi avesse sentore che ogni cosa stava per chiudersi con lo scricchiolio sinistro della bara, e tutti volevano ballare e darsi al gioco. C'era un proverbio, un modo di dire che circolava e che ha nella sua elementare assonanza un cupo rimbombo: «Godi, vivi, squacquera e non pagar mai zacchera».
Il 26 febbraio, Antonio Savorgnan raccolse a Caprigli, cioè a Chiavris, alle porte nord della città, più di duemila villani. Egli aveva detto loro (almeno così riferisce il canonico Agostino di Colloredo in una sua cronaca) che i castellani si erano messi d'accordo con gli imperiali e che avrebbero consegnata la Patria a questi. Poi egli, circondato da una schiera di amici, Nicolò Chiribin, Nicolò Zanni de Cortona, Francesco Janis de Tolmezzo,
Riccardo de Fontanabona, Zuan Francesco Torso, Odorico Susanna, era entrato in città e aveva parlato agli zambarlani della città, agli amici che aveva nell'Arengo e li aveva incitati ad unirsi nella causa comune, aveva poi detto a questi: «Queste sono tutte le casade suspecte et rebelle: tutte le casade de Colloreto, excepto messer Camillo, et quelli de Mels; tutti li Strassoldi, excepto messer Zuanne; le casade delli Candidi, le casade deli Gorghi, tutte le casade de Zucco, Cucagna et Partistagno, le casade de Bertulini [...]» .
Intanto, alla spicciolata, mascherati per il carnevale, armati, i volti dipinti e le insegne del partito zambarlano bene in vista, i contadini entravano in città, creavano scompiglio, gridavano «Savorgnan, Savorgnan» (e, con ogni probabilità, visto che tutte le cronache sono dell'altra parte, grida marchesche), s'azzuffavano con membri del partito avversario. Il luogotenente generale se ne sta imbarazzato e perplesso in Castello.
In seguito si vedrà, dall'inchiesta fatta fare dal Senato, che, se non aperta istigazione e determinazione a procedere in tal senso, un certo favoreggiamento ci dovette essere. Non poteva certo sfuggire, a chi ben sapeva la gravità della situazione, cosa potevano significare centinaia di furibondi contadini che, entrando in città, si mescolavano a riottosi popolani, a poveri, ad avventurieri.
Nel pomeriggio del 27 la situazione precipita. La gente «dabbene» si tappa in casa, spranga porte e finestre e attende. I della Torre e i loro seguaci, sparano archibugiate sulla folla che si avventa contro i portoni dei loro palazzi. Un misterioso cannone, tratto a forza dal Castello (ma si può portar via un cannone dai muri di una fortezza che è sede della massima autorità politica e militare di Venezia, senza che questa intervenga?), mentre suonano a martello le campane e anche quella, simbolica ed emblematica, dell'Arengo, viene portato e messo in posizione davanti al portone principale.
Ai primi colpi la barriera di legno cade, e la massa si precipita dentro.
Altri palazzi, intanto, vengono assaliti e messi a sacco. Coloro che fuggono, braccati, ricercati, e uccisi. Più di 20 palazzi e case «de le miglior de la terra», saccheggiati. Fuggendo, perdono la vita tre della Torre, Alvise, Nicolò, Isidoro, due dei Colloredo, (Teseo e Federico), e poi Leonardo della Frattina, Apollonio Gorgo. Altri riescono a fuggire, a nascondersi in case insospettabili. Intanto il palazzo della Torre comincia a bruciare. Le fiamme, nitide e crepitanti, in un giorno livido di febbraio che già inclinava alla sera, salivano al cielo mentre dalle finestre piovevano cassapanche, sedie, argenterie, piatti, indumenti, cibi. Le strade di quella crudele “zoiba grassa” si riempivano di maschere che portavano trofei insanguinati e di maschere che erano mascherate da nobili con gli abiti tolti ai morti o rubati. Mai rovesciamento dei ruoli era stato meno simbolico e più realistico, mai gioco dell'inversione delle parti, più cruento.
Alla fine della prima giornata, mentre allegra la fiamma rischiarava le strade — una notte da Turchi — e i villani con i loro alleati popolani riempivano le osterie o s'addormentavano al riparo di qualche muro, in qualche braida, Antonio Savorgnan e i suoi amici potevano, forse, ritenere di ver saldato il conto e di essere in grado di presentare alla Serenissima un gradevole «fatto compiuto», da deprecare formalmente.
Il giorno dopo il carnevale riprende, suscitando sempre di più la preoccupazione del luogotenente generale che se ne sta sempre chiuso in castello, pare per mancanza di truppe.
Il problema è che innescare una rivolta di contadini non è la stessa cosa che pagare dei mercenari e degli attaccabrighe affinché facciano da agenti provocatori, pronti a scomparire ad un cenno dell'ufficiale pagatore.
Il Lutero, soddisfatto dell'aiuto contadino alla causa della Riforma, non lo è più poco tempo dopo, tanto che è spaventato «della plebaglia impazzita dei contadini» al punto di fare un appello ai nobili affinché ognuno di essi «percuota, ferisca, sgozzi, uccida come se fossero cani arrabbiati [...]».
Nella complessa articolazione di un grande moto sociale, il meccanismo di scatto è poco importante, ma, una volta partito il segnale, la fiammata della rivolta di «classe» non ha più bisogno di incitamenti, né il cessate il fuoco ha senso.
L'erba secca brucia e la sua traccia corre attraverso i campi, passa le colline, guada i fiumi, investe i punti cardinali e li fa ruotare come impazziti.
La notizia arriva alle campagne e, subito, bande di contadini cominciano a riunirsi, a mormorare frasi sediziose, a muoversi verso i castelli per dare alle fiamme, sicuramente, quella parte dell'edificio dove i pazienti gastaldi avevano raccolto le loro infernali carte in cui erano segnati debiti, contratti, affitti, possessi, pretese, giudizi.
Stupendissimi disordini
La domenica, come nota Girolamo Sini, «il popolo di S. Daniele, spinto dalle vessazioni dei Nobili, appiccò il fuoco al Castello con danno notabile». Il giorno dopo è assaltato il castello di Spilimbergo.
Un Colloredo scrive: «et li villani de tutte le ville fin a Sacil levati in arme contra li castelli a sachizarli et brusarli et dove non li fo fatta resistentia entrarono in dicti castelli [...] ita che fin a Sacil tutti i villani era in arme a tal effetto [...]». Naturalmente la tesi è che sono i partigiani di Antonio Savorgnan a sobillarli. In ogni modo «et durò sette zorni questa furia».
Intanto l'ondata s'abbatte sui castelli di Villalta, Brazzacco, Arcano, Cergnacco, Susans, Colloredo, Caporiacco, Tarcento, Fagagna, Moruzzo, Zoppola, Cusano, Varmo, Valvasone, Salvarolo.
Il signor di Cergneu, che vive realisticamente del lavoro dei suoi contadini, ma che è legato ancora ai Paladini di Francia, racconta sbalordito le «orrende cose che a narrar restano».
I nobili del castello di Sterpo, rocca assai forte, di roba piena, hanno la dabbenaggine di calare il ponte levatoio per parlamentare e i contadini, che nulla sanno di Orlando e di Artù, irrompono nel castello.
E poi, il virtuoso signore di Cergneu esclama: «Dirò de mi, a quali il castello nostro Cergnacco fu depredato e ruinato; da chi? dalli nostri massari del loco medesmo, de quali alcune non era, che debitor non fusse de più de cinque fitti scorsi de resti [...]».
Intanto gli echi si propagano. Altro che mene di un Savorgnan, altro che intrallazzi, baruffe e plagiati villani: «fumo le persecuzioni in questa parte superiore de l'Alemagna a noi vicina, fumo nell'Ongaria dove adunati erano più di sedici millia villani a ruina de' nobili; e tutto in poco tempo [...]».
La storia scritta dai contadini non esiste e tutte le cronache sono piene dell'orrore di un castellano o di un benestante, così non sappiamo niente di quegli uomini, di quelle masse oscure «senza storia». C'è un silenzio assoluto. Pare che una massa anonima e bestiale, di locuste e di formiche, improvvisamente impazzita, ingrata verso chi sempre l'aveva aiutata, si sia messa a mordere la mano generosa che sempre aveva dato.
Nemmeno un oscuro cavaliere che potesse interessare un Goethe.
E il momento in cui appare necessaria un'azione rapida, prima che il male dilaghi.
Il luogotenente pare scuotersi dal suo strano torpore: chiede aiuti. Dall'Isonzo, dove contrastano gli imperiali, accorrono Baldassare Scipione da Siena con 80 cavalli leggeri, Battista Mirandola Vicentino con 50, Camillo Malfatto con 100 cavalli e 50 fanti.
E i nobili fecero campo insieme e scomenzorno a mazzar villani
60 cavalieri si riuniscono a Porcia assieme a soldati e borghesi di Pordenone e fanno a pezzi una colonna di 2000 contadini, ne uccidono un centinaio e uno lo impiccano a Zoppola. Lo scontro avviene sul greto del Cellina.
Una colonna contadina che si muove verso Codroipo viene intercettata da Andrea Loredan, del Consiglio dei Dieci, che stava accorrendo da Venezia alla notizia dei fatti friulani, la disperde, e a Codroipo è costretto a intervenire di nuovo.
Ciò il 5 marzo. Il 30, però, Sanudo, nei suoi Diarii annota che i villani stanno assaltando il castello di Porpetto.
Il primo giorno di Quaresima Loredan è a Udine e tenta di aggiustare la situazione. E’ amico di Antonio, e si muove con quella lentezza che in politica vuoi dire, oggi, insabbiamento. La cosa è nota alla nobiltà friulana. L'assoluzione da ogni responsabilità, e la conferma a capo delle cernide pare aver chiuso la questione, quando, in settembre, il Consiglio dei Dieci lo condanna, ma in segreto, a morte.
Egli ha ancora degli amici, ma non basta e fugge in territorio imperiale.
La nobiltà, che non dimentica, lo fa controllare (però c'era una taglia di 5000 ducati sulla sua testa). L'anno seguente in marzo, lo individuano a Villacco. Partono per prenderlo Zuan Enrico di Spilimbergo, Girolamo di Colloredo, Zuan di Zoppola. Secondo la cronaca del Canonico Agostino di Colloredo, gli tendono un agguato presso il cimitero della città austriaca, uccidono uno dei famigli, feriscono altri, e spaccano la testa ad Antonio, che resta a terra che ancora respira e non può più parlare. Viene un cane grosso che gli mangia il cervello. «Perché non si deve credere che Dio non fusse justo iudice.»
Qualunque sia il giudizio, certo fu uomo abile, di grande capacità politica, si collegò alla borghesia cittadina, protesse gli Ebrei. Nel panorama non esaltante della nobiltà del tempo, Antonio, e Girolamo, generale di talento, e Giulio, l'architetto di Palmanova, danno a questa famiglia una notevole vivacità e capacità che giustificano il peso preponderante avuto nella storia della Patria e di Udine.
Dalle stime fatte sui danni subiti, per quanto possano essere gonfiati per vari motivi, certo l'entità del disastro appare già in una notevole dimensione. I Torriani denunciano più di 50.000 ducati, Gerolamo di Colloredo 16.670, Antonio di Brazzacco 10.270, Giovanni Saldonieri 10.000, i Valvason 5.106, un Odoardo di Spilimbergo 2000 ducati solo per biancheria e vasellame, 600 per derrate, oltre a denunciare il furto o la distruzione di 300 staia di frumento, 400 orci di vino, eccetera.
Il 26 marzo, quando ancora la Patria era agitata da simili terribili disordini, la terra tremò. Erano le 8 di sera, il castello barcollò sotto le scosse e poi rovinò nella polvere, la chiesa di S. Maria si spaccò e il vecchio campanile non resistendo, s'inginocchiò.
E poi l'ala della peste s'alzò da quella polvere. «E ne seguitava stupendissimi disordini e calamità, cadendo de multi a terra sì de fame che peste, sentendose exlamar et ulular de zorno et de nocte le misere persone et fanciulli [...]».
Un terzo dei cittadini di Udine moriva, e c'è chi parla di diecimila, e della Patria si sa solo che la tragedia fu immensa.
scrito da (on soçałista o comonista?)

https://www.filarveneto.eu/wp-content/u ... -Friul.jpg
L'inverno del patriarcato
Ormai l'inverno del patriarcato era alle porte.
Secondo ogni legge fisica e storica una pressione costante su di un oggetto, alla lunga finisce con l'indebolirne la struttura.
Se poi le forze interne che regolano la forma materiale dell'oggetto cominciano ad incrinarsi, ogni speranza è perduta. Venezia che spinge da un lato ha raggiunto il punto in cui una zona cuscinetto fra il suo territorio e quello dell'impero è assolutamente e categoricamente necessaria. Alle stesse conclusioni giunge l'impero, e allora si mettono in moto con ogni mezzo per raggiungere l'oggetto tanto desiderato. Nel mezzo, il patriarcato d'Aquileia, la Patria del Friuli, non ha più in sé le condizioni per esistere, può solo sperare di durare. Fallito il tentativo, le «Constitutiones Patriae Foriiulii» che l'abilità di Marquado di Randek, 1'11 giugno 1366, riuscirà a promulgare, non sono altro che un monumento funebre che si trascinerà fino al 1420, anno dell'ingresso di Venezia nella Patria.
Lavorando per linee interne (l'asino carico d'oro di Filippo di Macedonia) Venezia raggiunge uno degli anelli della catena che tiene ancora in equilibrio, pur sotto tensione, lo stato patriarcale. L'iscrizione, nel 1385 di una delle colonne portanti del patriarcato, Federico, della famiglia Savorgnan, fra i nobili del maggior consiglio della repubblica, è la rottura dell'anello. Nel 1388 il Patriarca Giovanni di Moravia, nel tentativo di spezzare la velata signoria su Udine dei Savorgnan, portando al governo cittadino membri delle 12 arti rappresentate in città, ruppe il secondo anello: la città. Cividale e Udine si allearono in campi opposti e la diga rabberciata che teneva immote le acque feudali, a sua volta, si ruppe.
Nel tortuoso scorrere delle maree, preso il flusso, Venezia raggiunse il suo obiettivo, un relitto arenato.
Il patriarcato, come forza spirituale, resterà per qualche secolo, poi altre vicende lo trascineranno in Venezia. Elio Bartolini descrive i giorni veneziani dell'ultimo patriarca in uno splendido, ambiguo e profondo romanzo: Pontificale in San Marco. L'involucro di quella che fu una potenza materiale e spirituale, per l'aura che emanava, poteva essere ancora appetibile e così lasciò il palazzo di Udine con gli affreschi per andare in un altro palazzo con affreschi a Venezia, in un momento in cui, l'ironia della storia, vedeva un involucro di repubblica. Era venuto l'inverno dello scontento, anzi, era tornato, perché esso sempre torna.
Le ali del leone
La fede et conversation dela sua Republica consisteva solo in li villani et plebei.
(Amaseo, Diarii)
Nel 1421, nello stesso periodo in cui Venezia stringeva i fili del proprio secolare potere in Friuli, il doge Tommaso Mocenigo elencava, in una lettera — quasi un congedo — ai suoi compatrioti, in cifre, la grandezza della città. 195.000 persone si affaccendavano fra le calli e i canali, circolavano dieci milioni di ducati che fornivano un interesse annuale di quattro milioni. Solcavano i caldi mari in cui si spartiva il Mediterraneo più di 3.000 navi con 20.000 marinai, e nei piccoli laboratori artigianali 16.000 operai producevano di tutto e trasformavano le materie prime.
La guerra di Chioggia, con l'occupazione, certo momentanea ma traumatica, della cittadina lagunare da parte dei Genovesi, aveva sollecitato un ripensamento strategico complessivo.
Il relativo disinteresse per la terraferma era motivato dal fatto che frammentari poteri feudali poco potevano impressionare una grande potenza. Le cose cambiavano quando erano viste sotto l'inquietante crescere dei Visconti in Lombardia che, oltre al fatto di essere uno stato unificato, minacciava già Verona, Vicenza e Padova, tagliando inoltre le grandi vie commerciali per l'Europa.
Una cosa, forse, sfuggiva ai sottili politici di San Marco. Per essere sempre stata «fuori» dalle campagne, il fenomeno feudale aveva toccato Venezia in misura molto piccola; così i suoi rapporti con i cittadini, con gli artigiani, con gli operai, con i contadini, pur non sfuggendo a certa demagogia, erano stati più sfumati. L'aristocrazia mercantile d'altra parte, agendo in un clima estremamente favorevole - erano eliminati gli scontri frontali fra contadini, popolo e feudatari - evitò, senza neppur rendersene conto, il pericolo della Signoria, vista la grande compattezza politica dei gruppi dirigenti.
Non a caso, a lungo, il regime politico di Venezia venne visto da osservatori politici, legislatori e filosofi come una sorta di «migliore dei mondi possibili». Brian Pullan lo analizza molto bene, e cita Contarini al quale non sfugge la situazione: «Cosa veramente sopra il creder d'ogni uno, che il popolo sendo stato tanti anni privo del governo publico, mai habbia rifiutato l'imperio de i gentil huomini...»; così il «modello» veneziano venne osservato da uomini della statura di Bodin e di Botero.
Entrando però nelle grandi e immote campagne dell'Adige e del Po, del Brenta, del Tagliamento fino all'Isonzo, la Repubblica doveva farsi carico di ensioni e lacerazioni di cui non aveva pratica diretta. Non solo, ma con il XVI secolo entriamo in un periodo, che taluni definiscono di «rifeudalizzazione», in cui assistiamo all'inizio di un'inversione di tendenza dell'economia basata sul commercio: il capitale viene immobilizzato sempre di più nell'acquisto di grandi proprietà terriere, e sempre di meno investito in quei commerci che erano stati la chiave della grande ascesa della potenza della repubblica. Nel 1454 Venezia, con la pace di Lodi, ha definitivamente chiuso il ciclo della sua espansione a onde intorno al centro. Tutto il Veneto, il Cadore e la Patria del Friuli fino ai confini della contea di Gorizia e delle Alpi Carniche, parte della Lombardia fino all'Adda, portano una nuova struttura statuale, una nuova sicurezza, le ricchezze del suolo — non ultimi, certo, gli alberi che hanno, per i Veneziani, una forma esatta per tutte le parti di una nave — e nuovi investimenti.
Inizialmente la Patria non rappresenta certo i boschi della Carnia, rappresenta solo un ulteriore allargamento dell'anello difensivo.
Nonostante tutti gli sforzi non è riuscita ad avere il pieno controllo del litorale Adriatico e del golfo di Trieste; la città si è già involata nelle mani degli Asburgo i quali, per quasi tre secoli, non l'avranno in cima ai loro pensieri.
Ma contano i passi delle Alpi, la strada del ferro e la strada del sale di cui è la massima produttrice ed esportatrice. (Cento e più anni dopo troveremo che Udine e Cividale negli appalti del sale, controllati da quella potenza che era l'ordo salis, avranno notevoli tassi di profitto: 61,53% Cividale, 31,25% Udine.)
Il collaboratore per eccellenza, Tristano Savorgnan, come un suo antenato era stato ammesso alla nobiltà veneta, per ricompensa avrà il titolo di «primario della Patria del Friuli».
Nella valutazione degli interessi basterà vedere che Venezia avrà inteso dare un privilegio «onorario» e che così, invece, non l'intenderanno i Savorgnan.
Le condizioni sociali del territorio erano desolanti. Lo strano procedere delle guerre, quell'impazienza apparente di fermarsi per poco, dare il guasto, andare e ricomparire da lì a un mese o a un anno, che ha più l'aspetto di una guerriglia continua che di una campagna, avevano ridotto commercio e lavoro dei campi ad un decadimento fortissimo. Bruciare i campi, tagliare gli alberi da frutto, le viti, portar via il bestiame erano usanze che si ripetevano ad ogni uscita di campo. E quando se ne andavano gli stranieri, erano i nobili locali in eterna bega fra di loro a condurre operazioni del genere, su scala forse più piccola, ma certamente più dannosa per la sua costanza. Vittime usuali erano i contadini e, in definitiva, l'intera vita della Patria ne usciva malferma perché il paese viveva sostanzialmente di agricoltura.
Il compito di Venezia era assai difficile e per molto tempo, vista la turbolenza del paese, gli scontri con l'impero, le scorrerie della cavalleria turca, cercò di cambiare il meno possibile.
L'unico cambiamento di fondo fu quello della direzione politica e amministrativa.
Con ogni probabilità, visto l'esiguo numero di personale a disposizione, sia per gli allargamenti territoriali, sia perché impreparata tecnicamente ad essere «impero», il piccolissimo strato burocratico locale dovette rimanere. Il personale dirigente fu sempre veneto, ogni potere reale fu sottratto al Parlamento, la Chiesa venne relegata nel ruolo che uno Stato, molto laico e poco incline allo strapotere clericale, riteneva idoneo ad un'autorità spirituale (così come avrebbe fatto molti anni dopo il friulano Paolo Sarpi, non a caso protetto dalla Repubblica). Il potere politico venne accentrato nelle mani di un rappresentante del Senato, il luogotenente, una sorta di governatore, il quale, oltre ad avere un limitato arco di tempo di governo, doveva mandare a Venezia quelle «relazioni» che saranno la base di uno studio molto accurato da parte degli storici per la gran quantità d'informazioni sociali ed economiche sul territorio preso in esame.
Il luogotenente stabilì il centro della propria attività politica nel castello sul colle di Udine.
Inoltre, vista la necessità di provvedere alle difese della terra, minacciata da imperiali e da Turchi, si dette mano alla costituzione di gruppi di contadini armati, le «cernide». A capo di questi organismi, naturalmente sollevando le proteste, le diffidenze ed i sospetti dei nobili di parte imperiale (molti dei quali speravano inutilmente in un ritorno al vecchio modo di governare, una volta pur tanto detestato), fu messo un membro della famiglia Savorgnan che non se ne lasciò mai sfuggire il controllo. In realtà l'efficienza militare delle cernide era assai limitata. Non bastava assicurare un minimo di armamento a dei gruppi di contadini: l'addestramento all'uso delle armi e la pratica di combattimento richiedeva troppo tempo. In questo contesto si assiste al lento spostarsi dell'appoggio contadino a Venezia, come controprova della disaffezione che l'uomo della gleba provava per i suoi signori.
Del resto, di tale appoggio Venezia godrà in tutto il suo territorio per secoli. Di questo fatto darà diretta e stupita testimonianza Nicolò Machiavelli nel 1509: «E tutto dì occorre che uno di loro preso si lascia ammazzare per non negare el nome viniziano. E pure iersera ne fu uno innanzi a questo Vescovo, che disse che era Marchesco, e Marchesco voleva morire, e non voleva vivere altrimenti; in tal modo che il Vescovo lo fece appiccare; né promessa di camparlo, né d'altro bene lo possé trarre di questa opinione; dimodoché, considerato tutto, è impossibile che questi re tenghino questi paesi con questi paesani vivi».
I Turcs tal Friul
Per più di due secoli le incursioni della cavalleria irregolare turca, infiltrandosi attraverso le valli della Drava e della Sava, alle spalle dell'Istria veneziana, saggiarono le difese veneziane e imperiali, imparzialmente.
Sulla spinta delle conquiste nella penisola balcanica, l'impero turco si assestò come scomodo vicino per i regni cristiani. All'interno del sistema di stato costituito, la selvaggia cavalleria irregolare dei Turcomanni finiva con l'essere di estremo disturbo. Così venne deciso dai sultani di usarla per scorrerie alle frontiere e oltre. Questo corpo irregolare, gli agingi, viste le difficoltà del Tesoro ottomano a pagare costantemente un esercito regolare, era pagato esclusivamente con il bottino che riusciva a procurarsi in qualunque condizione, in qualunque territorio oltre a quello imperiale.
Questi cavalieri, che rinnoveranno per secoli lo stesso terrore degli Ungari, si erano aggregati all'impero sotto la spinta delle tribù mongole di Genghiz khan, e avevano seguito le fortune dei sultani. Avevano un armamento leggero: archi, lance, spade, poche armi da fuoco. Abituati ad una vita dura e selvaggia, si muovevano con grande rapidità, distruggevano, bruciavano, depredavano e prendevano prigionieri....
Per farvi fronte venne costruita la gigantesca fortezza nella bassa pianura, Palmanova, la cui modernità e la cui misura saranno proporzionali all'inutilità del lavoro e al gigantesco saccheggio, questo «legale», cui si diede la Repubblica per reperire i fondi. La maggior spesa venne sostenuta, e pare naturale, dai «fedeli e boni furlani».
Un conglomerato eterogeneo
«Un conglomerato eterogeneo, tenuto insieme dalla forza coercitiva del governo centrale» (Ventura).
All'indomani dell'acquisizione del Friuli gravi contrasti di fondo avevano scosso Venezia. La tendenza a impegnarsi in terraferma, contrastata dal vecchio doge Mocenigo, aveva avuto la meglio, ma, come è stato notato, il partito vincitore non proponeva idee chiare e, soprattutto, non aveva una strategia di lunga durata. Così il gruppo dirigente si trovò impegnato nella costruzione di uno Stato che non era quello per cui la città era sorta, né quello in cui si era formata una classe dirigente aristocratica, abile nella politica mercantile, ma limitata a pensare solo in funzione cittadina.
Vennero dunque stesi i fili di un potere molto centralizzato. Nessun friulano ebbe mai in mano uno solo di quei fili. Il luogotenente rispondeva solo a Venezia. D'altra parte una politica di rotazione costante, forse utile, forse eccessivamente sospettosa, impediva a quel funzionario di avere una conoscenza approfondita del territorio che governava. Se sono di buon livello, accurate e attente le relazioni che era tenuto a inviare, con ogni probabilità ciò è dovuto agli estensori reali.
Il luogotenente generale aveva la sua sede in Udine e controllava il territorio della Patria e il Cadore. Dei Rettori, che in larga misura da lui dipendevano, reggevano dei dipartimenti che avevano un centro amministrativo a Caneva, Sacile, Pordenone, Portogruaro, Marano, Monfalcone, Cividale, Venzone e, dopo la costruzione della fortezza, Palmanova, che aveva diritto, vista la sua importanza strategica deterrente, a un Provveditore Generale della Fortezza.
Questa terra dalla struttura geologica così diversa è un mare contadino, anonimo, senza storia e senza tempo. Venezia deve trattare con questo immoto specchio d'acqua, ma non ha, ancora, nessun proponimento d'investire in bonifiche, in migliorie, in una diversa conduzione agraria.
Per il momento è interessata a non agitare troppo le acque con la nobiltà, di cui. diffida, ma di cui ritiene di non poter fare a meno pur controllando che il suo peso feudale sui contadini non sia eccessivo.
Solo quattro anni dopo il suo arrivo fa una mossa politica per trovare alleati sicuri. Il 14 aprile 1424 fa pervenire una sua Ducale in cui afferma: «Nostrae intentione fuit et est quod nobiles omnes gaudere debent sine diminutione privilegiis, concessionibus et immutatibus».
Avendo diviso il territorio della Patria in Giurisdizioni, alcune di queste continuarono per espresso desiderio di Venezia ad essere sottoposte a signoria ecclesiastica o feudale; in seguito, per necessità economiche, alcune di queste Giurisdizioni vennero messe a disposizione di chi, mercante o nobile, fosse nelle condizioni di riscattarle. Era un onore che non dava oneri alla Repubblica in quanto queste ville, dette dominicali, di per sé non erano in grado di essere rappresentate nel Parlamento della Patria dai loro signori.
Per un certo periodo di tempo, per quanto privato di reale potere politico, il Parlamento fu in grado di stabilire gli estimi per le spese militari e sanitarie. I sei deputati incaricati dell'ufficio potevano avere notevoli possibilità d'arricchire, e di far arricchire a spese d'altri, con operazioni che erano comunissime in quell'epoca come lo sono nella nostra. In seguito anche questo ufficio passò direttamente ai Veneziani (evidentemente c'era stato sentore dello zampettare di tanti topolini friulani intorno ad un formaggio friulano e si ritenne più decoroso che topolini veneziani gustassero con minori complessi il formaggio foresto).
Nel grande teatro del mondo, l'apparenza del potere ha la forma del potere e non la sua sostanza, ma resta il fatto che la forma, pur coprendo un manichino, è pur sempre visibile, rispettabile, onorabile, così questo parla-mento che si riunisce una volta all'anno nel vecchio castello del patriarca (sappiamo come doveva essere dal trecentesco sigillo del comune di Udine, visto che crollò rovinosamente nel grande terremoto del 1511) alla presenza del luogotenente, questo parlamento che parla, ma che poco conta, può almeno far scrivere, per i posteri, da un cancelliere le decisioni. Può insomma, previo cenno di capo di chi a capo è veramente, «dispensar e ordinar le gravezze e fazioni che occorrono nella Patria...».
Stanno seduti, i potenti con i poveri, i deboli, i subalterni, i contadini, undici rappresentanti della Chiesa, quarantacinque feudatari e tredici città dette Comunità: Udine, Gemona, Venzone, Tolmezzo, Sacile, Portogruaro, (i lettori del Nievo ricorderanno la sonnolenta e nebbiosa vita della gente dabbene di Portogruaro sul crinale della grande Rivoluzione: veramente il tempo gira in ozioso e silenzioso circolo), Monfalcone, di notevole interesse strategico per il suo incunearsi nelle terre dell'impero, San Daniele, Fagagna, Aviano, Caneva, Mossa, Meduna.
Capitoło: Lo slittamento dei codici: dal linguaggio del rito al linguaggio della rivolta
Man mano che l'antropologia culturale, arricchita da studi interdisciplinari, prende in esame determinati eventi storici, s'accorge di affondare sempre di più in un mare di significati complessi. Per molto tempo la rivolta contadina che sconvolse il Friuli nel 1511 è stata vista come un'anomalia. Si è pensato immediatamente a «rimuovere» pretese, definite «pretesti», su di un'interpretazione basata sul concetto di lotta di classe.
L'evento è stato staccato dal suo contesto e visto con molta perplessità. Si è pensato, dapprima, di darne un'interpretazione di lotta politica, di «parte», tenendo conto che lo scontro avveniva fra due fazioni, «zambarlani» e «strumieri», di cui la prima era favorevole a Venezia (e in qualche testo definita «guelfa») e la seconda all'impero (e perciò «ghibellina»).
In secondo luogo si è trasformato questo avvenimento in una rivolta diretta dai Savorgnan contro i loro rivali i della Torre, nobili d'origine lombarda e imperiali, per eliminarli direttamente dalla scena politica friulana. Cosa prevista, tanto che nobili amici dei della Torre non avevano mancato di avvisare i sospettosi padroni veneziani su non certo tanto ipotetici sospetti nei confronti di un Savorgnan Antonio, che poteva voler una signoria, e che perciò si sforzava «de meter insidie fra li villani e li castellani, maxime in questo caso che li castellani non vedevano l'ora de mutar stado per tornar la famoletà (servitù) in la Patria, et cazar li villani zoso de li tereni per non li pagar loro meglioramenti».
Ma, dando pur per esatte queste versioni-almeno suì fatti non c'è molto da discutere, se mai si tratta di trovare negli archivi altro materiale-l'antropologia, aiutata dalla psicologia e dalla psicanalisi e da altri strumenti, va più nel profondo e tende a far emergere vibrazioni collettive, onde lunghe generalizzate, tendenze del profondo che vengono da molto lontano nel tempo, molto inquietanti.
Prendiamo ad esempio il periodo 27, 28 febbraio e 1 marzo del 1511: si comincia con Giovedì grasso. Casuale?
Naturalmente potrebbe essere casuale, ma vi sono coincidenze che non possono non interessare e non obbligare ad una più approfondita riflessione.
Alcuni esempi: nel 1376 a Basilea ha luogo, il Martedì grasso, un massacro di tale portata da essere ricordato negli annali svizzeri come bòse Fastnacht (cattivo Carnevale); a Londra, in una festa popolare scoppia una rivolta
contadina, è il 1517, a Digione, nel 1630, scoppia una violenta rivolta di viticultori a Carnevale; sul Carnevale di Romans, del 1580, Le Roy Ladurie ha costruito un libro eccezionale, appunto intitolato Il Carnevale di Romans (Burke ricorda anche altre rivolte con massacri in giorni di festività chiave, come il Corpus Domini della Catalogna, e la Domenica delle Palme di Madrid del 1766).
Non a caso, molto acutamente, nel suo documentatissimo e monumentale libro “Tradizioni popolari in Friuli”, A. Ciceri avverte l'esistenza di questo implacabile, se pur apparentemente invisibile filo, quando ricorda che «gli eccessi più gravi che la nostra storia ricordi, sono avvenuti sempre nel "giovedì" grasso», ed ha in mente, oltre ad un altro fatto, proprio il giovedì grasso del 1511, e annota, inoltre, come i membri delle due fazioni portassero «mascheramenti di segno diverso, onde riconoscersi nella lotta».
Allora è evidente che qualcosa lega gli eventi a movimenti tellurici dell'inconscio collettivo.
Quali, e perché, e in che misura?
Il mondo alla rovescia
Gli elementi fondamentali del Carnevale sono il cibo, il sesso e la violenza. Bachtin ha dato interessanti motivazioni sulla maschera, specialmente sull'inversione dei ruoli maschio-femmina e l'interpreta come «il diritto carnevalesco di critica e derisione, che talora sfociava in rivolta vera e propria». In sostanza era un'usanza di cui l'attuale Carnevale, in epoca postindustriale, non è altro che un pretesto senza le basi sociali che ne sostengano l'ambiguità e la funzione, spesso ripetuta, di valvola sociale.
Abbiamo già ricordato l'interpretazione che vien data, alla luce di recenti indagini, della Messa dello Spadone nel giorno dell'Epifania in Cividale.
L'inversione dei ruoli e la contrapposizione dialettica ne sono le componenti: maschio-femmina (molte maschere hanno significati sessuali), dominati-dominatori («Un giorno di regno», i dominati regnano per un giorno — in epoche più antiche i dominati che regnavano per quel giorno venivano sacrificati come simbolo del limite invalicabile che si poneva fra il potere e il mondo dei poveri) il grasso-il magro (al di là di spiegazioni di normativa alimentare-etichette messe su situazioni di cui non si comprendeva il reale significato. Harris ad esempio ha svelato l'arcano della proibizione del maiale fra i popoli semiti e della mucca fra gli indù, – v'è la più elementare spiegazione di un periodo agricolo in cui s'impoveriscono le scorte, ed ecco la Quaresima).
La permissività del Carnevale può essere stata interpretata come una valvola di sfogo a tensioni a lungo represse (non è spiegabile altrimenti il vagheggiare il Carnevale che avveniva nel passato, dove tutto accadeva in funzione del prossimo Carnevale, divertirsi certo, ma che altro?).
Non a caso L. Accati indica nel Carnevale in Friuli, uno dei meccanismi in cui la Chiesa cerca di comprimere tutte le feste contadine. A questo punto il «Carnevale assomma dunque e concentra i significati delle feste, diventa il
teatro in cui si riversano i riti agrari e non cristiani via via espunti dal calendario. Il Carnevale festeggia la morte della vecchia stagione, il nascere della nuova, la fertilità e la fecondità e nel contempo ironizza sulle assurde pretese della gerarchia dominante e dei suoi membri all'eternità e all'immortalità».
A risultati del genere, per un'area diversa (ma teniamo a mente come nei secoli passati un substrato «pagano» e neolitico fosse abbastanza comune, prima cioè che le diversità nazionali e le culture delle classi dirigenti si stendessero in maniera abbastanza impermeabile sull'inconscio contadino) sono arrivati la Zemon-Davis, Camporesi, Hill.
Hill, ad esempio, ritiene che queste feste d'apparente follia fossero «una valvola di sicurezza: le tensioni sociali si allentavano grazie a questo periodico “bouleversement” e forse l'ordinamento sociale ne risulta un po' più tollerabile».
È dopo, molto dopo, certo non nella nostra situazione (ecco perché il timore di un'interpretazione «rivoluzionaria» del giovedì grasso 1511 è privo di fondamenti) che sorge una domanda, e cioè se questo «mondo alla rovescia» non avesse, per caso, una possibilità politica di essere realizzato.
Carnevale in Friuli era chiamato “Inseri”, parola di cui non si sa con certezza l'etimologia (Ciceri); il Pirona (Vocabolario della lingua friulana) dice che «indicherebbe l'ultimo giorno di carnevale». Infatti c'è un proverbio della metà del '500 che suona in questo modo: «Lu prin dì d'inseri è San Pas [da pàscisi = mangiare a sazietà], lu sejont San Creper [crepa = crepapancia], lu tiarz San Sclop [sclopà = scoppiare]» (Il primo giorno di carnevale è San Pasciuto, il secondo San Crepapancia, il terzo è Santo Scoppio). In questo contesto, in gran parte perduto, ricostruire una mentalità contadina con tutte le sue complesse interdipendenze (oggi dalle maschere, è possibile riconoscere ancora origini slave, austriache o locali) è molto difficile.
Resta il fatto che viene ad emergere, a mutili frammenti, un mondo — in gran parte dai resoconti dei processi dell'Inquisizione — greve, sommerso nel fango di una paura senza nome della morte. E già stato fatto notare che non è casuale il comparire delle grandi pestilenze del XIV secolo assieme ad un lento decrescere della naturalità della morte, quella che Ariès chiama, in un suo libro, (Storia della morte in occidente), la «morte addomesticata», mentre compare un concetto che è quello della «morte di sé». Huizinga ritiene che sia la campana che annuncia «l'autunno del Medioevo». Ariès ritiene, d'accordo con Tenenti, che ciò possa essere l'attaccamento alla vita, «la vita piena». In uno spazio in cui si affrontano il bel vivere e il vivere di stenti, lo specchio rimanda, nonostante tutto, un'immagine di felicità della vita malgrado la presente infelicità, e da ciò sorge, impetuoso, vorticoso, drammatico il concetto stesso di esistenza.
Nel grande monastero fortezza di Sesto al Reghena tutti, poveri o ricchi che lì si recano a pregare, possono vedere affrescato, il loro dramma segreto, il dramma della morte di sé. E l'affresco, si ritiene degli inizi del XIV secolo, dell'incontro dei tre vivi e dei tre morti.
Non che tutti l'abbiano visto, naturalmente, ma è una cosa che ormai sta nell'aria, assieme ai germi della peste e determina una nuova, tenebrosa, sensibilità e morbosità. Non v'è momento più adatto a tale concetto di un momento in cui così poco valore ha la vita.
Udine, giovedì grasso 27 febbraio, venerdì 28, sabato 1 marzo 1511
«A furore rusticorum libera nos, Domine.»
Un'immagine «alta» direbbe che la Patria del Friuli del XVI secolo ricorda una tragedia di Shakespeare, un'immagine «bassa» potrebbe farci ricordare pagine di Gargantua e Pantagruel, oppure, per essere più vicini al senso del tempo, l'uno dentro l'altro. Vi è un piccolo Riccardo III, Antonio Savorgnan, i cui seguaci potrebbero benissimo chiamarsi Falstaff, Pistola, Sommario, Silenzio, Bardolfo, e vi sono gli abitanti di Lerné che per ordine del re Picrocole assaltano i pastori, e il re che assedia la fortezza Clermaud. La tragedia ha in sé il riso, come il corpo ha il tanto terrorizzante scheletro che pur lo sostiene.
Nel 1508 scoppia la guerra fra l'Impero e Venezia. Sono guerre strane, ma tutti si muovono vorticosamente sulla terra friulana. Gli imperiali vanno e fuggono, ritornano, assediano Udine, e, immancabilmente vivono sul terreno. Sono 14.000 che mangiano, bruciano, violentano, bevono, inseguono e sono inseguiti. Nella pause, il Papa ed altri signori fanno lega a Cambrai e muovono guerra a Venezia la cui sfortuna è uguale a quella della Chiesa, come ha scritto un grande dell'epoca, troppo forte per essere sconfitta, troppo debole per prendere il potere e costituire uno Stato.
La rabbia contadina comincia a debordare. Nella Carniola viaggia per monti e valli un santo contadino che afferma di avere rapporti diretti con lo Spirito Santo, i contadini che lo seguono bruciano i castelli, tagliano la testa ai nobili proprietari e costringono le gentildonne, vestite da contadine, a lavorare la terra. E il mondo alla rovescia. Ma, breve è il Carnevale e molto lunga la Quaresima. Cinquant'anni prima, per poco la plebe, in un momento di furore, non aveva preso il castello di Spilimbergo, per un motivo sproporzionato all'evento, almeno pare, visto che avevano arrestato un mugnaio reo di furto.
Ma nell'anno della guerra imperiale è il castello di Sterpo ad essere assalito e bruciato (1509).
E una situazione di endemica insicurezza, e intanto Antonio Savorgnan medita.
Egli medita sullo stato delle cose. Per quel che sappiamo di lui, e abbiamo una coralità di giudizi negativi, quasi egli fosse del tutto simile al torvo pensoso isolato psicologicamente e fisicamente Catilina del Maccari aveva una notevole, anche se contorta e ambigua personalità (ma sono i tempi che rafforzano le inclinazioni). D'altra parte, nella oggettività della situazione, la potente famiglia doveva per forza di cose essere guardata con sospetto, sia per quella «larvata Signoria» di cui parla Ventura in quella che è certamente la più acuta analisi fatta su di una vicenda vista distrattamente dagli storici non friulani, (anche se non è sfuggita, sia pur descritta in modo un po'
meccanico, agli storici sovietici Skaskin e Samarkin), e mi riferisco a “Nobiltà e popolo nella società veneta del 400 e 500”, sia per l'ostilità istintiva che potevano provare dei signori feudali come quelli friulani, fossero o meno di origine tedesca, verso un'aristocrazia mercantile.
Non a caso Roberto di Spilimbergo scriveva: «pertanto io protesto coram Deo che [...] ne hanno messo il jugo de questa servitù perpetua, che mai non fui consentiente».
Il Savorgnan intuiva che l'appoggio che Venezia da quasi un secolo forniva alla sua famiglia, era un appoggio obtorto collo, presa com'era la repubblica fra la sua evidente simpatia per la classe dirigente che si rivelava infida, e l'impossibilità, classista, di appoggiare deliberatamente istanze contadine.
D'altra parte l'assenza di una forte borghesia comunale in Udine, l'unica città in qualche modo «borghese», rendeva precaria la scelta di alleati. Per quanto nei secoli passati, molte famiglie d'artigiani, mercanti, professionisti, banchieri fossero venute a stabilirsi in Friuli, e a Udine in particolar modo, in parte portati o invitati dai patriarchi italiani, lombardi soprattutto (basterà ricordare alcuni nomi per risentirne la toscanità: Capponi, Cavalcanti, Soldanieri, Lotti, Anselmi, Vanni, Manini, Brunelleschi, Neri, Ridolfi) il loro influsso politico era minimo, culturalmente nullo.
Un vecchio e accuratissimo studioso di cose friulane, lo Joppi, ci rammenta che Udine, almeno fino alla fine del XV secolo, non ebbe un artista, uno storico, un letterato, un poeta.
Ne conseguiva una sorta d'ambigua politica, oscillante fra il colpo al cerchio e l'altro alla botte, con molto paternalismo verso il basso, sospirosa tolleranza verso una nobiltà in generale arrogante, incolta e rissosa, pignolissima con i contadini e distrattissima nel pagare le tasse: nel 600 un di Toppo denuncia una rendita di 94 staia di frumento mentre, spulciando i libri contabili, si può trovare che supera i 240. (Bianco). La condizione di guerra guerreggiata, con incursioni dentro il territorio della Patria, rendeva la situazione estremamente confusa, specialmente per chi, stando a Venezia, di là seguiva l'andamento delle cose.
In ogni modo Venezia, muovendo cautamente i piatti della bilancia, un cenno d'interessamento lo aveva dato ai contadini, abolendo progressivamente, fino alla sua totale scomparsa, la servitù di masnada, pur riaffermando — colpo all'altro piatto della bilancia — i diritti dei castellani sui servi.
Questo atto formale non era stato certamente senza effetto. Pur non divenendo «marcheschi» nella maniera descritta dal Machiavelli, certo i contadini s'erano spostati istintivamente verso la Repubblica.
Per quanto ignoranti, illetterati e incapaci di vedere il mondo oltre i campi e il villaggio, essi non potevano non provare grande inquietudine per lo scalpitare dei loro padroni verso l'impero. Non v'era dubbio che l'impero avrebbe significato il ritorno, tout court, dell'antico modo di governare.
Così la campagna, ribollendo per mille correnti e rivoli, tende a coagularsi intorno ai più evidenti difensori di Venezia, i Savorgnan, uno dei quali poi — il caso si presenta all'appello della storia come una delle condizioni necessarie — era il capitano delle cernide.
Delle cernide abbiamo già parlato, ma per quanto da poco fossero militarmente — almeno contro i Turchi — secondo il conte di Porcia, all'epoca avevano la forza di 1250 archibugieri, 1300 galeotti, 1250 picche.
Cosa del tutto rispettabile se si tien conto dell'antichità dei castelli, rabberciati alla meglio per paura dei Turchi, e di guarnigioni nominali, certo più che sufficienti ad imporre pioveghi (cioè corvée), tasse e altro ad una masnada impaurita, inadatta alle armi, come dovevano essere i contadini.
La preoccupazione dei nobili è puntigliosamente annotata da Francesco di Strassoldo il quale, parlando dei contadini, scrive: «hanno inter caetera dicto et usate alcune nefandissime e diaboliche parole massime de tagliar a pezzi prelati, zentilhomeni, castellani, et cittadini, et denique de far uno vespro cicilian [...]».
L'aria era agitata da condizioni molto precise: la questione delle migliorie sui mansi. I proprietari dovevano rifondere gli affittuari delle spese sostenute, che, a volte, eccedevano il valore del fondo stesso.
Nel 1503 il Parlamento della Patria aveva fatto pendere la bilancia dalla parte dei proprietari, aggiungendo poi, come una sorta di minacciosa spada di Damocle, che il Comune rustico sarebbe stato responsabile di possibili danni determinati da atteggiamenti di protesta o ribellione. Non si vede come un Parlamento così costituito avrebbe potuto legiferare diversamente (il giovane avvocato Karl Marx esordì proprio con un argomento non del tutto dissimile, a proposito della legge sui furti di legna, dove sosteneva la tesi che era assai improbabile che dei giudici, figli di proprietari di boschi, fossero in grado di essere «oggettivi» di fronte ai furti nei boschi), resta il fatto che tutto ciò consolidò definitivamente il peso del «partito veneziano».
Il Devoto dice, nel suo Dizionario della lingua italiana: «partito. Diviso [...] o con l'idea di un frazionamento accentuato spec. sul piano politico o civile [...]e cita Dante «Li cittadin della città partita».
Ora, l'idea di partito che accompagna il nostro andamento sociale, non è certo la più adatta a farci comprendere il concetto di partito in uso nel XVI secolo. Non vi è somiglianza di sorta fra i due termini tranne, forse, nella comune adesione al trasformismo, anche se, una maggior radicalizzazione dello scontro fino all'eliminazione fisica dell'avversario, rendeva più difficile, anche se non impossibile, un passaggio armi e bagagli dall'altra parte (e proprio lo stesso Antonio Savorgnan di cui si parla, pochi mesi dopo quel Giovedì grasso, passerà agli imperiali, finendo poi ucciso per mano di non dimentichi avversari).
Sarà proprio un Furlano di quei tempi a dire, a giustificazione dell'uccisione di un avversario: «omo morto non fa guerra».
I nomi dei due partiti sono di origine confusa, strumîrs e zambarlàns, «strumieri» e «zambarlani». Abbiamo già accennato alle definizioni approssimative di ghibellini e guelfi, che, in qualche modo, possono dare una vaga idea del complesso intreccio di questi «partiti» che partiti non erano, e che governavano, o meglio controllavano, strati notevoli della città e delle campagne. Sappiamo che, per distinguersi bene gli uni dagli altri, i simpatizzanti delle due parti portavano piume sui cappelli, erbe sulle scarpe e fiori.
La tensione aumentava in continuazione. Questi versi ne sono una testimonianza eloquente:
Raibe stizze velen el maal mazuch
Mal di sclese e di sclop lancuur faiaal
La madreule el madron e ogni maal
Ai Signors e in tiri in t'un scrusup.
Rabbia rogna veleno il mal caduco / mal di scheggia e di vermi / crepacuore e malanno senza cura / il tappo al culo l'ipocondria e ogni male / ai Signori, e che gli capiti in una catapecchia.
Dove aleggia un'aura impalpabile e maleodorante, che sa di evocazione, di «preento», di scongiuro, d'invettiva e di maledizione, di odio gridato a squarciagola e con irrefrenabile violenza, un odore di morte i cui miasmi salgono dalle campagne e dalle città, dove nobili spaventati e incarogniti sostano, pernottano, vigilano assieme a servi e seguaci e bravi, guardando gli uni le case asserragliate degli altri, ascoltando i brusii che salgono dalle strade e che superano gli alti muri e provengono da altre strade, da braide all'apparenza deserte e percorse dal gelido e omicida vento di febbraio, dove i colori dei panni dei gonfaloni e dei pennoni sembrano funesti presagi, scricchiolanti per il ghiaccio che li artiglia.
Sono i giorni in cui per la prima volta il sole rivolge indietro i suoi passi e l'ora della sera, suonata con quel lugubre lamento che han le campane delle chiese nei giorni che inclinano lividi verso sere furtive, s'allontana impercettibilmente. Febbraio è il peggiore dei mesi, “Fevrarùt piés di dut, ma già 'e Pifanìe un pît di strie” (all'Epifania un piede di strega, i giorni, cioè, crescono impercettibili come i piedi delle streghe).
Dentro il palmo del destino premeva il sangue, e dietro s'agitava già per le viscere della terra brontolando il terremoto, e dietro ancora, in letargo, i bacilli della peste stavano per schiudersi.
«Li poveri castelani tuti stavano neli loro casteli cum grande temerosità, dubitando de non eser tagliati a pezi deli vilani e abrusati.» Spaventati, alzavano la voce i castellani, e uno degli uomini della famiglia di punta, contraria ai Savorgnan, Alvise della Torre, risponde ai signori di Spilimbergo che lo informavano d'avere uomini pronti — arroganza della paura o della certezza? — «ve avisemo, che quella bestia de Antonio Savorgnan [...] era posto in tanta fuga, che non ardiva monstrar lo volto».
Intanto in questo clima da fine del mondo, le osterie erano piene, la gente si voleva divertire ad ogni costo, quasi avesse sentore che ogni cosa stava per chiudersi con lo scricchiolio sinistro della bara, e tutti volevano ballare e darsi al gioco. C'era un proverbio, un modo di dire che circolava e che ha nella sua elementare assonanza un cupo rimbombo: «Godi, vivi, squacquera e non pagar mai zacchera».
Il 26 febbraio, Antonio Savorgnan raccolse a Caprigli, cioè a Chiavris, alle porte nord della città, più di duemila villani. Egli aveva detto loro (almeno così riferisce il canonico Agostino di Colloredo in una sua cronaca) che i castellani si erano messi d'accordo con gli imperiali e che avrebbero consegnata la Patria a questi. Poi egli, circondato da una schiera di amici, Nicolò Chiribin, Nicolò Zanni de Cortona, Francesco Janis de Tolmezzo,
Riccardo de Fontanabona, Zuan Francesco Torso, Odorico Susanna, era entrato in città e aveva parlato agli zambarlani della città, agli amici che aveva nell'Arengo e li aveva incitati ad unirsi nella causa comune, aveva poi detto a questi: «Queste sono tutte le casade suspecte et rebelle: tutte le casade de Colloreto, excepto messer Camillo, et quelli de Mels; tutti li Strassoldi, excepto messer Zuanne; le casade delli Candidi, le casade deli Gorghi, tutte le casade de Zucco, Cucagna et Partistagno, le casade de Bertulini [...]» .
Intanto, alla spicciolata, mascherati per il carnevale, armati, i volti dipinti e le insegne del partito zambarlano bene in vista, i contadini entravano in città, creavano scompiglio, gridavano «Savorgnan, Savorgnan» (e, con ogni probabilità, visto che tutte le cronache sono dell'altra parte, grida marchesche), s'azzuffavano con membri del partito avversario. Il luogotenente generale se ne sta imbarazzato e perplesso in Castello.
In seguito si vedrà, dall'inchiesta fatta fare dal Senato, che, se non aperta istigazione e determinazione a procedere in tal senso, un certo favoreggiamento ci dovette essere. Non poteva certo sfuggire, a chi ben sapeva la gravità della situazione, cosa potevano significare centinaia di furibondi contadini che, entrando in città, si mescolavano a riottosi popolani, a poveri, ad avventurieri.
Nel pomeriggio del 27 la situazione precipita. La gente «dabbene» si tappa in casa, spranga porte e finestre e attende. I della Torre e i loro seguaci, sparano archibugiate sulla folla che si avventa contro i portoni dei loro palazzi. Un misterioso cannone, tratto a forza dal Castello (ma si può portar via un cannone dai muri di una fortezza che è sede della massima autorità politica e militare di Venezia, senza che questa intervenga?), mentre suonano a martello le campane e anche quella, simbolica ed emblematica, dell'Arengo, viene portato e messo in posizione davanti al portone principale.
Ai primi colpi la barriera di legno cade, e la massa si precipita dentro.
Altri palazzi, intanto, vengono assaliti e messi a sacco. Coloro che fuggono, braccati, ricercati, e uccisi. Più di 20 palazzi e case «de le miglior de la terra», saccheggiati. Fuggendo, perdono la vita tre della Torre, Alvise, Nicolò, Isidoro, due dei Colloredo, (Teseo e Federico), e poi Leonardo della Frattina, Apollonio Gorgo. Altri riescono a fuggire, a nascondersi in case insospettabili. Intanto il palazzo della Torre comincia a bruciare. Le fiamme, nitide e crepitanti, in un giorno livido di febbraio che già inclinava alla sera, salivano al cielo mentre dalle finestre piovevano cassapanche, sedie, argenterie, piatti, indumenti, cibi. Le strade di quella crudele “zoiba grassa” si riempivano di maschere che portavano trofei insanguinati e di maschere che erano mascherate da nobili con gli abiti tolti ai morti o rubati. Mai rovesciamento dei ruoli era stato meno simbolico e più realistico, mai gioco dell'inversione delle parti, più cruento.
Alla fine della prima giornata, mentre allegra la fiamma rischiarava le strade — una notte da Turchi — e i villani con i loro alleati popolani riempivano le osterie o s'addormentavano al riparo di qualche muro, in qualche braida, Antonio Savorgnan e i suoi amici potevano, forse, ritenere di ver saldato il conto e di essere in grado di presentare alla Serenissima un gradevole «fatto compiuto», da deprecare formalmente.
Il giorno dopo il carnevale riprende, suscitando sempre di più la preoccupazione del luogotenente generale che se ne sta sempre chiuso in castello, pare per mancanza di truppe.
Il problema è che innescare una rivolta di contadini non è la stessa cosa che pagare dei mercenari e degli attaccabrighe affinché facciano da agenti provocatori, pronti a scomparire ad un cenno dell'ufficiale pagatore.
Il Lutero, soddisfatto dell'aiuto contadino alla causa della Riforma, non lo è più poco tempo dopo, tanto che è spaventato «della plebaglia impazzita dei contadini» al punto di fare un appello ai nobili affinché ognuno di essi «percuota, ferisca, sgozzi, uccida come se fossero cani arrabbiati [...]».
Nella complessa articolazione di un grande moto sociale, il meccanismo di scatto è poco importante, ma, una volta partito il segnale, la fiammata della rivolta di «classe» non ha più bisogno di incitamenti, né il cessate il fuoco ha senso.
L'erba secca brucia e la sua traccia corre attraverso i campi, passa le colline, guada i fiumi, investe i punti cardinali e li fa ruotare come impazziti.
La notizia arriva alle campagne e, subito, bande di contadini cominciano a riunirsi, a mormorare frasi sediziose, a muoversi verso i castelli per dare alle fiamme, sicuramente, quella parte dell'edificio dove i pazienti gastaldi avevano raccolto le loro infernali carte in cui erano segnati debiti, contratti, affitti, possessi, pretese, giudizi.
Stupendissimi disordini
La domenica, come nota Girolamo Sini, «il popolo di S. Daniele, spinto dalle vessazioni dei Nobili, appiccò il fuoco al Castello con danno notabile». Il giorno dopo è assaltato il castello di Spilimbergo.
Un Colloredo scrive: «et li villani de tutte le ville fin a Sacil levati in arme contra li castelli a sachizarli et brusarli et dove non li fo fatta resistentia entrarono in dicti castelli [...] ita che fin a Sacil tutti i villani era in arme a tal effetto [...]». Naturalmente la tesi è che sono i partigiani di Antonio Savorgnan a sobillarli. In ogni modo «et durò sette zorni questa furia».
Intanto l'ondata s'abbatte sui castelli di Villalta, Brazzacco, Arcano, Cergnacco, Susans, Colloredo, Caporiacco, Tarcento, Fagagna, Moruzzo, Zoppola, Cusano, Varmo, Valvasone, Salvarolo.
Il signor di Cergneu, che vive realisticamente del lavoro dei suoi contadini, ma che è legato ancora ai Paladini di Francia, racconta sbalordito le «orrende cose che a narrar restano».
I nobili del castello di Sterpo, rocca assai forte, di roba piena, hanno la dabbenaggine di calare il ponte levatoio per parlamentare e i contadini, che nulla sanno di Orlando e di Artù, irrompono nel castello.
E poi, il virtuoso signore di Cergneu esclama: «Dirò de mi, a quali il castello nostro Cergnacco fu depredato e ruinato; da chi? dalli nostri massari del loco medesmo, de quali alcune non era, che debitor non fusse de più de cinque fitti scorsi de resti [...]».
Intanto gli echi si propagano. Altro che mene di un Savorgnan, altro che intrallazzi, baruffe e plagiati villani: «fumo le persecuzioni in questa parte superiore de l'Alemagna a noi vicina, fumo nell'Ongaria dove adunati erano più di sedici millia villani a ruina de' nobili; e tutto in poco tempo [...]».
La storia scritta dai contadini non esiste e tutte le cronache sono piene dell'orrore di un castellano o di un benestante, così non sappiamo niente di quegli uomini, di quelle masse oscure «senza storia». C'è un silenzio assoluto. Pare che una massa anonima e bestiale, di locuste e di formiche, improvvisamente impazzita, ingrata verso chi sempre l'aveva aiutata, si sia messa a mordere la mano generosa che sempre aveva dato.
Nemmeno un oscuro cavaliere che potesse interessare un Goethe.
E il momento in cui appare necessaria un'azione rapida, prima che il male dilaghi.
Il luogotenente pare scuotersi dal suo strano torpore: chiede aiuti. Dall'Isonzo, dove contrastano gli imperiali, accorrono Baldassare Scipione da Siena con 80 cavalli leggeri, Battista Mirandola Vicentino con 50, Camillo Malfatto con 100 cavalli e 50 fanti.
E i nobili fecero campo insieme e scomenzorno a mazzar villani
60 cavalieri si riuniscono a Porcia assieme a soldati e borghesi di Pordenone e fanno a pezzi una colonna di 2000 contadini, ne uccidono un centinaio e uno lo impiccano a Zoppola. Lo scontro avviene sul greto del Cellina.
Una colonna contadina che si muove verso Codroipo viene intercettata da Andrea Loredan, del Consiglio dei Dieci, che stava accorrendo da Venezia alla notizia dei fatti friulani, la disperde, e a Codroipo è costretto a intervenire di nuovo.
Ciò il 5 marzo. Il 30, però, Sanudo, nei suoi Diarii annota che i villani stanno assaltando il castello di Porpetto.
Il primo giorno di Quaresima Loredan è a Udine e tenta di aggiustare la situazione. E’ amico di Antonio, e si muove con quella lentezza che in politica vuoi dire, oggi, insabbiamento. La cosa è nota alla nobiltà friulana. L'assoluzione da ogni responsabilità, e la conferma a capo delle cernide pare aver chiuso la questione, quando, in settembre, il Consiglio dei Dieci lo condanna, ma in segreto, a morte.
Egli ha ancora degli amici, ma non basta e fugge in territorio imperiale.
La nobiltà, che non dimentica, lo fa controllare (però c'era una taglia di 5000 ducati sulla sua testa). L'anno seguente in marzo, lo individuano a Villacco. Partono per prenderlo Zuan Enrico di Spilimbergo, Girolamo di Colloredo, Zuan di Zoppola. Secondo la cronaca del Canonico Agostino di Colloredo, gli tendono un agguato presso il cimitero della città austriaca, uccidono uno dei famigli, feriscono altri, e spaccano la testa ad Antonio, che resta a terra che ancora respira e non può più parlare. Viene un cane grosso che gli mangia il cervello. «Perché non si deve credere che Dio non fusse justo iudice.»
Qualunque sia il giudizio, certo fu uomo abile, di grande capacità politica, si collegò alla borghesia cittadina, protesse gli Ebrei. Nel panorama non esaltante della nobiltà del tempo, Antonio, e Girolamo, generale di talento, e Giulio, l'architetto di Palmanova, danno a questa famiglia una notevole vivacità e capacità che giustificano il peso preponderante avuto nella storia della Patria e di Udine.
Dalle stime fatte sui danni subiti, per quanto possano essere gonfiati per vari motivi, certo l'entità del disastro appare già in una notevole dimensione. I Torriani denunciano più di 50.000 ducati, Gerolamo di Colloredo 16.670, Antonio di Brazzacco 10.270, Giovanni Saldonieri 10.000, i Valvason 5.106, un Odoardo di Spilimbergo 2000 ducati solo per biancheria e vasellame, 600 per derrate, oltre a denunciare il furto o la distruzione di 300 staia di frumento, 400 orci di vino, eccetera.
Il 26 marzo, quando ancora la Patria era agitata da simili terribili disordini, la terra tremò. Erano le 8 di sera, il castello barcollò sotto le scosse e poi rovinò nella polvere, la chiesa di S. Maria si spaccò e il vecchio campanile non resistendo, s'inginocchiò.
E poi l'ala della peste s'alzò da quella polvere. «E ne seguitava stupendissimi disordini e calamità, cadendo de multi a terra sì de fame che peste, sentendose exlamar et ulular de zorno et de nocte le misere persone et fanciulli [...]».
Un terzo dei cittadini di Udine moriva, e c'è chi parla di diecimila, e della Patria si sa solo che la tragedia fu immensa.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38318
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
Re: El parlamento furlan
Il lento ansimare del leone: dissoluzione
Panze piene no crót a panze ueide. Pancia piena non crede a pancia vuota (proverbio popolare friulano.)
La paura dei contadini genera la forma di un'istituzione che nella sua mancanza di sostanza rispecchia la paura: la Contadinanza
Venezia istituisce “La Contadinanza”
La grande paura terminò, ma restò la costanza della paura.
Appariva chiaro che il problema doveva essere affrontato, e altrettanto chiaro appariva che non era possibile affrontarlo. La caratteristica aristocratico-borghese di Venezia poneva la sua classe dirigente in una sorta di limbo ambiguo dal quale non era in grado di uscire.
L'ingresso in terraferma e una politica statuale, lo abbiamo già detto, trovarono una classe dirigente senza grandi prospettive. Il risultato fu negativo, perché segnò una lenta e progressiva rifeudalizzazione o nuova feudalizzazione della città, trasferendo ingenti capitali dal grande movimento del mercato Mediterraneo (certo in crisi per vari motivi, ma non ancora totalmente in crisi) alla rendita fondiaria e all'investimento in terre. Il Friuli, terra sterile o bisognosa di grandi movimenti di capitale per bonifiche, proprio là dove la terra era buona, non interessò subito la nobiltà veneta.
Restavano questi contadini così ottusi, così deferenti, e nello stesso tempo così rozzi e litigiosi, bestemmiatori e ubriaconi, tanto che i due secoli sono tappezzati di grida contro la bestemmia, la rissa, la frequenza nelle osterie, così religiosi in maniera pagana da suscitare l'interesse professionale del Sant'Uffizio, legati alla terra e alle streghe, alle piante e agli esseri sovrannaturali, tranquilli sotto signori dalla mano pesante e poi, improvvisamente, posseduti da uno spirito di ferocia e di violenza che annullava i giudizi precedentemente e incautamente dati.
Il contadino insomma restava, accanto al grano e all'uva, al bestiame e al legname, un semplice accessorio della terra, un animale cum vocale, ma il cui urlo di rivolta ancora rimbalzava nei saloni dei palazzi di governo, ingenerando inquietudini costanti e permanenti.
Il modo in cui i vari governi europei avevano risolto il problema contadino — in ciò concordavano cattolici e protestanti, ortodossi e musulmani — era stato duro, violento e radicale. Nessuna trattativa, nessuna promessa — se mai vaghi accenni a perdoni, raramente mantenuti — nessun accordo. Non esisteva soluzione politica, esisteva solo una soluzione militare o poliziesca a seconda dell'entità della protesta.
Nella sua logorante e ovattata prudenza, la Serenissima pervenne ad una conclusione che oggi definiremmo «gattopardesca». Si trattava di dare senza dare, di offrire qualcosa di assoluta inconsistenza nella sostanza, ma formalmente così colorata da far credere il contrario, un'armatura vuota, un cavaliere inesistente, un palazzo che aveva l'apparenza del potere.
Ciò non è nuovo sotto il sole dei secoli, ma è singolarmente nuovo per quel periodo, tanto che fa meraviglia che una siffatta creazione dell'arte del sembrare, tipica del secolo che annuncia il manierismo e avanza facendo sudare i fuochi dell'immaginazione, il secolo del Bembo, dell'Aretino, del 'Castiglione, ma anche di Machiavelli, Guicciardini (ogni cosa è pregna del suo contrario), creazione di ingegneria politica altamente simbolica e affascinante, possa essere sfuggita all'interesse degli studiosi di storia d'Italia, di storia delle istituzioni e, specialmente, di storia sociale. La creazione della Contadinanza dovrebbe essere minutamente studiata perché costituisce un atto di notevole intelligenza politica, qualcosa che oggi può essere capito benissimo.
Scontentando i nobili quel tanto che bastava per punirli della loro irritante ostilità, e accontentando i contadini quel tanto che dava la sensazione di aver riparato torti del passato — quali non era detto, ma era sottinteso e ammiccato —, creava interessi verso possibilità di una maggior comprensione e ascolto da parte delle autorità, comprensione e ascolto che, pur essendo raccolte nella Patria, andavano proprio nel centro del Potere di San Marco.
Potenza della fantasia, fantasia della legge.
Il fatto è che i contadini, alla ricerca di un'ala protettrice (la ricerca della classe, la ricerca dell'identità, dell'essere in sé o per sé non era certamente un problema di quell'epoca) erano marcheschi istintivamente.
Le acute osservazioni del Machiavelli e le realistiche annotazioni del Priuli nei Diarii, «hera molto meglio havere li contadini propitii per esser magior numero cha li citadini», lo confermano. A questo punto Venezia agisce rapidamente. L'operazione del Savorgnan le ha dato spazio di sicurezza fra i nobili, lo condanna, ma approfitta della situazione; nel 1513, liberatasi dagli imperiali, elimina l'Arengo, forma un Consiglio in cui i nobili sono 150 e 80 i popolari, togliendo spazio ad ogni possibile forma di controllo popolare, e istituisce la Contadinanza. Ciò avviene per gradi. Vengono stabiliti i meccanismi di questo organismo rappresentativo: 8 sindaci eletti dai decani dei paesi, 4 della Destra Tagliamento, 4 della Sinistra. C'erano due cassieri e un controllore. Avevano la possibilità di intervenire nella compilazione degli elenchi dei contribuenti, e sulla ripartizione delle spese militari. Potevano controllare il taglio dei boschi per l'Arsenale, e avevano in mano l'equipaggiamento delle cernide. Erano legalmente autorizzati a rappresentare le possibili lamentele dei contadini presso il governo della Repubblica.
Come prima mossa — lo zucchero che permane.,in bocca quando si mastica inutilmente per ore l'insipida gomma americana —, nel 1518 riuscirono a impugnare le misure stabilite dal Parlamento sui patti livellari e a ottenere dal governo la loro revoca. In realtà, poco era il potere iniziale e quasi nullo il potere nella lunga marcia del tempo che porterà la Contadinanza, come tutte le altre istituzioni della Patria, al redde rationem del generale Bonaparte.
Resta il fatto, come conclusione, che è e rimane l'unico esempio di soluzione politica e istituzionale di uno scontro di grande violenza, la cui soluzione fu, per ogni paese, uno scontro a morte.
Stiamo entrando in un periodo storico in cui, sempre più, nessuna società è un'isola fine a se stessa. Il crollo dei prezzi che investe la Spagna ha ripercussioni in ogni luogo del vecchio continente.
Quanto più Venezia vede diminuire le proprie capacità di espansione economica, tanto più abbandona un'economia mercantile per basarsi sulla rendita fondiaria, tanto più il suo peso fiscale si fa sentire in terraferma.
Le «colonie» di terraferma pagano gli ultimi splendori della Serenissima. Il Friuli paga per l'inutile fortezza di Palmanova, una linea Maginot di grande ingegno militare, ma un peso assolutamente inerte sul territorio, nel mentre ben 30.000 campi sono rimasti incolti per debiti, tasse e insolvenze varie.
All'inizio del secolo gli abitanti sono scesi, secondo calcoli abbastanza precisi, a 97 mila persone (nel 1596 erano 196.000), mentre Venezia spreme dal solo campatico nel 1636 la bella somma di 137.695 ducati.
I contadini sono fannulloni, beoni, non lavorano i campi, passano il tempo in «hostaria».
Nel 1622 si consumano in Friuli 40.000 conzi di vino (conzo di Udine, cuinz = litri 79,3045). Gli abitanti della Patria bestemmiano tanto che si è costretti a fare delle energiche esortazioni «contro bestemmiatori e scandalosi, e obbligo di denontiarli, e ritenerli» (6 marzo 1695, Luogotenente Duodo), e in seguito (11 marzo) «contro irriverenti alle Chiese e luoghi sacri». «Si eserciteranno li castighi conforme alle qualità degli eccessi, et delinquenti, con le pene cominate dalle Leggi del taglio della lingua, berlina, frusta, corda, prigione, galera, e bando.»
Si stanno allargando in maniera allarmante gli insulti alla religione (L, Accati riporta alcuni fatti accaduti nel Friuli del '600, là dove ricorda che «La strega e le maschere dileggiano il sacramento della penitenza: lo strumento con cui la Chiesa proprio in questi anni, cerca di penetrare e d'imporsi nelle campagne».
Allora le contromisure diventano sempre più stringenti: «[...] si riceveranno denunzie secrete, per le quali sono esposte le casselle, si procederà per via d'inquisizione ex offizio, e si faranno passi maggiori a misura degl'eccessi acciò tanto più esemplari, quanto più pesanti riescano li castighi de' delinquenti [...]».
La scarsa voglia di lavorare (o uno stato di sottoalimentazione permanente?), l'abbandono dei campi, la diffusione a macchia d'olio dei mendicanti, dei perdigiorno, degli imbroglioni diventano costanti elementi, indicatori di uno stato d'animo perturbato, agitato, incline alla credulità, alle fantasie, alle fantasticherie.
Forse non è un caso che un piccolo glossarietto, pubblicato a Ferrara nel 1640, Modo nuovo de intendere la lingua terga, alla lettera F la parola «Furlano» equivalga a «Menchione», cioè poco furbo (ma già nel '500 una strada di Udine aveva l'indicativo nome di «spelevilàn» e cioè «sbuccia, pela il villano»). E infatti i contadini erano i più soggetti agli imbrogli di tutti i tipi, compresi quelli dei falsi frati e dei falsi predicatori e dei venditori d'oggetti sacri.
«Povera gente? Però i loro giudici non erano povera gente, e neanche degli illetterati. Forse loro vedevano nelle storie dei lupi mannari più difficoltà che gli stregoni medesimi? Eh, no. Seguivano. Erano in balìa delle parole.» (L. Febvre, Il problema dell'incredulità del secolo xvr.)
L'apparenza è l'immobilità, un silenzio generale. Ma questo avviene perché le religioni delle classi popolari o subalterne sono state viste sempre nell'ottica di chi di esse scriveva. Per esse, come bene osserva Ginzburg, erano stabilite quattro categorie: il proposto, il prescritto, il tollerato, il proscritto.
In definitiva, potremmo dire con Burke che ci troviamo di fronte ad una miniera inafferrabile.
In realtà ci troviamo di fronte ad uno scontro senza precedenti fra cultura delle classi subalterne e cultura delle classi dominanti.
Il risultato sembra evidente, se l'accezione universalmente intesa di folklore è quella delle Pro-Loco, anche se vi è un lavoro molto difficile per riafferrare i fili di una tradizione di cui resta l'eco, o tessere di mosaico che galleggiano, prive della loro unità e ripetute nei paesi come eco di un'eco di cui si è perduta la ragione e la logica.
Fata morgana di morti modi di produzione?
Una spiegazione è difficile, non solo perché dobbiamo lottare con le stesse nostre perplessità e incredulità, ma proprio perché, come osserva De Martino «[...] sembra sfidare, col suo astorico riprodursi, qualunque orientamento storicistico inteso ad individuare svolgimenti irrepetibili nella storia umana, drammi vissuti una sola volta nella vita culturale».
Il fenomeno è troppo complesso per essere ridotto esclusivamente a mancanza di proteine.
Un'altra osservazione da fare, per evitare inutili interpretazioni con il senno di poi, è che la cultura e le religioni delle classi subalterne non sono e non volevano essere e non potevano essere, una cultura alternativa.
E una cultura, se si vuole, dei «vinti» e dei dominati, ma che mutua anche elementi della cultura delle classi dirigenti.
La morta gora della nobiltà
Il declino costante della nobiltà è un declino che trascina nella sua corrente, irrimediabilmente, Venezia e con essa il suo territorio. Ultimo lembo feudale, il Friuli non può far altro che seguirne il corso.
Per un quadro di tale situazione basterà che si prenda in mano la prima parte de “Le memorie di un italiano” di Ippolito Nievo. Imparentato con un'illustre casata friulana, visse a lungo in Friuli, tanto da conoscerne a fondo la realtà. Il mondo di Fratta è l'espressione tipica dello sfaldamento della società feudale alla vigilia della rivoluzione francese. Nessuno storico sarebbe in grado di dare «l'aura» di un corrompimento generale come questo grande romanzo. Ogni personaggio, nella sua tipicità, rappresenta la fine dei vecchi modi di produzione, modi la cui agonia proseguirà, si può dire, fino alle guerre del XX secolo.
Il costo della vita è in continuo aumento, e il cattivo stato della terra e dei contadini non contribuiscono certo ad aumentare il reddito che si va, di anno in anno, sempre più stringendo, man mano che ci si avvicina alla fine della Repubblica. Ma, nonostante le apparenze, si spende molto in feste e in doti. Alcune grandi famiglie continuano a spendere somme enormi per il prestigio.
Nel 1705 la famiglia Manin chiede al Comune di Udine la licenza per restaurare, a proprie spese, una parte del Duomo della città, di dilatare il Coro, d'introdurre due cappelle più grandi e cospicue, di rifar pitture, affreschi e di offrire, inoltre, un nuovo altare con baldacchino d'argento. I lavori cominciano nel 1714 e non erano ancora terminati il 18 aprile del 1735, giorno della solenne riconsacrazione. La nota spese dell'architetto Domenico Rossi, il 20 maggio 1713 dice: «Avertendo che il suddetto Conto non potrà essere esato [...]». La somma è di 32.108 ducati.
Gli Strassoldo chiamano il Quaglio a dipingere il loro palazzo, ora sede della Banca del Friuli; i Manin, mentre spendono tutti quei ducati per il Duomo, fanno edificare una cappella in città, e pensano alla loro villa di Passariano che è incominciata nel 1738.
I due ultimi patriarchi, Dionisio e Daniele Delfino rivaleggiavano con la nobiltà. Ultimi sprazzi prima del trasporto a Venezia del Patriarcato, dopo di che in Friuli resteranno due arcivescovadi, divisi fra Udine e Gorizia (come ultima grazia a Daniele Delfino fu concesso di godere fino alla morte del titolo di patriarca d'Aquileia). Dionisio fece costruire il nuovo palazzo patriarcale (ora arcivescovado) e fece venire il Tiepolo, che tornò, con il figlio, per Daniele Delfino che fece loro affrescare l'Oratorio della Purità.
Il decoro e la rappresentatività che la forma deve necessariamente esprime-re, come prima apparivano sotto forma di cavalli e anni, in questi due ultimi secoli compaiono sotto forma di feste, di giochi, di carrozze, di case di campagna che sempre più perdono la loro funzione di economia curtense, per diventare luoghi di villeggiatura, anche se in molti casi, come si può notare in tante ville venete, la vecchia funzione continua e si bada solo a separare con muri ed alberi la parte della produzione da quella scenografica dello spreco.
La villa Manin di Passariano rappresenta nella sua megalomane magnificenza, l'alto grado di sfruttamento cui sono soggetti i contadini.
Per quanto, già alla fine del '500, Camillo Tarello con il suo Ricordo d'agricoltura, avesse gettato le basi di una nuova maniera d'intendere il rapporto con la terra (nel '700 sarà letto e seguito da intelligenti proprietari terrieri inglesi, francesi, olandesi), e per quanto, oltre a nuove tecniche, avesse intuito i risultati sociali che ne avrebbero potuto scaturire: «rimovendo la causa, ch'è la povertà, radice d'infiniti mali, si rimoveranno anco gli effetti dei moltissimi mali che si fanno [...]» , le cose resteranno sostanzialmente immote, tranne, forse, nel Friuli austriaco, dove le riforme di Maria Teresa cominciavano a dare i loro frutti.
Il gravame feudale era stato alleggerito, i commerci liberati da anacronistici legami, l'agricoltura aveva avuto un certo rilancio, le zone paludose di Aquileia, che ora apparteneva all'impero, erano avviate a bonifica.
Ma il Friuli veneto, immoto, galleggiava nelle paludi.
Di questo paese si potrà dire quel che dice Bruto nel Giulio Cesare di Shakespeare: «Vi è una marea nelle cose umane la quale, se colta al flusso, mena al successo; se invece è negletta, tutto il viaggio della loro vita resta arenato nei bassifondi e nelle disgrazie». Il risultato di tale modo di essere sarà che, verso la fine del '600, solo il 3% della terra sarà in conduzione diretta, mentre il 57,5 sarà in affittanza in natura, oppure in natura e moneta, e il 13% sarà in moneta.
Alla metà del '700, poco prima della caduta, i possessi di nobiltà e grossa borghesia veneziana in Friuli passeranno da 23.360 ettari nel 1636, a 62.630 ettari nel 1740.
E la nobiltà, tranne le eccezioni, sarà quella che nel 1773 il Canciani descriverà in una memoria vincitrice del premio della Società d'Agricoltura di Udine (per una sorta d'ironia, la seconda in Italia dopo quella dei Georgofili di Firenze): «[..a] ma finché i proprietari delle terre misureranno la loro grandezza dalla pompa con che vanno vestiti, dall'equipaggio che li circonda e dal potere in ozio godere di certi privilegi e finché essi disprezzano il resto della popolazione che nelle nostre campagne fa professione di fatica e travaglio». La storia va, o meglio, la storiografia va, a passi cauti. Spesso succede che una nuova documentazione, emersa dagli archivi (e ai metodi puntigliosi di pazienti studiosi deve andare la riconoscenza di tutti, da chi, come chi scrive, si avvale del loro lavoro, a chi, alla foce, legge della storia) scompagini idee fissate da molto tempo, luoghi comuni che a volte sono veri, a volte si reggono su vecchie e superate letture. Così non può passare sotto silenzio l'opinione di uno storico francese, Geogelin, riportata in un interessante libro di Bianco Nobili castellani, comunità, sottani, in cui sembra emergere una certa capacità imprenditoriale e una notevole volontà di «capire», di certa nobiltà agraria di terraferma veneta.
E indubbiamente, «alcuni» nobili e borghesi, dando vita a Udine, nel 1762 alla Società di agricoltura pratica (abbiamo già detto che fu la seconda in Italia) e a Gorizia, nel 1765, su impulso dell'imperatrice Maria Teresa, alla Società Agraria, danno la sensazione di muoversi. I Savorgnan danno inizio ad una bonifica nel 1690 a Tor di Zuìn (oggi Torviscosa), nel '700 si bonificano zone nella bassa friulana, a Porpetto, Paradiso, Fraforeano, dove s'inizia anche una rotazione frumento-riso. Un Linussio sviluppa un'intensa attività industriale, concentrandola sulla lavorazione del lino (quasi 38.000 pezze nel 1755), Zanon e Zamparo danno inizio alla lavorazione della seta impiantando due filatoi a Udine. Il conte Asquini sperimenta la patata.
Ma la sostanza non cambia. Come si suoi dire, le eccezioni confermano la regola. Giustamente Ellero riporta una citazione del vecchio, illuminato e straordinario Antonio Zanon di cui si parlerà più oltre: «[l'agricoltura] [...] totalmente abbandonata dall'ignorante padrone all'ignorante agricoltore, il quale altro non sa che le sciocche tradizioni di un suo avo ugualmente ignorante».
E opinione diffusa fra gli stessi illuminati scrittori dell'epoca che la condizione generale della campagna fosse disastrosa. Rota scrive nel 1806: «generalmente il contadino è povero, vilipeso, abbandonato e miserabile. Gli affitti non hanno veruna norma, l'infingardaggine dei proprietari e dei fattori [...]».
Ma la condizione umana è osservata dallo Zanon in maniera «indiretta» e perciò, forse, complessivamente e psicologicamente più pregnante. Certo, in questa breve frase parla di una zona precisa, l'arida pianura che da Udine, sopra la linea delle risorgive, e lungo i colli morenici, va verso le infinite ghiaie del Tagliamento, ma il «clima» che evoca non si può facilmente scordare: «Taluni [contadini] invecchiano senza aver assaggiato appena un sorso di vino o un frutto [...]».
Panze piene no crót a panze ueide. Pancia piena non crede a pancia vuota (proverbio popolare friulano.)
La paura dei contadini genera la forma di un'istituzione che nella sua mancanza di sostanza rispecchia la paura: la Contadinanza
Venezia istituisce “La Contadinanza”
La grande paura terminò, ma restò la costanza della paura.
Appariva chiaro che il problema doveva essere affrontato, e altrettanto chiaro appariva che non era possibile affrontarlo. La caratteristica aristocratico-borghese di Venezia poneva la sua classe dirigente in una sorta di limbo ambiguo dal quale non era in grado di uscire.
L'ingresso in terraferma e una politica statuale, lo abbiamo già detto, trovarono una classe dirigente senza grandi prospettive. Il risultato fu negativo, perché segnò una lenta e progressiva rifeudalizzazione o nuova feudalizzazione della città, trasferendo ingenti capitali dal grande movimento del mercato Mediterraneo (certo in crisi per vari motivi, ma non ancora totalmente in crisi) alla rendita fondiaria e all'investimento in terre. Il Friuli, terra sterile o bisognosa di grandi movimenti di capitale per bonifiche, proprio là dove la terra era buona, non interessò subito la nobiltà veneta.
Restavano questi contadini così ottusi, così deferenti, e nello stesso tempo così rozzi e litigiosi, bestemmiatori e ubriaconi, tanto che i due secoli sono tappezzati di grida contro la bestemmia, la rissa, la frequenza nelle osterie, così religiosi in maniera pagana da suscitare l'interesse professionale del Sant'Uffizio, legati alla terra e alle streghe, alle piante e agli esseri sovrannaturali, tranquilli sotto signori dalla mano pesante e poi, improvvisamente, posseduti da uno spirito di ferocia e di violenza che annullava i giudizi precedentemente e incautamente dati.
Il contadino insomma restava, accanto al grano e all'uva, al bestiame e al legname, un semplice accessorio della terra, un animale cum vocale, ma il cui urlo di rivolta ancora rimbalzava nei saloni dei palazzi di governo, ingenerando inquietudini costanti e permanenti.
Il modo in cui i vari governi europei avevano risolto il problema contadino — in ciò concordavano cattolici e protestanti, ortodossi e musulmani — era stato duro, violento e radicale. Nessuna trattativa, nessuna promessa — se mai vaghi accenni a perdoni, raramente mantenuti — nessun accordo. Non esisteva soluzione politica, esisteva solo una soluzione militare o poliziesca a seconda dell'entità della protesta.
Nella sua logorante e ovattata prudenza, la Serenissima pervenne ad una conclusione che oggi definiremmo «gattopardesca». Si trattava di dare senza dare, di offrire qualcosa di assoluta inconsistenza nella sostanza, ma formalmente così colorata da far credere il contrario, un'armatura vuota, un cavaliere inesistente, un palazzo che aveva l'apparenza del potere.
Ciò non è nuovo sotto il sole dei secoli, ma è singolarmente nuovo per quel periodo, tanto che fa meraviglia che una siffatta creazione dell'arte del sembrare, tipica del secolo che annuncia il manierismo e avanza facendo sudare i fuochi dell'immaginazione, il secolo del Bembo, dell'Aretino, del 'Castiglione, ma anche di Machiavelli, Guicciardini (ogni cosa è pregna del suo contrario), creazione di ingegneria politica altamente simbolica e affascinante, possa essere sfuggita all'interesse degli studiosi di storia d'Italia, di storia delle istituzioni e, specialmente, di storia sociale. La creazione della Contadinanza dovrebbe essere minutamente studiata perché costituisce un atto di notevole intelligenza politica, qualcosa che oggi può essere capito benissimo.
Scontentando i nobili quel tanto che bastava per punirli della loro irritante ostilità, e accontentando i contadini quel tanto che dava la sensazione di aver riparato torti del passato — quali non era detto, ma era sottinteso e ammiccato —, creava interessi verso possibilità di una maggior comprensione e ascolto da parte delle autorità, comprensione e ascolto che, pur essendo raccolte nella Patria, andavano proprio nel centro del Potere di San Marco.
Potenza della fantasia, fantasia della legge.
Il fatto è che i contadini, alla ricerca di un'ala protettrice (la ricerca della classe, la ricerca dell'identità, dell'essere in sé o per sé non era certamente un problema di quell'epoca) erano marcheschi istintivamente.
Le acute osservazioni del Machiavelli e le realistiche annotazioni del Priuli nei Diarii, «hera molto meglio havere li contadini propitii per esser magior numero cha li citadini», lo confermano. A questo punto Venezia agisce rapidamente. L'operazione del Savorgnan le ha dato spazio di sicurezza fra i nobili, lo condanna, ma approfitta della situazione; nel 1513, liberatasi dagli imperiali, elimina l'Arengo, forma un Consiglio in cui i nobili sono 150 e 80 i popolari, togliendo spazio ad ogni possibile forma di controllo popolare, e istituisce la Contadinanza. Ciò avviene per gradi. Vengono stabiliti i meccanismi di questo organismo rappresentativo: 8 sindaci eletti dai decani dei paesi, 4 della Destra Tagliamento, 4 della Sinistra. C'erano due cassieri e un controllore. Avevano la possibilità di intervenire nella compilazione degli elenchi dei contribuenti, e sulla ripartizione delle spese militari. Potevano controllare il taglio dei boschi per l'Arsenale, e avevano in mano l'equipaggiamento delle cernide. Erano legalmente autorizzati a rappresentare le possibili lamentele dei contadini presso il governo della Repubblica.
Come prima mossa — lo zucchero che permane.,in bocca quando si mastica inutilmente per ore l'insipida gomma americana —, nel 1518 riuscirono a impugnare le misure stabilite dal Parlamento sui patti livellari e a ottenere dal governo la loro revoca. In realtà, poco era il potere iniziale e quasi nullo il potere nella lunga marcia del tempo che porterà la Contadinanza, come tutte le altre istituzioni della Patria, al redde rationem del generale Bonaparte.
Resta il fatto, come conclusione, che è e rimane l'unico esempio di soluzione politica e istituzionale di uno scontro di grande violenza, la cui soluzione fu, per ogni paese, uno scontro a morte.
Stiamo entrando in un periodo storico in cui, sempre più, nessuna società è un'isola fine a se stessa. Il crollo dei prezzi che investe la Spagna ha ripercussioni in ogni luogo del vecchio continente.
Quanto più Venezia vede diminuire le proprie capacità di espansione economica, tanto più abbandona un'economia mercantile per basarsi sulla rendita fondiaria, tanto più il suo peso fiscale si fa sentire in terraferma.
Le «colonie» di terraferma pagano gli ultimi splendori della Serenissima. Il Friuli paga per l'inutile fortezza di Palmanova, una linea Maginot di grande ingegno militare, ma un peso assolutamente inerte sul territorio, nel mentre ben 30.000 campi sono rimasti incolti per debiti, tasse e insolvenze varie.
All'inizio del secolo gli abitanti sono scesi, secondo calcoli abbastanza precisi, a 97 mila persone (nel 1596 erano 196.000), mentre Venezia spreme dal solo campatico nel 1636 la bella somma di 137.695 ducati.
I contadini sono fannulloni, beoni, non lavorano i campi, passano il tempo in «hostaria».
Nel 1622 si consumano in Friuli 40.000 conzi di vino (conzo di Udine, cuinz = litri 79,3045). Gli abitanti della Patria bestemmiano tanto che si è costretti a fare delle energiche esortazioni «contro bestemmiatori e scandalosi, e obbligo di denontiarli, e ritenerli» (6 marzo 1695, Luogotenente Duodo), e in seguito (11 marzo) «contro irriverenti alle Chiese e luoghi sacri». «Si eserciteranno li castighi conforme alle qualità degli eccessi, et delinquenti, con le pene cominate dalle Leggi del taglio della lingua, berlina, frusta, corda, prigione, galera, e bando.»
Si stanno allargando in maniera allarmante gli insulti alla religione (L, Accati riporta alcuni fatti accaduti nel Friuli del '600, là dove ricorda che «La strega e le maschere dileggiano il sacramento della penitenza: lo strumento con cui la Chiesa proprio in questi anni, cerca di penetrare e d'imporsi nelle campagne».
Allora le contromisure diventano sempre più stringenti: «[...] si riceveranno denunzie secrete, per le quali sono esposte le casselle, si procederà per via d'inquisizione ex offizio, e si faranno passi maggiori a misura degl'eccessi acciò tanto più esemplari, quanto più pesanti riescano li castighi de' delinquenti [...]».
La scarsa voglia di lavorare (o uno stato di sottoalimentazione permanente?), l'abbandono dei campi, la diffusione a macchia d'olio dei mendicanti, dei perdigiorno, degli imbroglioni diventano costanti elementi, indicatori di uno stato d'animo perturbato, agitato, incline alla credulità, alle fantasie, alle fantasticherie.
Forse non è un caso che un piccolo glossarietto, pubblicato a Ferrara nel 1640, Modo nuovo de intendere la lingua terga, alla lettera F la parola «Furlano» equivalga a «Menchione», cioè poco furbo (ma già nel '500 una strada di Udine aveva l'indicativo nome di «spelevilàn» e cioè «sbuccia, pela il villano»). E infatti i contadini erano i più soggetti agli imbrogli di tutti i tipi, compresi quelli dei falsi frati e dei falsi predicatori e dei venditori d'oggetti sacri.
«Povera gente? Però i loro giudici non erano povera gente, e neanche degli illetterati. Forse loro vedevano nelle storie dei lupi mannari più difficoltà che gli stregoni medesimi? Eh, no. Seguivano. Erano in balìa delle parole.» (L. Febvre, Il problema dell'incredulità del secolo xvr.)
L'apparenza è l'immobilità, un silenzio generale. Ma questo avviene perché le religioni delle classi popolari o subalterne sono state viste sempre nell'ottica di chi di esse scriveva. Per esse, come bene osserva Ginzburg, erano stabilite quattro categorie: il proposto, il prescritto, il tollerato, il proscritto.
In definitiva, potremmo dire con Burke che ci troviamo di fronte ad una miniera inafferrabile.
In realtà ci troviamo di fronte ad uno scontro senza precedenti fra cultura delle classi subalterne e cultura delle classi dominanti.
Il risultato sembra evidente, se l'accezione universalmente intesa di folklore è quella delle Pro-Loco, anche se vi è un lavoro molto difficile per riafferrare i fili di una tradizione di cui resta l'eco, o tessere di mosaico che galleggiano, prive della loro unità e ripetute nei paesi come eco di un'eco di cui si è perduta la ragione e la logica.
Fata morgana di morti modi di produzione?
Una spiegazione è difficile, non solo perché dobbiamo lottare con le stesse nostre perplessità e incredulità, ma proprio perché, come osserva De Martino «[...] sembra sfidare, col suo astorico riprodursi, qualunque orientamento storicistico inteso ad individuare svolgimenti irrepetibili nella storia umana, drammi vissuti una sola volta nella vita culturale».
Il fenomeno è troppo complesso per essere ridotto esclusivamente a mancanza di proteine.
Un'altra osservazione da fare, per evitare inutili interpretazioni con il senno di poi, è che la cultura e le religioni delle classi subalterne non sono e non volevano essere e non potevano essere, una cultura alternativa.
E una cultura, se si vuole, dei «vinti» e dei dominati, ma che mutua anche elementi della cultura delle classi dirigenti.
La morta gora della nobiltà
Il declino costante della nobiltà è un declino che trascina nella sua corrente, irrimediabilmente, Venezia e con essa il suo territorio. Ultimo lembo feudale, il Friuli non può far altro che seguirne il corso.
Per un quadro di tale situazione basterà che si prenda in mano la prima parte de “Le memorie di un italiano” di Ippolito Nievo. Imparentato con un'illustre casata friulana, visse a lungo in Friuli, tanto da conoscerne a fondo la realtà. Il mondo di Fratta è l'espressione tipica dello sfaldamento della società feudale alla vigilia della rivoluzione francese. Nessuno storico sarebbe in grado di dare «l'aura» di un corrompimento generale come questo grande romanzo. Ogni personaggio, nella sua tipicità, rappresenta la fine dei vecchi modi di produzione, modi la cui agonia proseguirà, si può dire, fino alle guerre del XX secolo.
Il costo della vita è in continuo aumento, e il cattivo stato della terra e dei contadini non contribuiscono certo ad aumentare il reddito che si va, di anno in anno, sempre più stringendo, man mano che ci si avvicina alla fine della Repubblica. Ma, nonostante le apparenze, si spende molto in feste e in doti. Alcune grandi famiglie continuano a spendere somme enormi per il prestigio.
Nel 1705 la famiglia Manin chiede al Comune di Udine la licenza per restaurare, a proprie spese, una parte del Duomo della città, di dilatare il Coro, d'introdurre due cappelle più grandi e cospicue, di rifar pitture, affreschi e di offrire, inoltre, un nuovo altare con baldacchino d'argento. I lavori cominciano nel 1714 e non erano ancora terminati il 18 aprile del 1735, giorno della solenne riconsacrazione. La nota spese dell'architetto Domenico Rossi, il 20 maggio 1713 dice: «Avertendo che il suddetto Conto non potrà essere esato [...]». La somma è di 32.108 ducati.
Gli Strassoldo chiamano il Quaglio a dipingere il loro palazzo, ora sede della Banca del Friuli; i Manin, mentre spendono tutti quei ducati per il Duomo, fanno edificare una cappella in città, e pensano alla loro villa di Passariano che è incominciata nel 1738.
I due ultimi patriarchi, Dionisio e Daniele Delfino rivaleggiavano con la nobiltà. Ultimi sprazzi prima del trasporto a Venezia del Patriarcato, dopo di che in Friuli resteranno due arcivescovadi, divisi fra Udine e Gorizia (come ultima grazia a Daniele Delfino fu concesso di godere fino alla morte del titolo di patriarca d'Aquileia). Dionisio fece costruire il nuovo palazzo patriarcale (ora arcivescovado) e fece venire il Tiepolo, che tornò, con il figlio, per Daniele Delfino che fece loro affrescare l'Oratorio della Purità.
Il decoro e la rappresentatività che la forma deve necessariamente esprime-re, come prima apparivano sotto forma di cavalli e anni, in questi due ultimi secoli compaiono sotto forma di feste, di giochi, di carrozze, di case di campagna che sempre più perdono la loro funzione di economia curtense, per diventare luoghi di villeggiatura, anche se in molti casi, come si può notare in tante ville venete, la vecchia funzione continua e si bada solo a separare con muri ed alberi la parte della produzione da quella scenografica dello spreco.
La villa Manin di Passariano rappresenta nella sua megalomane magnificenza, l'alto grado di sfruttamento cui sono soggetti i contadini.
Per quanto, già alla fine del '500, Camillo Tarello con il suo Ricordo d'agricoltura, avesse gettato le basi di una nuova maniera d'intendere il rapporto con la terra (nel '700 sarà letto e seguito da intelligenti proprietari terrieri inglesi, francesi, olandesi), e per quanto, oltre a nuove tecniche, avesse intuito i risultati sociali che ne avrebbero potuto scaturire: «rimovendo la causa, ch'è la povertà, radice d'infiniti mali, si rimoveranno anco gli effetti dei moltissimi mali che si fanno [...]» , le cose resteranno sostanzialmente immote, tranne, forse, nel Friuli austriaco, dove le riforme di Maria Teresa cominciavano a dare i loro frutti.
Il gravame feudale era stato alleggerito, i commerci liberati da anacronistici legami, l'agricoltura aveva avuto un certo rilancio, le zone paludose di Aquileia, che ora apparteneva all'impero, erano avviate a bonifica.
Ma il Friuli veneto, immoto, galleggiava nelle paludi.
Di questo paese si potrà dire quel che dice Bruto nel Giulio Cesare di Shakespeare: «Vi è una marea nelle cose umane la quale, se colta al flusso, mena al successo; se invece è negletta, tutto il viaggio della loro vita resta arenato nei bassifondi e nelle disgrazie». Il risultato di tale modo di essere sarà che, verso la fine del '600, solo il 3% della terra sarà in conduzione diretta, mentre il 57,5 sarà in affittanza in natura, oppure in natura e moneta, e il 13% sarà in moneta.
Alla metà del '700, poco prima della caduta, i possessi di nobiltà e grossa borghesia veneziana in Friuli passeranno da 23.360 ettari nel 1636, a 62.630 ettari nel 1740.
E la nobiltà, tranne le eccezioni, sarà quella che nel 1773 il Canciani descriverà in una memoria vincitrice del premio della Società d'Agricoltura di Udine (per una sorta d'ironia, la seconda in Italia dopo quella dei Georgofili di Firenze): «[..a] ma finché i proprietari delle terre misureranno la loro grandezza dalla pompa con che vanno vestiti, dall'equipaggio che li circonda e dal potere in ozio godere di certi privilegi e finché essi disprezzano il resto della popolazione che nelle nostre campagne fa professione di fatica e travaglio». La storia va, o meglio, la storiografia va, a passi cauti. Spesso succede che una nuova documentazione, emersa dagli archivi (e ai metodi puntigliosi di pazienti studiosi deve andare la riconoscenza di tutti, da chi, come chi scrive, si avvale del loro lavoro, a chi, alla foce, legge della storia) scompagini idee fissate da molto tempo, luoghi comuni che a volte sono veri, a volte si reggono su vecchie e superate letture. Così non può passare sotto silenzio l'opinione di uno storico francese, Geogelin, riportata in un interessante libro di Bianco Nobili castellani, comunità, sottani, in cui sembra emergere una certa capacità imprenditoriale e una notevole volontà di «capire», di certa nobiltà agraria di terraferma veneta.
E indubbiamente, «alcuni» nobili e borghesi, dando vita a Udine, nel 1762 alla Società di agricoltura pratica (abbiamo già detto che fu la seconda in Italia) e a Gorizia, nel 1765, su impulso dell'imperatrice Maria Teresa, alla Società Agraria, danno la sensazione di muoversi. I Savorgnan danno inizio ad una bonifica nel 1690 a Tor di Zuìn (oggi Torviscosa), nel '700 si bonificano zone nella bassa friulana, a Porpetto, Paradiso, Fraforeano, dove s'inizia anche una rotazione frumento-riso. Un Linussio sviluppa un'intensa attività industriale, concentrandola sulla lavorazione del lino (quasi 38.000 pezze nel 1755), Zanon e Zamparo danno inizio alla lavorazione della seta impiantando due filatoi a Udine. Il conte Asquini sperimenta la patata.
Ma la sostanza non cambia. Come si suoi dire, le eccezioni confermano la regola. Giustamente Ellero riporta una citazione del vecchio, illuminato e straordinario Antonio Zanon di cui si parlerà più oltre: «[l'agricoltura] [...] totalmente abbandonata dall'ignorante padrone all'ignorante agricoltore, il quale altro non sa che le sciocche tradizioni di un suo avo ugualmente ignorante».
E opinione diffusa fra gli stessi illuminati scrittori dell'epoca che la condizione generale della campagna fosse disastrosa. Rota scrive nel 1806: «generalmente il contadino è povero, vilipeso, abbandonato e miserabile. Gli affitti non hanno veruna norma, l'infingardaggine dei proprietari e dei fattori [...]».
Ma la condizione umana è osservata dallo Zanon in maniera «indiretta» e perciò, forse, complessivamente e psicologicamente più pregnante. Certo, in questa breve frase parla di una zona precisa, l'arida pianura che da Udine, sopra la linea delle risorgive, e lungo i colli morenici, va verso le infinite ghiaie del Tagliamento, ma il «clima» che evoca non si può facilmente scordare: «Taluni [contadini] invecchiano senza aver assaggiato appena un sorso di vino o un frutto [...]».
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38318
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
Re: El parlamento furlan
La Contadinanza
Instauratasi la dominazione veneta sul Friuli, il glorioso Parlamento della Patria fu ridimensionato nei suoi poteri e perdette gran parte della sua importanza. Non poté più decidere gli affari della politica estera e, quanto alla politica interna, dovette sottostare alle direttive di Venezia. Gli fu tolto anche il diritto di eleggere il Consiglio, che rimase composto da sei membri, detti deputati: uno per ogni ordine (clero, nobiltà e comunità) tanto per la destra quanto per la sinistra del Tagliamento. Le sedute erano presiedute dal luogotenente veneto che fissava anche l'ordine del giorno (il patriarca non intervenne ad alcuna seduta). In pratica era ormai un organo svuotato di contenuto, ma serviva alle classi alte come loro sindacato e ai Veneziani per far mostra del loro rispetto formale della individualità, se non dell'autonomia, della Patria. Non bisogna però dimenticare che il Parlamento, qui come altrove, per esempio in Sicilia e in Sardegna (spagnole), fu tenuto in vita perché era una struttura di governo già consolidata.
Il Parlamento, scrive il Nievo, "una volta all'anno si raccoglieva con voto consultivo allato del Luogotenente mandato ad Udine da Venezia", e i suoi atti non erano "senza bellezze per chi volesse ridere".
Alla decadenza del Parlamento corrisponde la nascita e la crescita di una istituzione assolutamente nuova in Italia: la Contadinanza, un'organizzazione di classe, un sindacato avanti lettera dei contadini, che non avevano mai avuto (e non avranno) una rappresentanza diretta in Parlamento.
La Contadinanza, ovvero il quarto ordine sociale del Friuli, nasce sotto la protezione dei Veneziani ed in opposizione al Parlamento (Paschini), con l'aiuto dei Savorgnan e di avvocati intelligenti come Fabio Forza (Leicht), i quali videro la nuova istituzione in funzione antifeudale. In realtà Venezia capì che le plebi rurali del Friuli, specie dopo la guerra contro l'impero e le invasioni turche, versavano in condizioni di grave indigenza, e, come da loro ripetuta istanza, acconsenti ad una organizzazione di classe che tutelasse i loro interessi.
L'anno di nascita della "Contadinanza" è, secondo gli storici più attenti il 1518, quando i contadini ricorsero al doge contro disposizioni prese dal Parlamento a favore dei cittadini titolari di livelli. La rappresentanza dei contadini si recò a Venezia con lettera credenziale del luogotenente e il doge diede loro soddisfazione. Nel 1525 la Contadinanza ottenne il potere di verificare i conti delle esazioni imposte dal Parlamento.
I rappresentanti della Contadinanza sono dapprima i decani delle ville che agiscono attraverso appositi avvocati. Dal 1533, invece, la rappresentanza è affidata a sindaci eletti dapprima tumultuosamente, poi con regole più precise. Questi eleggono a loro volta i sindaci generali, che devono essere quattro per la destra e quattro per la sinistra del Tagliamento. I sindaci ebbero anche mansioni di carattere militare, perché tennero in consegna le armi delle milizie paesane. Avevano anche la responsabilità di una cassa particolare della Contadinanza, nella quale versavano l'importo delle imposte che gravavano sui "fuochi", ovvero sulle case rustiche.
Non si può negare che l'istituzione della Contadinanza non abbia giovato a risollevare un poco le condizioni di vita dei villani, e soprattutto a tutelarli nei confronti dei feudatari, ma le condizioni dei contadini rimasero in complesso assai cattive. Ce lo testimoniano i luogotenenti veneti con dovizia di particolari, e un nobile friulano, il conte Girolamo di Porcia, che in una relazione inviata al nunzio papale a Venezia nel 1567, scrive: "I contadini sono uomini da poco che lavorano mal volentieri, dediti come sono alla crapula, e consumano molto tempo e denaro all'osteria ed a litigare tanto coi padroni quanto fra loro stessi". I soliti luogotenenti annotano che gli uomini costringevano al lavoro le donne ed i bambini!
Non erano ancora giunti i tempi, a quanto pare, del friulano "salt, onest, lavorador".
Ma forse più delle descrizioni, valgono alcuni dati statistici sulla consistenza della popolazione friulana in quei secoli.
Dalla metà del '500 alla meta del '600 assistiamo ad un vero e proprio crollo demografico, causato dalle pestilenze, dai cattivi raccolti e dall'emigrazione. Gli abitanti, che erano 250.000 nel 1561, passano a 92.000 nel 1602, e salgono a 121.000 nel 1640 (più cinquantamila se consideriamo anche quelle parti del Friuli non soggette al luogotenente).
P. S. LEICHT, La Contadinanza friulana, "Ce fastu?", IV (1928).
Instauratasi la dominazione veneta sul Friuli, il glorioso Parlamento della Patria fu ridimensionato nei suoi poteri e perdette gran parte della sua importanza. Non poté più decidere gli affari della politica estera e, quanto alla politica interna, dovette sottostare alle direttive di Venezia. Gli fu tolto anche il diritto di eleggere il Consiglio, che rimase composto da sei membri, detti deputati: uno per ogni ordine (clero, nobiltà e comunità) tanto per la destra quanto per la sinistra del Tagliamento. Le sedute erano presiedute dal luogotenente veneto che fissava anche l'ordine del giorno (il patriarca non intervenne ad alcuna seduta). In pratica era ormai un organo svuotato di contenuto, ma serviva alle classi alte come loro sindacato e ai Veneziani per far mostra del loro rispetto formale della individualità, se non dell'autonomia, della Patria. Non bisogna però dimenticare che il Parlamento, qui come altrove, per esempio in Sicilia e in Sardegna (spagnole), fu tenuto in vita perché era una struttura di governo già consolidata.
Il Parlamento, scrive il Nievo, "una volta all'anno si raccoglieva con voto consultivo allato del Luogotenente mandato ad Udine da Venezia", e i suoi atti non erano "senza bellezze per chi volesse ridere".
Alla decadenza del Parlamento corrisponde la nascita e la crescita di una istituzione assolutamente nuova in Italia: la Contadinanza, un'organizzazione di classe, un sindacato avanti lettera dei contadini, che non avevano mai avuto (e non avranno) una rappresentanza diretta in Parlamento.
La Contadinanza, ovvero il quarto ordine sociale del Friuli, nasce sotto la protezione dei Veneziani ed in opposizione al Parlamento (Paschini), con l'aiuto dei Savorgnan e di avvocati intelligenti come Fabio Forza (Leicht), i quali videro la nuova istituzione in funzione antifeudale. In realtà Venezia capì che le plebi rurali del Friuli, specie dopo la guerra contro l'impero e le invasioni turche, versavano in condizioni di grave indigenza, e, come da loro ripetuta istanza, acconsenti ad una organizzazione di classe che tutelasse i loro interessi.
L'anno di nascita della "Contadinanza" è, secondo gli storici più attenti il 1518, quando i contadini ricorsero al doge contro disposizioni prese dal Parlamento a favore dei cittadini titolari di livelli. La rappresentanza dei contadini si recò a Venezia con lettera credenziale del luogotenente e il doge diede loro soddisfazione. Nel 1525 la Contadinanza ottenne il potere di verificare i conti delle esazioni imposte dal Parlamento.
I rappresentanti della Contadinanza sono dapprima i decani delle ville che agiscono attraverso appositi avvocati. Dal 1533, invece, la rappresentanza è affidata a sindaci eletti dapprima tumultuosamente, poi con regole più precise. Questi eleggono a loro volta i sindaci generali, che devono essere quattro per la destra e quattro per la sinistra del Tagliamento. I sindaci ebbero anche mansioni di carattere militare, perché tennero in consegna le armi delle milizie paesane. Avevano anche la responsabilità di una cassa particolare della Contadinanza, nella quale versavano l'importo delle imposte che gravavano sui "fuochi", ovvero sulle case rustiche.
Non si può negare che l'istituzione della Contadinanza non abbia giovato a risollevare un poco le condizioni di vita dei villani, e soprattutto a tutelarli nei confronti dei feudatari, ma le condizioni dei contadini rimasero in complesso assai cattive. Ce lo testimoniano i luogotenenti veneti con dovizia di particolari, e un nobile friulano, il conte Girolamo di Porcia, che in una relazione inviata al nunzio papale a Venezia nel 1567, scrive: "I contadini sono uomini da poco che lavorano mal volentieri, dediti come sono alla crapula, e consumano molto tempo e denaro all'osteria ed a litigare tanto coi padroni quanto fra loro stessi". I soliti luogotenenti annotano che gli uomini costringevano al lavoro le donne ed i bambini!
Non erano ancora giunti i tempi, a quanto pare, del friulano "salt, onest, lavorador".
Ma forse più delle descrizioni, valgono alcuni dati statistici sulla consistenza della popolazione friulana in quei secoli.
Dalla metà del '500 alla meta del '600 assistiamo ad un vero e proprio crollo demografico, causato dalle pestilenze, dai cattivi raccolti e dall'emigrazione. Gli abitanti, che erano 250.000 nel 1561, passano a 92.000 nel 1602, e salgono a 121.000 nel 1640 (più cinquantamila se consideriamo anche quelle parti del Friuli non soggette al luogotenente).
P. S. LEICHT, La Contadinanza friulana, "Ce fastu?", IV (1928).
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38318
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
Re: El parlamento furlan e la contadinansa
QUESTA STORIA NON S'HA DA SAPERE
http://www.lavosdalfriul.eu/?q=article% ... -da-sapere
“Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani”
Chissà quante volte ci siamo trovati di fronte a queste parole studiando un libro di storia, preparando un tema oppure svolgendo la traccia per qualche esame di stato. Dall'unità d'Italia in avanti, rappresentano un dogma proposto in diverse occasioni dalla scuola primaria fino alla preparazione universitaria.
Rispolverando tra i ricordi, in maniera quasi meccanica, si identifica in questa frase l'emblema dell'unità, il “desiderio” e l'”entusiasmo” di creare uno stato unitario, di costituire un'area geografica che in realtà è composta da piccole nazioni con percorsi linguistici, economici e culturali quasi inconciliabili, tanto erano le specificità maturate nel corso dei secoli.
Cosa volevano veramente le persone di queste piccole nazioni?
Questa domanda, spesso, non trova risposta nei libri di storia che riportano, invece, con dovizia di particolari, la cronologia delle battaglie, degli scontri, degli accordi e di tutte le procedure del protocollo passato alla storia con l'etichetta “facciamo l'Italia”. E' stato sufficiente cambiare alcuni confini, redigere alcune leggi e l'Italia era pronta. L'unità sembra aver portato progresso, istruzione, salute e libertà ovunque. Poco o quasi nulla si sa del Friuli: viene dipinto come una zona gestita dalla monarchia asburgica che, seppur illuminata, per il popolo rappresentava l'opprimente invasore.
Sarà vero?
Per conoscere a fondo la questione è necessario armarsi di pazienza, operare in maniera autonoma, e consultare archivi storici e fonti storiografiche locali in grado di aprire nuovi orizzonti di ricerca. Non tutti hanno avuto la possibilità e gli strumenti culturali per poter accedere a questo diverso punto di vista, ma solo fin dalla più tenera età una panoramica dettagliata del fenomeno Italia.
Nel disegno post unitario la storia del Friuli, come tutte le altre storie locali, è stata “dimenticata” per far posto alla storia dello stato costruito a tavolino da gruppi di potere e di interesse. Per far sentire tutti italiani era fondamentale far convincere dell'esistenza di un percorso condiviso, far emergere il bisogno di ricercare nelle singole storie un ipotetico innato istinto all'unità.
Pochi conoscono monsignor Pio Paschini, storico e religioso friulano e le “vicende tanto svariate e prove tanto atroci” che hanno caratterizzato le nostre terre. Il 3 aprile è una ricorrenza che, nel corso degli anni, si ricorda senza conoscere nel dettaglio la ragione.
La Patrie dal Friûl, una delle più antiche forme politiche democratiche europee, nonostante i suoi sei secoli, è una conoscenza esclusa dalla memoria collettiva italiana.
Nei programmi scolastici il Friuli è spesso una zona d'ombra dove il tempo è passato come un fantasma senza lasciare grosse tracce. In realtà basta guardarsi attorno per rendersi conto che i nostri luoghi sono stati teatro di invasioni, guerre, incontri e scontri tra popoli e civiltà diverse. Un crocevia che ha dato vita ad una nazione che, dal 1866, è stata progressivamente ritoccata e compressa in una regione autonoma, organismo che toglie respiro alla specificità “tutelandola” in maniera restrittiva.
Dimenticare le proprie radici senza difendere e tramandare la nostra storia significa arrendersi a una cultura della quale non faremo e non saremo mai parte, significa aderire ad eventi e decisioni di un passato che non è il nostro. Leggiamo e facciamo leggere a i nostri ragazzi le pagine di Pier Silverio Leicht, di Tito Maniacco, le opere di Novella Cantarutti e di Padre David Maria Turoldo. Per il Parlament Furlan è basilare riportare alla luce e a conoscenza di tutti la nostra storia e identità millenaria. Un impegno che sarà presto concretizzato dall'attività e dalle proposte che nasceranno dal confronto attivo e partecipato della Commissione Cultura e Istruzione con tutti coloro che si riconoscono in questa scelta. Se vogliamo davvero continuare a scrivere la nostra storia diventiamo promotori attivi di tutte le vicende che hanno reso unico il nostro “piccolo compendio dell'universo”.
Sabrina Pivetta - Parlament Furlan
Comenti:
Alberto Pento
El Parlamento Furlan nol jera demogratego ma arestogratego, no femo confouxion. Come kel jera arestogratego el Parlamento Venesian.
http://www.lavosdalfriul.eu/?q=article% ... -da-sapere
“Abbiamo fatto l'Italia, ora dobbiamo fare gli italiani”
Chissà quante volte ci siamo trovati di fronte a queste parole studiando un libro di storia, preparando un tema oppure svolgendo la traccia per qualche esame di stato. Dall'unità d'Italia in avanti, rappresentano un dogma proposto in diverse occasioni dalla scuola primaria fino alla preparazione universitaria.
Rispolverando tra i ricordi, in maniera quasi meccanica, si identifica in questa frase l'emblema dell'unità, il “desiderio” e l'”entusiasmo” di creare uno stato unitario, di costituire un'area geografica che in realtà è composta da piccole nazioni con percorsi linguistici, economici e culturali quasi inconciliabili, tanto erano le specificità maturate nel corso dei secoli.
Cosa volevano veramente le persone di queste piccole nazioni?
Questa domanda, spesso, non trova risposta nei libri di storia che riportano, invece, con dovizia di particolari, la cronologia delle battaglie, degli scontri, degli accordi e di tutte le procedure del protocollo passato alla storia con l'etichetta “facciamo l'Italia”. E' stato sufficiente cambiare alcuni confini, redigere alcune leggi e l'Italia era pronta. L'unità sembra aver portato progresso, istruzione, salute e libertà ovunque. Poco o quasi nulla si sa del Friuli: viene dipinto come una zona gestita dalla monarchia asburgica che, seppur illuminata, per il popolo rappresentava l'opprimente invasore.
Sarà vero?
Per conoscere a fondo la questione è necessario armarsi di pazienza, operare in maniera autonoma, e consultare archivi storici e fonti storiografiche locali in grado di aprire nuovi orizzonti di ricerca. Non tutti hanno avuto la possibilità e gli strumenti culturali per poter accedere a questo diverso punto di vista, ma solo fin dalla più tenera età una panoramica dettagliata del fenomeno Italia.
Nel disegno post unitario la storia del Friuli, come tutte le altre storie locali, è stata “dimenticata” per far posto alla storia dello stato costruito a tavolino da gruppi di potere e di interesse. Per far sentire tutti italiani era fondamentale far convincere dell'esistenza di un percorso condiviso, far emergere il bisogno di ricercare nelle singole storie un ipotetico innato istinto all'unità.
Pochi conoscono monsignor Pio Paschini, storico e religioso friulano e le “vicende tanto svariate e prove tanto atroci” che hanno caratterizzato le nostre terre. Il 3 aprile è una ricorrenza che, nel corso degli anni, si ricorda senza conoscere nel dettaglio la ragione.
La Patrie dal Friûl, una delle più antiche forme politiche democratiche europee, nonostante i suoi sei secoli, è una conoscenza esclusa dalla memoria collettiva italiana.
Nei programmi scolastici il Friuli è spesso una zona d'ombra dove il tempo è passato come un fantasma senza lasciare grosse tracce. In realtà basta guardarsi attorno per rendersi conto che i nostri luoghi sono stati teatro di invasioni, guerre, incontri e scontri tra popoli e civiltà diverse. Un crocevia che ha dato vita ad una nazione che, dal 1866, è stata progressivamente ritoccata e compressa in una regione autonoma, organismo che toglie respiro alla specificità “tutelandola” in maniera restrittiva.
Dimenticare le proprie radici senza difendere e tramandare la nostra storia significa arrendersi a una cultura della quale non faremo e non saremo mai parte, significa aderire ad eventi e decisioni di un passato che non è il nostro. Leggiamo e facciamo leggere a i nostri ragazzi le pagine di Pier Silverio Leicht, di Tito Maniacco, le opere di Novella Cantarutti e di Padre David Maria Turoldo. Per il Parlament Furlan è basilare riportare alla luce e a conoscenza di tutti la nostra storia e identità millenaria. Un impegno che sarà presto concretizzato dall'attività e dalle proposte che nasceranno dal confronto attivo e partecipato della Commissione Cultura e Istruzione con tutti coloro che si riconoscono in questa scelta. Se vogliamo davvero continuare a scrivere la nostra storia diventiamo promotori attivi di tutte le vicende che hanno reso unico il nostro “piccolo compendio dell'universo”.
Sabrina Pivetta - Parlament Furlan
Comenti:
Alberto Pento
El Parlamento Furlan nol jera demogratego ma arestogratego, no femo confouxion. Come kel jera arestogratego el Parlamento Venesian.
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38318
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
Re: El parlamento furlan e la contadinansa
Sti veneti envaxà e orbà dal mito de Venesia no łi ghe riva e no łi capise:
LA PATRIA DEL FRIULI DI OGGI, E VENEZIA
http://venetostoria.com/2015/08/30/la-p ... -e-venezia
30 agosto 2015 di Millo Bozzolan
Di Milo Boz, veneto marciano.
Vengo ora da una capatina nella pagina di un gruppo autonomista friulano e mi vien da pensare quanto balzi all’occhio, nei contenuti, la differenza tra noi indipendentisti veneti e loro. Bene o male, magari in maniera a volte un po’ troppo “nazionalista” noi ci rifacciamo a una civiltà e a una storia, quella veneta, espressa da Venezia, che ha segnato lo sviluppo dell’Europa e quindi dell’Occidente. Un grande retaggio di cultura, che ha riempito i musei del mondo di opere d’arte e anche un esempio di convivenza tra vari popoli di cultura ed etnia diversi, valido ancora oggi, a cui hanno contribuito tutti, compresi i friulani, che dovrebbero menarne vanto e rivendicare con orgoglio la loro fetta di “venezianità”.
Invece li vedo capaci solo di un campanilismo privo di storia, basato sulla specificità della lingua friulana e poco altro. Rinnegando un grande passato all’ombra del Leone, cosa vi resta in mano cari “fradei furlani”? E’ Venezia che vi permise di aver un parlamento in quel di Udine, è Venezia che impose ai feudatari di accettarvi, come di consuetudine già nella Terraferma, i rappresentanti di tutte le categorie, compresi i contadini, le classi più umili… fareste bene a ricordare anche queste cose, parte della vostra storia.
O no?
Sti veneti envaxà e orbà dal mito de Venesia no łi ghe riva e no łi capise:
No, sto omo nol capise, nol ghe riva, nol capise ke ła storia dei veneti de tera suditi de ła Repiovega Veneta a domegno venesian ła xe durà lomè 4 secołi e ke ła storia sensa Venesia ła xe durà pì del dopio, 900 e pàsa ani, dapò el termene de l'enpero roman; e sto omo nol capise ke ła Repiovega Veneta ła xe morta purpio par colpa dei venesiani ke łi ga volesto tegner sudite o sotane tute łe xenti de łe tere venet-furlane anvençe de farle responsabiłi e parteçepi del poter połedego. Nol ghe riva a capir ke xe stà purpio par sto egoixmo venesian ke no ghè pì tanto amor par Venesia e i venesiani. Coando kel capirà che el Veneto co ła Furlania no łe xe Venesia e ke ła so storia lè anca altro da coeła de Venesia forse sarà màsa tardi.
Mi a so veneto vixentin e no veneto marcian come ke łi udinexi łi xe furlani, mai dexmentegarse de recognosar e de ver creansa par ła storia e l'edentetà de łi altri e ke no se ga da far come ke ła ga fato ła Tałia ke ła ga scançełà e falbà ła storia de tuti contando lomè coeła de łi romani e de łi "tałiani".
LA PATRIA DEL FRIULI DI OGGI, E VENEZIA
http://venetostoria.com/2015/08/30/la-p ... -e-venezia
30 agosto 2015 di Millo Bozzolan
Di Milo Boz, veneto marciano.
Vengo ora da una capatina nella pagina di un gruppo autonomista friulano e mi vien da pensare quanto balzi all’occhio, nei contenuti, la differenza tra noi indipendentisti veneti e loro. Bene o male, magari in maniera a volte un po’ troppo “nazionalista” noi ci rifacciamo a una civiltà e a una storia, quella veneta, espressa da Venezia, che ha segnato lo sviluppo dell’Europa e quindi dell’Occidente. Un grande retaggio di cultura, che ha riempito i musei del mondo di opere d’arte e anche un esempio di convivenza tra vari popoli di cultura ed etnia diversi, valido ancora oggi, a cui hanno contribuito tutti, compresi i friulani, che dovrebbero menarne vanto e rivendicare con orgoglio la loro fetta di “venezianità”.
Invece li vedo capaci solo di un campanilismo privo di storia, basato sulla specificità della lingua friulana e poco altro. Rinnegando un grande passato all’ombra del Leone, cosa vi resta in mano cari “fradei furlani”? E’ Venezia che vi permise di aver un parlamento in quel di Udine, è Venezia che impose ai feudatari di accettarvi, come di consuetudine già nella Terraferma, i rappresentanti di tutte le categorie, compresi i contadini, le classi più umili… fareste bene a ricordare anche queste cose, parte della vostra storia.
O no?
Sti veneti envaxà e orbà dal mito de Venesia no łi ghe riva e no łi capise:
No, sto omo nol capise, nol ghe riva, nol capise ke ła storia dei veneti de tera suditi de ła Repiovega Veneta a domegno venesian ła xe durà lomè 4 secołi e ke ła storia sensa Venesia ła xe durà pì del dopio, 900 e pàsa ani, dapò el termene de l'enpero roman; e sto omo nol capise ke ła Repiovega Veneta ła xe morta purpio par colpa dei venesiani ke łi ga volesto tegner sudite o sotane tute łe xenti de łe tere venet-furlane anvençe de farle responsabiłi e parteçepi del poter połedego. Nol ghe riva a capir ke xe stà purpio par sto egoixmo venesian ke no ghè pì tanto amor par Venesia e i venesiani. Coando kel capirà che el Veneto co ła Furlania no łe xe Venesia e ke ła so storia lè anca altro da coeła de Venesia forse sarà màsa tardi.
Mi a so veneto vixentin e no veneto marcian come ke łi udinexi łi xe furlani, mai dexmentegarse de recognosar e de ver creansa par ła storia e l'edentetà de łi altri e ke no se ga da far come ke ła ga fato ła Tałia ke ła ga scançełà e falbà ła storia de tuti contando lomè coeła de łi romani e de łi "tałiani".
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38318
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 1 ospite

