Adonai
Adonài significa, letteralmente, “mio Signore”, un termine con cui rivolgersi ad un superiore, come “m'lord” nel vecchio stile inglese. Sin dai primissimi tempi questo termine è stato usato in sostituzione di Y-H-V-H, che non poteva essere pronunciato. Quando la Bibbia ebraica venne tradotta per la prima volta in greco (intorno al 200 a.e.v.) fu la parola Adonài che i traduttori greci resero come Kyrios o Signore.
La tradizione midrashica offre una spiegazione illuminante per l'origine di questo termine come sostituto per il nome di Dio. Quando Dio creò Adamo, si racconta che gli angeli furono presi da una gelosia rabbiosa. “Un semplice terrestre!” dicevano, negando che Adamo avesse un qualsiasi valore speciale. Ma Dio amava Adamo e voleva che egli mostrasse la sua saggezza. Così Dio fece venire avanti gli animali, uno dopo l'altro, e chiese agli angeli di dar loro un nome. Non avendo alcuna esperienza del mondo animale, gli angeli non seppero rispondere. Allora Dio chiamò Adamo e chiese a lui di dare un nome agli animali. Adamo fece ciò in breve tempo. “E ora - disse Dio - quale dovrebbe essere il tuo nome?”. Rispose Adamo: “Il mio nome dovrebbe essere Adamo, perché sono stato tratto da adamah (terra)”. “E quale dovrebbe essere il mio nome?” chiese Dio. “Tu - replicò Adamo immediatamente - dovresti essere chiamato Adonài, perché Tu sei il Signore di tutte le Tue opere”.
Da questo midràsh si può apprendere una duplice lezione. Una è che l'essere Signore sopra di noi non è la parte più importante del Sé Divino. L'essenza divina è espressa in modo migliore dal nome Y-H-V-H, perché la Presenza divina permea tutta l'esistenza. Siamo noi esseri umani che attribuiamo a Dio il dominio, per il nostro bisogno di sottomissione. Il potere è una proiezione della società umana nell'Essere divino, misterioso, inconoscibile. Nonostante questo, tuttavia, chiamiamo Dio Adonài perfino nelle nostre preghiere più intime. Usiamo questa parola come se fosse realmente un nome. Questa è la seconda lezione. Dire “Signore” ci mette in relazione con Y-H-V-H. Questo desiderio di un rapporto, anche se con un essere così astratto come Y-H-V-H, è un segno del nostro amore. Dio risponde al nostro amore e sceglie di essere chiamato con questo nome che abbiamo creato per lui, alle nostre origini, piuttosto che con il suo nome dichiarato, Y-H-V-H.
Ebraeixmo spertoałetà e rełixon
Re: Ebraeixmo: Elohim
Elohìm
Elohìm è il comune termine ebraico per “dio”. La Bibbia lo usa quando fa riferimento sia al “Dio” d'Israele che agli “dei” degli altri popoli. La parola è, talvolta, usata nel significato di “eminente” con riferimento ad un'autorità umana rispettata. La cosa più interessante riguardo a Elohìm è il fatto che si tratta di una forma plurale.
La Bibbia riconosce questo fatto nell'usarla quando parla degli “dei degli altri”. In questo caso verbo ed aggettivi assumono anch'essi la forma plurale, come richiesto dal corretto uso grammaticale. Ma quando la stessa parola plurale è impiegata per riferirsi al Dio di Israele, quelle regole vengono intenzionalmente violate e Elohìm è considerata come una forma al singolare. Pertanto le prime parole della Bibbia, Bereshit barà Elohìm (“In principio Dio creò...”), sono una sorta di abominio grammaticale! Ogni volta che la Toràh* dice va-yomer Elohìm (“Dio disse”) le regole della grammatica vengono infrante.
Questo, naturalmente, non è affatto un caso. Il punto è che Elohìm, in questo contesto, è usato come un collettivo. Tutti i poteri che una volta appartenevano a tutte le divinità del pantheon |m- come l'amore, la forza, la sapienza, la guerra, la fecondità |m- sono ora concentrati in questo unico Essere che li contiene tutti. Le benedizioni necessarie ad ogni aspetto della vita umana sono viste, ora, come provenienti da una singola fonte. Questa è l'essenza della rivoluzione monoteistica, incarnata nella lingua ogni volta che usiamo questo comune termine ebraico per “Dio”.
Lo Zòhar, il grande compendio della Qabbalàh, si apre con una profonda interpretazione della parola Elohìm. Interpreta la parola come se fosse composta da due termini ebraici più brevi: elleh e mi. Elleh significa “questi”, con riferimento a tutti gli aspetti e gli attributi di Dio a noi accessibili attraverso le sefiròt. Mi significa “chi?” sempre nella forma interrogativa. Malgrado tutta la capacità del nostro pensiero e della nostra immaginazione - lo Zòhar insegna - Dio rimane un mistero. Se credete di comprendere Dio, perdete il significato del “chi?” Allora diventate idolatri che adorano la loro immagine, proprio come coloro che fecero il vitello d'oro e dicevano: “Questi sono i tuoi dei, o Israele!” (Es. 32:4).
Ki xeli sti cuà?
Elohìm è il comune termine ebraico per “dio”. La Bibbia lo usa quando fa riferimento sia al “Dio” d'Israele che agli “dei” degli altri popoli. La parola è, talvolta, usata nel significato di “eminente” con riferimento ad un'autorità umana rispettata. La cosa più interessante riguardo a Elohìm è il fatto che si tratta di una forma plurale.
La Bibbia riconosce questo fatto nell'usarla quando parla degli “dei degli altri”. In questo caso verbo ed aggettivi assumono anch'essi la forma plurale, come richiesto dal corretto uso grammaticale. Ma quando la stessa parola plurale è impiegata per riferirsi al Dio di Israele, quelle regole vengono intenzionalmente violate e Elohìm è considerata come una forma al singolare. Pertanto le prime parole della Bibbia, Bereshit barà Elohìm (“In principio Dio creò...”), sono una sorta di abominio grammaticale! Ogni volta che la Toràh* dice va-yomer Elohìm (“Dio disse”) le regole della grammatica vengono infrante.
Questo, naturalmente, non è affatto un caso. Il punto è che Elohìm, in questo contesto, è usato come un collettivo. Tutti i poteri che una volta appartenevano a tutte le divinità del pantheon |m- come l'amore, la forza, la sapienza, la guerra, la fecondità |m- sono ora concentrati in questo unico Essere che li contiene tutti. Le benedizioni necessarie ad ogni aspetto della vita umana sono viste, ora, come provenienti da una singola fonte. Questa è l'essenza della rivoluzione monoteistica, incarnata nella lingua ogni volta che usiamo questo comune termine ebraico per “Dio”.
Lo Zòhar, il grande compendio della Qabbalàh, si apre con una profonda interpretazione della parola Elohìm. Interpreta la parola come se fosse composta da due termini ebraici più brevi: elleh e mi. Elleh significa “questi”, con riferimento a tutti gli aspetti e gli attributi di Dio a noi accessibili attraverso le sefiròt. Mi significa “chi?” sempre nella forma interrogativa. Malgrado tutta la capacità del nostro pensiero e della nostra immaginazione - lo Zòhar insegna - Dio rimane un mistero. Se credete di comprendere Dio, perdete il significato del “chi?” Allora diventate idolatri che adorano la loro immagine, proprio come coloro che fecero il vitello d'oro e dicevano: “Questi sono i tuoi dei, o Israele!” (Es. 32:4).
Ki xeli sti cuà?
-

Sixara - Messaggi: 1764
- Iscritto il: dom nov 24, 2013 11:44 pm
Re: Ebraeixmo : Shaddai
Shaddai
Shaddài è l'antico nome di Dio che è spesso tradotto “Onnipotente”. L'etimologia del termine è incerta. Nella Bibbia esso è spesso usato insieme con il nome El, e El Shaddài poteva riferirsi a Dio nel Suo manifestarsi nei campi e nelle montagne. La parola può essere collegata a shad o “mammella”, e quindi El Shaddài indicherebbe un Dio con le mammelle, che nutre e cura i devoti. Questo significato è collegato all'opinione dei rabbini che la parola sia collegata a dai, “a sufficienza”, intendendo così dire che Dio offre sostentamento a sufficienza a tutti coloro che ne hanno necessità.
La leggenda rabbinica collega l'etimologia di Shaddài a un possente racconto della Creazione. Il secondo giorno Dio creò sia il cielo che la terraferma; tuttavia il confine tra i due non era chiaramente stabilito. Il mare, sotto l'aspetto di un grande drago acqueo, continuava ad attaccare la terra minacciando di inghiottirla. Dio dovette intervenire tra di loro e fissare i confini sabbiosi del mare. “Basta così!” gridò Dio, e il mare smise di espandersi. “Hai stabilito un confine che esse non possono attraversare, affinché non ritornino a coprire la terra” (Salmi 104:9). Qui il Dio chiamato Shaddài è Colui che poté dire “Basta!” alla potenza del mare che tutto erode.
Oggi i mari minacciano nuovamente la terra. L'inventiva umana ci ha portato ad usare e ad abusare del nostro mondo in un modo tale che la temperatura globale si sta innalzando e con essa il livello del mare. Molti prevedono grandi inondazioni delle aree costiere nei prossimi anni. Sta a noi, ora, dire “Basta!”.
Shaddài è l'antico nome di Dio che è spesso tradotto “Onnipotente”. L'etimologia del termine è incerta. Nella Bibbia esso è spesso usato insieme con il nome El, e El Shaddài poteva riferirsi a Dio nel Suo manifestarsi nei campi e nelle montagne. La parola può essere collegata a shad o “mammella”, e quindi El Shaddài indicherebbe un Dio con le mammelle, che nutre e cura i devoti. Questo significato è collegato all'opinione dei rabbini che la parola sia collegata a dai, “a sufficienza”, intendendo così dire che Dio offre sostentamento a sufficienza a tutti coloro che ne hanno necessità.
La leggenda rabbinica collega l'etimologia di Shaddài a un possente racconto della Creazione. Il secondo giorno Dio creò sia il cielo che la terraferma; tuttavia il confine tra i due non era chiaramente stabilito. Il mare, sotto l'aspetto di un grande drago acqueo, continuava ad attaccare la terra minacciando di inghiottirla. Dio dovette intervenire tra di loro e fissare i confini sabbiosi del mare. “Basta così!” gridò Dio, e il mare smise di espandersi. “Hai stabilito un confine che esse non possono attraversare, affinché non ritornino a coprire la terra” (Salmi 104:9). Qui il Dio chiamato Shaddài è Colui che poté dire “Basta!” alla potenza del mare che tutto erode.
Oggi i mari minacciano nuovamente la terra. L'inventiva umana ci ha portato ad usare e ad abusare del nostro mondo in un modo tale che la temperatura globale si sta innalzando e con essa il livello del mare. Molti prevedono grandi inondazioni delle aree costiere nei prossimi anni. Sta a noi, ora, dire “Basta!”.
-

Sixara - Messaggi: 1764
- Iscritto il: dom nov 24, 2013 11:44 pm
Re: Ebraeixmo
???

http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... /kw-41.jpg
El ’Šaddai.
Ai Patriarchi Dio si rivela come El ’Šaddai (Es. 6, 2-4).
Šaddai non ha nulla che vedere con il dio protettore amorrita Šedu, accadico šēdum, un demone, simbolo della energia vitale, spesso unito al protettore lamassu (‘ein Dämon, Lebenskraft’), l'ebraico šēd, aramaico šēdā.
Šaddai è la vetta, il monte, l’altura, il luogo preferito di culto della divinità; come le bāmōth del culto di Baal: questo stesso nome costituisce la base dell'italico fala nel senso di altura.
Šaddai corrisponde alla base di antico babilonese šaddā’u (abitatore dei monti, ‘Bergbewohner’).
In Assiria e in Babilonia l’immagine mitologica del monte richiama la dimora della divinità: il monte dei Cedri, sede degli dei, il monte dei Paesi, il monte dell'Assemblea, sopra le stelle di Dio: per essere a livello dell'Altissimo vi voleva salire il re di Babilonia (Is. 14, 13); il monte del vento.
In Fenicia (Ugarit), Saphon, nei miti di Rās Šamra, è la sede di Baal: Saphon è il monte Casio dove la mitologia greca pone la contesa tra Giove e Tifone.
La rivelazione di Dio a Mosè avviene sul monte di Jahweh, il Sinai (Es. 3, 1; 4, 27; 18, 5; 24, 13; IRe 19, 8; Num. 10, 33; Sal. 24, 3), il monte di Sion è il monte di Dio.
Questi richiami si chiariscono sullo sfondo della cosmologia babilonese che disegna lo spazio tra la terra e il firmamento come una grande montagna, casa della divinità.
Suman (Monte Suman) el monte sagro dei veneti – monte coxmego
viewtopic.php?f=45&t=125
https://docs.google.com/file/d/0B_VoBnR ... pOUG8/edit
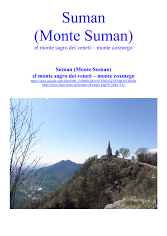

http://www.filarveneto.eu/wp-content/up ... /kw-41.jpg
El ’Šaddai.
Ai Patriarchi Dio si rivela come El ’Šaddai (Es. 6, 2-4).
Šaddai non ha nulla che vedere con il dio protettore amorrita Šedu, accadico šēdum, un demone, simbolo della energia vitale, spesso unito al protettore lamassu (‘ein Dämon, Lebenskraft’), l'ebraico šēd, aramaico šēdā.
Šaddai è la vetta, il monte, l’altura, il luogo preferito di culto della divinità; come le bāmōth del culto di Baal: questo stesso nome costituisce la base dell'italico fala nel senso di altura.
Šaddai corrisponde alla base di antico babilonese šaddā’u (abitatore dei monti, ‘Bergbewohner’).
In Assiria e in Babilonia l’immagine mitologica del monte richiama la dimora della divinità: il monte dei Cedri, sede degli dei, il monte dei Paesi, il monte dell'Assemblea, sopra le stelle di Dio: per essere a livello dell'Altissimo vi voleva salire il re di Babilonia (Is. 14, 13); il monte del vento.
In Fenicia (Ugarit), Saphon, nei miti di Rās Šamra, è la sede di Baal: Saphon è il monte Casio dove la mitologia greca pone la contesa tra Giove e Tifone.
La rivelazione di Dio a Mosè avviene sul monte di Jahweh, il Sinai (Es. 3, 1; 4, 27; 18, 5; 24, 13; IRe 19, 8; Num. 10, 33; Sal. 24, 3), il monte di Sion è il monte di Dio.
Questi richiami si chiariscono sullo sfondo della cosmologia babilonese che disegna lo spazio tra la terra e il firmamento come una grande montagna, casa della divinità.
Suman (Monte Suman) el monte sagro dei veneti – monte coxmego
viewtopic.php?f=45&t=125
https://docs.google.com/file/d/0B_VoBnR ... pOUG8/edit
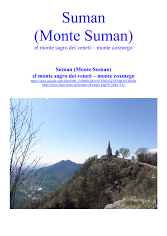
Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38319
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
Re: Ebraeixmo
Si ke po' a vardare bèn 'mammella ' la ga la forma de na montagna, nò? 
Eh insoma la rivelasion la vièn dà so na montagna- parké? Elora semo fregà naltri cuà zo..
Però lè bela anca la fòla ca conta i rabini sol Dio ca dixe Basta! .. moeghea! al drago-mare ke l se barufava co la tèra..
Eh insoma la rivelasion la vièn dà so na montagna- parké? Elora semo fregà naltri cuà zo..
Però lè bela anca la fòla ca conta i rabini sol Dio ca dixe Basta! .. moeghea! al drago-mare ke l se barufava co la tèra..
-

Sixara - Messaggi: 1764
- Iscritto il: dom nov 24, 2013 11:44 pm
Re: Ebraeixmo : Jitrò
La Parashà de la stìmana l è so i Comandamenti:
http://www.giuntina.it/Parasha/
Jitrò
(Esodo 18,1 - 20,26) La parte predominante della Parashà di Jitrò è costituita dalla Promulgazione del Decalogo sul monte Sinai.
Il termine usato in ebraico per quelli che comunemente vengono chiamati “I dieci Comandamenti”, è “'Assereth ha-dibberoth”, “Le dieci parole”, “Le dieci espressioni”, le parole con cui l'Eterno diede a tutta l'umanità, attraverso Israele, la guida che avrebbe illuminato la sua strada.
Come è stato ripetutamente rilevato, nel Decalogo troviamo enunciati i più alti precetti della Torà, di importanza fondamentale sia per una nuova, rivoluzionaria impostazione del vivere civile, sia per il modo imponente con il quale furono rivelati all'intera nazione: “Il terzo giorno, come fu mattino, cominciarono dei tuoni e dei lampi, apparve una folta nuvola sul monte e si udì un forte suono di tromba: e tutto il popolo che era nel campo tremò... Ora il monte Sinai era tutto fumante perché l'Eterno vi era disceso in mezzo al fuoco; e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si andava facendo sempre più forte...” (19,16-19).
E fra i tuoni, i lampi, il suono dello Shofar e le fiamme di fuoco che avvolgevano la montagna fumante, una Voce solenne pronunciò quelle parole che da quel momento fino ai giorni nostri sono state la guida del comportamento per il genere umano.
Possiamo affermare che quella rivelazione fu il più notevole avvenimento nella storia dell'Umanità; fu il momento in cui nacque la “religione dello spirito” che era destinata nel tempo ad illuminare le anime, a dare un ordine alla vita di tutti gli esseri umani.
Il Decalogo, fondamento di tutte le religioni monoteistiche, è un sublime compendio dei doveri basilari che impegnano tutto il genere umano; un compendio rimasto ineguagliato per la concisione, per l'esposizione, per la vastità dei concetti, per la solennità del momento in cui vennero pronunciati.
Il Decalogo, ci insegna la Torà, fu consegnato a Mosè in due Tavole, le “Tavole del Patto”, o “Tavole della Testimonianza”, come sono designate nel testo biblico.
Nelle due Tavole, le “'Assereth ha-dibberoth”, qui riportate nei punti essenziali, secondo la tradizione ebraica sono suddivise nell'ordine seguente:
Prima Tavola:
1) Io sono il Signore Dio tuo che ti trasse dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù.
2) Non avrai altri dèi all'infuori di Me.
3) Non pronunciare il nome del Dio tuo invano.
4) Ricordati del giorno del sabato per santificarlo.
5) Onora tuo padre e tua madre.
Seconda Tavola:
6) Non uccidere.
7) Non commettere adulterio.
8) Non rubare.
9) Non testimoniare il falso riguardo al tuo prossimo.
10) Non desiderare la donna del tuo prossimo; non desiderare tutto ciò che appartiene al tuo prossimo.
Si noterà che, secondo questa suddivisione, nella prima Tavola sono elencati i Comandamenti che riguardano i doveri dell'uomo verso l'Eterno; nella seconda Tavola, invece, quelli che riguardano il suo comportamento verso il prossimo.
Il principio fondamentale dei Comandamenti della prima Tavola è quindi l'amore per l'Eterno: quell'amore che nello Shemà', la solenne dichiarazione di fede dell'Ebraismo, è espresso nella frase: “E amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue facoltà” (Deut. 6,5).
Il principio su cui si fondano i Comandamenti contenuti nella seconda Tavola è l'amore per il prossimo; principio sintetizzato con insuperabile chiarezza e concisione nel verso del Levitico (19,18): “E amerai il prossimo tuo come te stesso”, o, con una traduzione più fedele al testo ebraico: “Desidera per il tuo prossimo quello che desideri per te stesso”, o ancora: “Agisci per il bene del tuo prossimo come agiresti per il tuo stesso bene”.
Nelle due “Tavole del Patto” viene perciò messo in risalto che l'amore verso Dio e quello verso il prossimo sono due sentimenti che si completano a vicenda, come ricorda il Lattes citando quanto ha affermato Rabbì Avraham Yeoshua di Apta, grande maestro del Chassidismo dell'inizio del secolo scorso: “Le frasi `Ama l'Eterno tuo Dio' e `Ama il prossimo tuo', costituiscono senza dubbio due Comandamenti. In realtà, però, l'amore di Dio e l'amore degli uomini sono una cosa sola. Compito dello `tzaddik', del giusto, è appunto di fare effettivamente dell'amore di Dio e dell'amore degli uomini una cosa sola”.
Può lasciare perplessi il fatto che il Comandamento “Onora tuo padre e tua madre”, sia inserito nella prima Tavola benché a prima vista sembri un comando che riguarda esclusivamente i rapporti fra l'uomo e il suo prossimo; in realtà esso costituisce il collegamento tra il primo e il secondo gruppo di Comandamenti. I genitori sono infatti i creatori materiali dell'uomo, ma l'anima è divina; i genitori sono quindi i collaboratori dell'Eterno nella creazione di un nuovo essere: concetto espresso in modo chiaro nel Talmud: “Tre sono i collaboratori nella creazione dell'uomo: il Signore Benedetto, il padre e la madre. Perciò, quando un uomo onora e rispetta il padre e la madre, il Signore Benedetto dice: `Io lo considero degno di ricompensa come se avesse rispettato Me stesso!'“ (Talmud Babilonese, Kiddushin 30b).
L'osservanza del precetto “Onora tuo padre e tua madre” costituisce, in effetti, il punto di partenza per la preparazione e la comprensione del rispetto e del timore di Dio; sono i genitori che insegnano ai giovani a conoscere Dio; costituiscono così il primo anello della catena della tradizione, fondamento non solo della vita religiosa ma, nel suo significato più ampio, anche della vita della società.
Se si analizzano i precetti delle due Tavole secondo la loro collocazione, si troverà un significativo parallelismo fra tutti i precetti collocati al medesimo livello.
In particolare metteremo in rilievo il primo e l'ultimo precetto delle due Tavole: “Non uccidere” è parallelo a “Io sono il Signore tuo Dio”; chi uccide commette un gravissimo peccato verso il Signore che ha creato il “tuo prossimo” come ha creato “te”, a Sua immagine e somiglianza.
Come pure “Non desiderare la donna del tuo prossimo” in parallelo a “Onora tuo padre e tua madre” sottolinea l'importanza della santità della famiglia in ogni suo aspetto.
Soffermiamoci sui primi quattro comandamenti.
“Io sono il Signore tuo Dio”. Queste parole ordinano la conoscenza di Dio e si rivolgono quindi alla fede, allo spirito.
Anche il secondo Comandamento, “Non avrai altri dei all'infuori di Me”, rifiutando qualsiasi falsa credenza, riguarda la fede; e anch'esso si rivolge allo spirito dell'uomo, al suo sentimento.
I primi due Comandamenti riguardano, quindi, la concezione religiosa, ed esprimendo il medesimo principio, prima in forma affermativa e poi in forma negativa, si completano a vicenda. Essi costituiscono il modello di tutti i precetti che richiamano perentoriamente l'uomo all'amore di Dio, al timore di Dio, al riconoscimento dell'unità di Dio.
Il terzo Comandamento, “Non pronunciare il nome del Signore tuo Dio invano”, ci esorta non soltanto a non pronunciare con leggerezza, senza ragione, il nome dell'Eterno, ma anche ad evitare interpretazioni errate, blasfeme nell'uso del nome di Dio. Come sempre i nostri Maestri, partendo dal concetto semplice e basilare espresso dalla Torà, lo hanno poi allargato per renderlo eticamente sempre più valido aiuto ad una vita migliore.
Ne deriva che le dichiarazioni di “guerra santa” con relativi massacri, che le stragi compiute in nome di Dio divengono parole blasfeme! Come pure la “conversione forzata” dietro minaccia di morte e di torture!
Non è questo che Dio richiede da noi!
Il “non pronunciare il nome di Dio invano” ci invita a una approfondita riflessione sull'uso che siamo tenuti a fare della parola, dono prezioso che il Signore Benedetto ci ha concesso. Non soltanto dobbiamo usare la parola per esprimere concetti che siano di lode al Signore, ma dobbiamo usarla per educare al bene, per stimolare noi stessi e il prossimo ad agire per il bene, per il progresso dell'umanità, in special modo quello morale e spirituale.
Quanto danno è stato causato dalla parola usata per insegnare la prepotenza, la superiorità di razza, l'importanza della ricchezza, della conquista territoriale!
Il quarto comandamento, “Ricordati del giorno del sabato per santificarlo”, a prima vista sembra rivolgersi soltanto all'intelletto, al pensiero dell'uomo. Ma la frase che segue immediatamente, “non farai in esso alcuna opera, perché in sei giorni l'Eterno fece il cielo e la terra e il settimo si riposò”, sottolinea il dovere che incombe su di noi di astenerci in questo giorno da ogni opera creativa per dedicarci a Dio non distratti da qualsiasi preoccupazione materiale.
Esso costituisce il modello di tutti i precetti con l'osservanza dei quali, adempiendo al nostro dovere verso il Signore, santifichiamo la nostra vita; precetti che si osservano sia eseguendo alcune azioni sia astenendosi da altre.
In altre parole i primi due Comandamenti riguardano il pensiero dell'uomo, il terzo la parola, il quarto l'azione.
Il quinto Comandamento, come abbiamo già notato, costituisce il passaggio dalla prima alla seconda Tavola.
Molto istruttivo è l'ordine con il quale i Comandamenti sono stati elencati nella seconda “Tavola del Patto”.
A differenza della prima Tavola, nella seconda troviamo all'inizio quelli che sottolineano l'importanza dell'azione concreta, vietando quelle azioni che danneggiando materialmente il prossimo privandolo di ciò che gli appartiene: “Non uccidere; non rubare” o moralmente: “Non commettere adulterio”, non possono che minare le fondamenta della società umana.
Segue il Comandamento che riguarda la favella: “Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo”.
Soltanto alla fine, dopo i Comandamenti che riguardano l'azione e la favella, troviamo il Comandamento che si riferisce al pensiero: “Non desiderare la donna del tuo prossimo; non desiderare tutto ciò che appartiene al tuo prossimo”.
Si può avanzare l'ipotesi che l'Eterno abbia voluto richiamare la nostra attenzione sul fatto che, per quanto riguarda il nostro comportamento verso di Lui, il punto di partenza non può essere che la fede, il pensiero. Affermato questo principio fondamentale, indiscutibile, ci ammonisce che le nostre azioni verso il prossimo devono essere improntate alla giustizia e alla comprensione reciproca, tese a stabilire rapporti concreti di armonia e di concordia.
La Torà non si limita quindi ad emanare disposizioni che ci guidino nel comportamento a cui dobbiamo attenerci nei riguardi del prossimo, non si limita a imporci di non compiere alcuna azione indegna che possa colpire i nostri simili nella vita, nella famiglia, nella proprietà; la Torà esige che vi sia reciproco rispetto anche nel sentimento e nel pensiero.
È molto importante a questo proposito il fatto che il Decalogo si concluda proprio con il Comandamento “Non desiderare tutto ciò che appartiene al tuo prossimo!”. Si potrebbe obiettare: che danno può arrecare al prossimo il riconoscere che possiede una cosa bella, pregevole, desiderabile? Ebbene la Torà ci mette in guardia contro il rancore, contro la smania di possesso ad ogni costo e a qualsiasi prezzo, contro l'invidia verso chi ha quel che noi non possiamo permetterci: sentimenti che denotano un animo non integro in colui che li prova.
In quest'ultimo Comandamento, non meno che nel primo, si rivela la straordinaria rivoluzione operata con la promulgazione del Decalogo. Il primo Comandamento, che esige la conoscenza di un Dio unico, creatore di ogni essere, trova la sua logica conclusione nell'ultimo che ci ammonisce a rispettare il prossimo che è stato creato per volontà dell'Eterno, a Sua immagine e somiglianza!
© Elia Kopciowski, Invito alla lettura della Torà.
http://www.giuntina.it/Parasha/
Jitrò
(Esodo 18,1 - 20,26) La parte predominante della Parashà di Jitrò è costituita dalla Promulgazione del Decalogo sul monte Sinai.
Il termine usato in ebraico per quelli che comunemente vengono chiamati “I dieci Comandamenti”, è “'Assereth ha-dibberoth”, “Le dieci parole”, “Le dieci espressioni”, le parole con cui l'Eterno diede a tutta l'umanità, attraverso Israele, la guida che avrebbe illuminato la sua strada.
Come è stato ripetutamente rilevato, nel Decalogo troviamo enunciati i più alti precetti della Torà, di importanza fondamentale sia per una nuova, rivoluzionaria impostazione del vivere civile, sia per il modo imponente con il quale furono rivelati all'intera nazione: “Il terzo giorno, come fu mattino, cominciarono dei tuoni e dei lampi, apparve una folta nuvola sul monte e si udì un forte suono di tromba: e tutto il popolo che era nel campo tremò... Ora il monte Sinai era tutto fumante perché l'Eterno vi era disceso in mezzo al fuoco; e tutto il monte tremava forte. Il suono della tromba si andava facendo sempre più forte...” (19,16-19).
E fra i tuoni, i lampi, il suono dello Shofar e le fiamme di fuoco che avvolgevano la montagna fumante, una Voce solenne pronunciò quelle parole che da quel momento fino ai giorni nostri sono state la guida del comportamento per il genere umano.
Possiamo affermare che quella rivelazione fu il più notevole avvenimento nella storia dell'Umanità; fu il momento in cui nacque la “religione dello spirito” che era destinata nel tempo ad illuminare le anime, a dare un ordine alla vita di tutti gli esseri umani.
Il Decalogo, fondamento di tutte le religioni monoteistiche, è un sublime compendio dei doveri basilari che impegnano tutto il genere umano; un compendio rimasto ineguagliato per la concisione, per l'esposizione, per la vastità dei concetti, per la solennità del momento in cui vennero pronunciati.
Il Decalogo, ci insegna la Torà, fu consegnato a Mosè in due Tavole, le “Tavole del Patto”, o “Tavole della Testimonianza”, come sono designate nel testo biblico.
Nelle due Tavole, le “'Assereth ha-dibberoth”, qui riportate nei punti essenziali, secondo la tradizione ebraica sono suddivise nell'ordine seguente:
Prima Tavola:
1) Io sono il Signore Dio tuo che ti trasse dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù.
2) Non avrai altri dèi all'infuori di Me.
3) Non pronunciare il nome del Dio tuo invano.
4) Ricordati del giorno del sabato per santificarlo.
5) Onora tuo padre e tua madre.
Seconda Tavola:
6) Non uccidere.
7) Non commettere adulterio.
8) Non rubare.
9) Non testimoniare il falso riguardo al tuo prossimo.
10) Non desiderare la donna del tuo prossimo; non desiderare tutto ciò che appartiene al tuo prossimo.
Si noterà che, secondo questa suddivisione, nella prima Tavola sono elencati i Comandamenti che riguardano i doveri dell'uomo verso l'Eterno; nella seconda Tavola, invece, quelli che riguardano il suo comportamento verso il prossimo.
Il principio fondamentale dei Comandamenti della prima Tavola è quindi l'amore per l'Eterno: quell'amore che nello Shemà', la solenne dichiarazione di fede dell'Ebraismo, è espresso nella frase: “E amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue facoltà” (Deut. 6,5).
Il principio su cui si fondano i Comandamenti contenuti nella seconda Tavola è l'amore per il prossimo; principio sintetizzato con insuperabile chiarezza e concisione nel verso del Levitico (19,18): “E amerai il prossimo tuo come te stesso”, o, con una traduzione più fedele al testo ebraico: “Desidera per il tuo prossimo quello che desideri per te stesso”, o ancora: “Agisci per il bene del tuo prossimo come agiresti per il tuo stesso bene”.
Nelle due “Tavole del Patto” viene perciò messo in risalto che l'amore verso Dio e quello verso il prossimo sono due sentimenti che si completano a vicenda, come ricorda il Lattes citando quanto ha affermato Rabbì Avraham Yeoshua di Apta, grande maestro del Chassidismo dell'inizio del secolo scorso: “Le frasi `Ama l'Eterno tuo Dio' e `Ama il prossimo tuo', costituiscono senza dubbio due Comandamenti. In realtà, però, l'amore di Dio e l'amore degli uomini sono una cosa sola. Compito dello `tzaddik', del giusto, è appunto di fare effettivamente dell'amore di Dio e dell'amore degli uomini una cosa sola”.
Può lasciare perplessi il fatto che il Comandamento “Onora tuo padre e tua madre”, sia inserito nella prima Tavola benché a prima vista sembri un comando che riguarda esclusivamente i rapporti fra l'uomo e il suo prossimo; in realtà esso costituisce il collegamento tra il primo e il secondo gruppo di Comandamenti. I genitori sono infatti i creatori materiali dell'uomo, ma l'anima è divina; i genitori sono quindi i collaboratori dell'Eterno nella creazione di un nuovo essere: concetto espresso in modo chiaro nel Talmud: “Tre sono i collaboratori nella creazione dell'uomo: il Signore Benedetto, il padre e la madre. Perciò, quando un uomo onora e rispetta il padre e la madre, il Signore Benedetto dice: `Io lo considero degno di ricompensa come se avesse rispettato Me stesso!'“ (Talmud Babilonese, Kiddushin 30b).
L'osservanza del precetto “Onora tuo padre e tua madre” costituisce, in effetti, il punto di partenza per la preparazione e la comprensione del rispetto e del timore di Dio; sono i genitori che insegnano ai giovani a conoscere Dio; costituiscono così il primo anello della catena della tradizione, fondamento non solo della vita religiosa ma, nel suo significato più ampio, anche della vita della società.
Se si analizzano i precetti delle due Tavole secondo la loro collocazione, si troverà un significativo parallelismo fra tutti i precetti collocati al medesimo livello.
In particolare metteremo in rilievo il primo e l'ultimo precetto delle due Tavole: “Non uccidere” è parallelo a “Io sono il Signore tuo Dio”; chi uccide commette un gravissimo peccato verso il Signore che ha creato il “tuo prossimo” come ha creato “te”, a Sua immagine e somiglianza.
Come pure “Non desiderare la donna del tuo prossimo” in parallelo a “Onora tuo padre e tua madre” sottolinea l'importanza della santità della famiglia in ogni suo aspetto.
Soffermiamoci sui primi quattro comandamenti.
“Io sono il Signore tuo Dio”. Queste parole ordinano la conoscenza di Dio e si rivolgono quindi alla fede, allo spirito.
Anche il secondo Comandamento, “Non avrai altri dei all'infuori di Me”, rifiutando qualsiasi falsa credenza, riguarda la fede; e anch'esso si rivolge allo spirito dell'uomo, al suo sentimento.
I primi due Comandamenti riguardano, quindi, la concezione religiosa, ed esprimendo il medesimo principio, prima in forma affermativa e poi in forma negativa, si completano a vicenda. Essi costituiscono il modello di tutti i precetti che richiamano perentoriamente l'uomo all'amore di Dio, al timore di Dio, al riconoscimento dell'unità di Dio.
Il terzo Comandamento, “Non pronunciare il nome del Signore tuo Dio invano”, ci esorta non soltanto a non pronunciare con leggerezza, senza ragione, il nome dell'Eterno, ma anche ad evitare interpretazioni errate, blasfeme nell'uso del nome di Dio. Come sempre i nostri Maestri, partendo dal concetto semplice e basilare espresso dalla Torà, lo hanno poi allargato per renderlo eticamente sempre più valido aiuto ad una vita migliore.
Ne deriva che le dichiarazioni di “guerra santa” con relativi massacri, che le stragi compiute in nome di Dio divengono parole blasfeme! Come pure la “conversione forzata” dietro minaccia di morte e di torture!
Non è questo che Dio richiede da noi!
Il “non pronunciare il nome di Dio invano” ci invita a una approfondita riflessione sull'uso che siamo tenuti a fare della parola, dono prezioso che il Signore Benedetto ci ha concesso. Non soltanto dobbiamo usare la parola per esprimere concetti che siano di lode al Signore, ma dobbiamo usarla per educare al bene, per stimolare noi stessi e il prossimo ad agire per il bene, per il progresso dell'umanità, in special modo quello morale e spirituale.
Quanto danno è stato causato dalla parola usata per insegnare la prepotenza, la superiorità di razza, l'importanza della ricchezza, della conquista territoriale!
Il quarto comandamento, “Ricordati del giorno del sabato per santificarlo”, a prima vista sembra rivolgersi soltanto all'intelletto, al pensiero dell'uomo. Ma la frase che segue immediatamente, “non farai in esso alcuna opera, perché in sei giorni l'Eterno fece il cielo e la terra e il settimo si riposò”, sottolinea il dovere che incombe su di noi di astenerci in questo giorno da ogni opera creativa per dedicarci a Dio non distratti da qualsiasi preoccupazione materiale.
Esso costituisce il modello di tutti i precetti con l'osservanza dei quali, adempiendo al nostro dovere verso il Signore, santifichiamo la nostra vita; precetti che si osservano sia eseguendo alcune azioni sia astenendosi da altre.
In altre parole i primi due Comandamenti riguardano il pensiero dell'uomo, il terzo la parola, il quarto l'azione.
Il quinto Comandamento, come abbiamo già notato, costituisce il passaggio dalla prima alla seconda Tavola.
Molto istruttivo è l'ordine con il quale i Comandamenti sono stati elencati nella seconda “Tavola del Patto”.
A differenza della prima Tavola, nella seconda troviamo all'inizio quelli che sottolineano l'importanza dell'azione concreta, vietando quelle azioni che danneggiando materialmente il prossimo privandolo di ciò che gli appartiene: “Non uccidere; non rubare” o moralmente: “Non commettere adulterio”, non possono che minare le fondamenta della società umana.
Segue il Comandamento che riguarda la favella: “Non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo”.
Soltanto alla fine, dopo i Comandamenti che riguardano l'azione e la favella, troviamo il Comandamento che si riferisce al pensiero: “Non desiderare la donna del tuo prossimo; non desiderare tutto ciò che appartiene al tuo prossimo”.
Si può avanzare l'ipotesi che l'Eterno abbia voluto richiamare la nostra attenzione sul fatto che, per quanto riguarda il nostro comportamento verso di Lui, il punto di partenza non può essere che la fede, il pensiero. Affermato questo principio fondamentale, indiscutibile, ci ammonisce che le nostre azioni verso il prossimo devono essere improntate alla giustizia e alla comprensione reciproca, tese a stabilire rapporti concreti di armonia e di concordia.
La Torà non si limita quindi ad emanare disposizioni che ci guidino nel comportamento a cui dobbiamo attenerci nei riguardi del prossimo, non si limita a imporci di non compiere alcuna azione indegna che possa colpire i nostri simili nella vita, nella famiglia, nella proprietà; la Torà esige che vi sia reciproco rispetto anche nel sentimento e nel pensiero.
È molto importante a questo proposito il fatto che il Decalogo si concluda proprio con il Comandamento “Non desiderare tutto ciò che appartiene al tuo prossimo!”. Si potrebbe obiettare: che danno può arrecare al prossimo il riconoscere che possiede una cosa bella, pregevole, desiderabile? Ebbene la Torà ci mette in guardia contro il rancore, contro la smania di possesso ad ogni costo e a qualsiasi prezzo, contro l'invidia verso chi ha quel che noi non possiamo permetterci: sentimenti che denotano un animo non integro in colui che li prova.
In quest'ultimo Comandamento, non meno che nel primo, si rivela la straordinaria rivoluzione operata con la promulgazione del Decalogo. Il primo Comandamento, che esige la conoscenza di un Dio unico, creatore di ogni essere, trova la sua logica conclusione nell'ultimo che ci ammonisce a rispettare il prossimo che è stato creato per volontà dell'Eterno, a Sua immagine e somiglianza!
© Elia Kopciowski, Invito alla lettura della Torà.
-

Sixara - Messaggi: 1764
- Iscritto il: dom nov 24, 2013 11:44 pm
-tura, -tor-, torah
-tura, -tor-, torah – (-tura, -tor- sofisi)
viewtopic.php?f=82&t=363
https://docs.google.com/file/d/0B_VoBnR ... NWVUk/edit

viewtopic.php?f=82&t=363
https://docs.google.com/file/d/0B_VoBnR ... NWVUk/edit

Prima l'uomo poi caso mai anche gli idoli e solo quelli che favoriscono la vita e non la morte; Dio invece è un'altra cosa sia dall'uomo che dai suoi idoli.
-

Berto - Site Admin
- Messaggi: 38319
- Iscritto il: ven nov 15, 2013 10:02 pm
Re: Ebraeixmo : Tzélem Elohim
Sixara ha scritto:“Le frasi `Ama l'Eterno tuo Dio' e `Ama il prossimo tuo', costituiscono senza dubbio due Comandamenti. In realtà, però, l'amore di Dio e l'amore degli uomini sono una cosa sola. Compito dello `tzaddik', del giusto, è appunto di fare effettivamente dell'amore di Dio e dell'amore degli uomini una cosa sola”.
La someja de Dio:
Tzelem Elohìm
Il credere che ogni uomo sia tzélem Elohìm, o un'“immagine di Dio”, è l'affermazione morale più importante dell'ebraismo e la base di un'etica interpersonale universale. In un famoso dibattito talmudico, Rabbi Akiva sosteneva che “Ama il prossimo tuo come te stesso” (Lev. 19:18) è “la regola più importante della Scrittura”. Il suo collega Ben Azai rispondeva che “Questo è il libro delle generazioni di Adamo” è un insegnamento ancora più importante. Egli si riferiva a Genesi 5:1-2: “Questo è il libro delle generazioni di Adamo; nel giorno in cui Dio creò Adamo Egli lo creò ad immagine di Dio. Maschio e femmina li creò e li benedisse, dando loro il nome |P`Adamo|P' nel giorno in cui li creò”. Ben Azai avverte Akiva, il grande romantico, che l'amore non è una base sufficiente per la morale. Ci sono esseri umani che non si possono semplicemente amare, o momenti in cui l'amore appare così logorato che non si può far conto su di esso. Perfino in momenti come questi, egli sostiene, dobbiamo ricordarci che l'altro è immagine di Dio e trattarlo di conseguenza.
L'universalità dell'immagine divina ci porta alla norma etica del kevòd ha-beriòt, il rispetto per tutti gli individui. Ogni essere umano ha diritto a necessità fondamentali come il cibo, la casa, il lavoro, per mantenersi senza dipendere dalla generosità degli altri, e il rispetto. Fare in modo che tutto ciò sia condiviso da tutta l'umanità è dovere di tutti. Il credere che ogni persona è l'immagine di Dio ci porterà ad aborrire tutte le forme di degradazione umana, comprese la schiavitù, la prostituzione e la tossicodipendenza, condizioni in cui il senso della dignità umana si perde rapidamente. Il mio maestro Rabbi Abraham Joshua Heschel (z.l.) era solito dire che il motivo per cui ci è proibito di scolpire immagini di Dio è che noi stessi siamo immagini di Dio. Il punto fondamentale del secondo dei Dieci Comandamenti non è che Dio non ha immagine, ma piuttosto che per riprodurre un'immagine autentica di Dio dobbiamo usare il tramite della nostra vita intera. Niente di meno sarà sufficiente.
Ai nostri giorni rimangono ancora grandi problemi etici che non possono essere risolti semplicemente insistendo sulla verità dell'idea di tzélem Elohìm. Il credere che ogni vita è immagine di Dio ci porta forse ad un rifiuto totale dell'aborto? Non necessariamente, perché il nascituro deve entrare in una vita che lo tratterà come l'immagine di Dio. Ma l'individuo è “immagine di Dio” anche prima della nascita? La nostra fede nel concetto di tzèlem Elohìm cosa ci dice a proposito dell'eutanasia? La morte cerebrale significa la fine dell'immagine di Dio nell'individuo, o un essere che respira senza speranza di ritornare ad uno stato di coscienza è ancora l'immagine di Dio? L'affermazione etica di base non dà risposta a queste domande, ma fornisce tuttavia la giusta cornice ebraica per affrontarle.
-

Sixara - Messaggi: 1764
- Iscritto il: dom nov 24, 2013 11:44 pm
Re: Ebraeixmo : Tzaddiq
Tzaddìq
Lo tzaddìq o “giusto” ha, nell'ebraismo, quella funzione che in molte delle tradizioni religiose del mondo ha il “santo”, il maestro spirituale o lo sciamano. Ma lo tzaddìq viene così chiamato prima di tutto per gli atti di straordinaria generosità e altruismo compiuti all'interno della comunità umana. Tutto questo rispecchia il carattere particolare dell'ebraismo quale è stato foggiato dai profeti. Sebbene molti vedano questi tzaddiqìm come individui che compiono miracoli e rivelano una particolare santità, questa figura dell'ebraismo non è generalmente chiamata un ba`àl mofèt (“un operatore di miracoli”), o un qadòsh (“santo”), ma piuttosto uno tzaddìq. L'ebreo santo è così definito in base alla sua bontà piuttosto che per il suo intuito carismatico o i suoi speciali poteri.
L'esempio biblico, nella ricca letteratura ebraica riguardante la figura dello tzaddìq, è costituito dalle storie di Elia e di Eliseo (1 Re 17, 2 Re 9), utilizzate anche per le necessità creative del primo cristianesimo. Questi erano profeti che si confrontavano con re e regine, ma che si prendevano cura anche delle povere vedove e dei bambini affamati. Lo tzaddìq, come appare nel Talmùd e nel Midràsh, esercita una grande influenza nel tribunale celeste. Egli può annullare i decreti divini o perfino dettare a Dio ordini che devono essere eseguiti. Ma egli preferirebbe trovarsi nella piazza del mercato, facendo in modo che i poveri non vengano imbrogliati o che i bisognosi vengano aiutati in qualche modo.
Aspetto essenziale della figura dello tzaddìq è l'umiltà (`anavàh), e ciò significa un'avversione ad essere pubblicamente identificati come uno che compie buone azioni. Le prime storie ebraiche sugli tzaddiqìm riguardano spesso i nistarìm, i “nascosti”, figure di santi che vengono riconosciuti soltanto dalla delicata fragranza di bontà che lasciano come una scia dietro di loro. Nel Medioevo, gli ebrei giunsero a credere che ci fosse un numero stabilito di trentasei tzaddiqìm nascosti in ciascuna generazione, per merito dei quali il mondo continuava ad esistere.
Questo uso del termine tzaddìq per indicare un uomo straordinariamente santo non dovrebbe essere confuso con un altro significato, quello di “innocente”, nel significato legale di “non colpevole”. Questo uso divide il mondo tra tzaddiqìm e resha`ìm, gli “innocenti” e i “colpevoli” o “malvagi”. Ma non tutti coloro che sono liberi dal peccato sono in grado di compiere quelle grandi imprese che vengono portate a termine dai veri tzaddiqìm nascosti.
Lo tzaddìq non ricopre un ruolo importante nelle presentazioni formali dell'ebraismo, sia medievale che moderno. Né si trova una particolare menzione degli tzaddiqìm nell'halakhàh, dove passano praticamente sotto silenzio. Ma a livello della credenza popolare, gli ebrei furono profondamente ispirati dai racconti degli tzaddiqìm, li cercarono durante la loro vita e fecero pellegrinaggi sulle loro tombe. Ciò è vero in particolare per gli ebrei dell'Ucraina, del Marocco e della Terra Santa.
Il chassidismo segna un cambiamento molto importante nella storia dello tzaddìq e della sua funzione all'interno dell'ebraismo. Piuttosto che accettare il ruolo dei giusti nascosti, la rinascita populista del chassidismo cercò di trasformare lo tzaddìq in una figura pubblica. Si sostenne che soltanto un autentico tzaddìq poteva esser adatto come guida e modello per gli altri ebrei. Gli ebrei chassidici dell'Europa orientale giunsero ad organizzarsi in tribù di discepoli, seguaci dei loro rispettivi maestri. In molti casi questa supremazia tendeva a diventare dinastica. Ma, in tempi successivi, anche un rebbe chassidico non veniva definito come uno tzaddìq a meno che non gli si potesse attribuire qualche straordinaria impresa di bontà.
Ke odore ga-la la bontà? Par mi l è on odore de fiori d arancio ( o anca lavanda).
Lo tzaddìq o “giusto” ha, nell'ebraismo, quella funzione che in molte delle tradizioni religiose del mondo ha il “santo”, il maestro spirituale o lo sciamano. Ma lo tzaddìq viene così chiamato prima di tutto per gli atti di straordinaria generosità e altruismo compiuti all'interno della comunità umana. Tutto questo rispecchia il carattere particolare dell'ebraismo quale è stato foggiato dai profeti. Sebbene molti vedano questi tzaddiqìm come individui che compiono miracoli e rivelano una particolare santità, questa figura dell'ebraismo non è generalmente chiamata un ba`àl mofèt (“un operatore di miracoli”), o un qadòsh (“santo”), ma piuttosto uno tzaddìq. L'ebreo santo è così definito in base alla sua bontà piuttosto che per il suo intuito carismatico o i suoi speciali poteri.
L'esempio biblico, nella ricca letteratura ebraica riguardante la figura dello tzaddìq, è costituito dalle storie di Elia e di Eliseo (1 Re 17, 2 Re 9), utilizzate anche per le necessità creative del primo cristianesimo. Questi erano profeti che si confrontavano con re e regine, ma che si prendevano cura anche delle povere vedove e dei bambini affamati. Lo tzaddìq, come appare nel Talmùd e nel Midràsh, esercita una grande influenza nel tribunale celeste. Egli può annullare i decreti divini o perfino dettare a Dio ordini che devono essere eseguiti. Ma egli preferirebbe trovarsi nella piazza del mercato, facendo in modo che i poveri non vengano imbrogliati o che i bisognosi vengano aiutati in qualche modo.
Aspetto essenziale della figura dello tzaddìq è l'umiltà (`anavàh), e ciò significa un'avversione ad essere pubblicamente identificati come uno che compie buone azioni. Le prime storie ebraiche sugli tzaddiqìm riguardano spesso i nistarìm, i “nascosti”, figure di santi che vengono riconosciuti soltanto dalla delicata fragranza di bontà che lasciano come una scia dietro di loro. Nel Medioevo, gli ebrei giunsero a credere che ci fosse un numero stabilito di trentasei tzaddiqìm nascosti in ciascuna generazione, per merito dei quali il mondo continuava ad esistere.
Questo uso del termine tzaddìq per indicare un uomo straordinariamente santo non dovrebbe essere confuso con un altro significato, quello di “innocente”, nel significato legale di “non colpevole”. Questo uso divide il mondo tra tzaddiqìm e resha`ìm, gli “innocenti” e i “colpevoli” o “malvagi”. Ma non tutti coloro che sono liberi dal peccato sono in grado di compiere quelle grandi imprese che vengono portate a termine dai veri tzaddiqìm nascosti.
Lo tzaddìq non ricopre un ruolo importante nelle presentazioni formali dell'ebraismo, sia medievale che moderno. Né si trova una particolare menzione degli tzaddiqìm nell'halakhàh, dove passano praticamente sotto silenzio. Ma a livello della credenza popolare, gli ebrei furono profondamente ispirati dai racconti degli tzaddiqìm, li cercarono durante la loro vita e fecero pellegrinaggi sulle loro tombe. Ciò è vero in particolare per gli ebrei dell'Ucraina, del Marocco e della Terra Santa.
Il chassidismo segna un cambiamento molto importante nella storia dello tzaddìq e della sua funzione all'interno dell'ebraismo. Piuttosto che accettare il ruolo dei giusti nascosti, la rinascita populista del chassidismo cercò di trasformare lo tzaddìq in una figura pubblica. Si sostenne che soltanto un autentico tzaddìq poteva esser adatto come guida e modello per gli altri ebrei. Gli ebrei chassidici dell'Europa orientale giunsero ad organizzarsi in tribù di discepoli, seguaci dei loro rispettivi maestri. In molti casi questa supremazia tendeva a diventare dinastica. Ma, in tempi successivi, anche un rebbe chassidico non veniva definito come uno tzaddìq a meno che non gli si potesse attribuire qualche straordinaria impresa di bontà.
Ke odore ga-la la bontà? Par mi l è on odore de fiori d arancio ( o anca lavanda).
-

Sixara - Messaggi: 1764
- Iscritto il: dom nov 24, 2013 11:44 pm
Re: Ebraeixmo : Tzedaqàh
Tzedaqàh
La tzedaqàh o “rettitudine” è considerata dai profeti d'Israele come uno dei valori più alti della vita religiosa. È spesso collegata alla parola mishpàt o “giustizia”. Altre parole che sono in relazione con essa sono onestà, perfezione, lealtà. È il sentiero intrapreso dagli tzaddiqìm e da coloro che cercano di emulare il loro esempio.
Nei libri profetici è difficile distinguere tra tzédeq, la forma parallela maschile del sostantivo, e tzedaqàh. Entrambe le parole sembrano avere la stessa gamma di significati. Ma nell'uso più tardo dell'ebraico la forma femminile tzedaqàh finì per essere collegata con la virtù di una giusta generosità, un modo di migliorare l'equilibrio del mondo, in particolar modo dando a coloro che hanno troppo poco.
La tzedaqàh si può fare sia con la propria persona, mettendosi a disposizione di coloro che hanno necessità, sia con i propri averi, dando ai bisognosi parte dei propri beni materiali. Il fatto che la tzedaqàh venga ad essere spesso collegata esclusivamente con il secondo aspetto non dovrebbe far dimenticare il suo significato originario più ampio. Perché la tzedaqàh è molto più che un impegno finanziario, e l'obbligo di praticarla riguarda tutti, anche i più poveri.
I destinatari della tzedaqàh, coloro che dipendono dalla generosità degli altri, sono una categoria molto vasta. Essa include sicuramente i poveri, i senza casa e chi non è in grado di provvedere al proprio sostentamento. La tzedaqàh, un tempo, comprendeva la sfera dei “bisogni o servizi sociali” che sono oggi nelle mani (con risultati diversi di efficienza) delle varie istituzioni statali. Ma i “bisognosi”, che ricevono la tzedaqàh sono oggi anche coloro che sono “affamati” dal punto di vista dell'istruzione, dei sentimenti e dello spirito e non soltanto quelli che hanno letteralmente fame. Se la tzedaqàh non deve mai trascurare le necessità dei poveri, essa è giunta anche a includere il sostegno a quelle istituzioni che favoriscono l'istruzione, i servizi sociali e le risposte a molte altre necessità umane.
L'essere considerato come un ba`àl tzedaqàh (un “maestro di rettitudine”) o un “donatore”, in una comunità ebraica, può mettere talvolta in una posizione difficile. Ci sono centinaia di cause, moltissime degne di nota, e tutte sembrano “perseguitare” i medesimi donatori. Dividere la nostra disponibilità di dare fra tutti i numerosi casi che ci vengono proposti può trasformare ogni singola offerta in qualcosa di troppo esiguo per avere importanza, mentre dare ad uno e ignorare tutti gli altri sembra quasi crudele. È per questo motivo, per evitare un'eccessiva competizione fra le varie cause, che vennero create le associazioni ebraiche di beneficenza. L'associazione locale riceve l'offerta e la divide tra le varie necessità locali e mondiali. Esistono molte associazioni più piccole che fanno la stessa cosa, talvolta finalizzate a qualcosa di particolarmente interessante.
El tzédeq l è mas-cio, la Tzedaqàh l è femena. A ga da èsarghe na coalke difarenza.. ga da verghe ke fare co la madrexia.
La tzedaqàh o “rettitudine” è considerata dai profeti d'Israele come uno dei valori più alti della vita religiosa. È spesso collegata alla parola mishpàt o “giustizia”. Altre parole che sono in relazione con essa sono onestà, perfezione, lealtà. È il sentiero intrapreso dagli tzaddiqìm e da coloro che cercano di emulare il loro esempio.
Nei libri profetici è difficile distinguere tra tzédeq, la forma parallela maschile del sostantivo, e tzedaqàh. Entrambe le parole sembrano avere la stessa gamma di significati. Ma nell'uso più tardo dell'ebraico la forma femminile tzedaqàh finì per essere collegata con la virtù di una giusta generosità, un modo di migliorare l'equilibrio del mondo, in particolar modo dando a coloro che hanno troppo poco.
La tzedaqàh si può fare sia con la propria persona, mettendosi a disposizione di coloro che hanno necessità, sia con i propri averi, dando ai bisognosi parte dei propri beni materiali. Il fatto che la tzedaqàh venga ad essere spesso collegata esclusivamente con il secondo aspetto non dovrebbe far dimenticare il suo significato originario più ampio. Perché la tzedaqàh è molto più che un impegno finanziario, e l'obbligo di praticarla riguarda tutti, anche i più poveri.
I destinatari della tzedaqàh, coloro che dipendono dalla generosità degli altri, sono una categoria molto vasta. Essa include sicuramente i poveri, i senza casa e chi non è in grado di provvedere al proprio sostentamento. La tzedaqàh, un tempo, comprendeva la sfera dei “bisogni o servizi sociali” che sono oggi nelle mani (con risultati diversi di efficienza) delle varie istituzioni statali. Ma i “bisognosi”, che ricevono la tzedaqàh sono oggi anche coloro che sono “affamati” dal punto di vista dell'istruzione, dei sentimenti e dello spirito e non soltanto quelli che hanno letteralmente fame. Se la tzedaqàh non deve mai trascurare le necessità dei poveri, essa è giunta anche a includere il sostegno a quelle istituzioni che favoriscono l'istruzione, i servizi sociali e le risposte a molte altre necessità umane.
L'essere considerato come un ba`àl tzedaqàh (un “maestro di rettitudine”) o un “donatore”, in una comunità ebraica, può mettere talvolta in una posizione difficile. Ci sono centinaia di cause, moltissime degne di nota, e tutte sembrano “perseguitare” i medesimi donatori. Dividere la nostra disponibilità di dare fra tutti i numerosi casi che ci vengono proposti può trasformare ogni singola offerta in qualcosa di troppo esiguo per avere importanza, mentre dare ad uno e ignorare tutti gli altri sembra quasi crudele. È per questo motivo, per evitare un'eccessiva competizione fra le varie cause, che vennero create le associazioni ebraiche di beneficenza. L'associazione locale riceve l'offerta e la divide tra le varie necessità locali e mondiali. Esistono molte associazioni più piccole che fanno la stessa cosa, talvolta finalizzate a qualcosa di particolarmente interessante.
El tzédeq l è mas-cio, la Tzedaqàh l è femena. A ga da èsarghe na coalke difarenza.. ga da verghe ke fare co la madrexia.
-

Sixara - Messaggi: 1764
- Iscritto il: dom nov 24, 2013 11:44 pm
Chi c’è in linea
Visitano il forum: Nessuno e 15 ospiti
